L'antica Citta De Veii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Aqua Traiana / Aqua Paola and Their Effects on The
THE AQUA TRAIANA / AQUA PAOLA AND THEIR EFFECTS ON THE URBAN FABRIC OF ROME Carolyn A. Mess A Thesis Presented to the Faculty of the Department of Architectural History In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Architectural History May 2014 Cammy Brothers __________________ Sheila Crane __________________ John Dobbins __________________ ii ABSTRACT Infrastructure has always played an important role in urban planning, though the focus of urban form is often the road system and the water system is only secondary. This is a misconception as often times the hydraulic infrastructure determined where roads were placed. Architectural structures were built where easily accessible potable water was found. People established towns and cities around water, like coasts, riverbanks, and natural springs. This study isolates two aqueducts, the Aqua Traiana and its Renaissance counterpart, the Aqua Paola. Both of these aqueducts were exceptional feats of engineering in their planning, building techniques, and functionality; however, by the end of their construction, they symbolized more than their outward utilitarian architecture. Within their given time periods, these aqueducts impacted an entire region of Rome that had twice been cut off from the rest of the city because of its lack of a water supply and its remote location across the Tiber. The Aqua Traiana and Aqua Paola completely transformed this area by improving residents’ hygiene, building up an industrial district, and beautifying the area of Trastevere. This study -
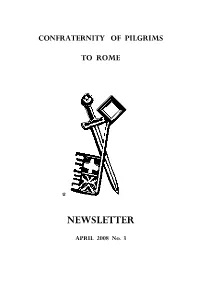
April Newsletter Issue 3
CONFRATERNITY OF PILGRIMS TO ROME * NEWSLETTER APRIL 2008 No. 3 Contents 1 Editorial Alison Raju Chris George 2 “A Pilgrim’s Tale” in the footsteps of Sigeric, Archbishop of Canterbury Veronica O’Connor 10 The Seven Pilgrim Churches of Rome Almis Simans 18 Who was St. Maurice? Janet Skinner 20 Medieval Itineraries to Rome Peter Robins 28 Rome for the modern pilgrim: traces of Peter and Paul Howard Nelson 36 Michael Alberto Alberti 38 Reviews William Marques Alison Raju 42 Additions to the CPR Library Howard Nelson 45 Secretary's Notebook Confraternity of Pilgrims to Rome Founded November 2006 www.pilgrimstorome.org Chairman William Marques [email protected] Webmaster Ann Milner [email protected] Treasurer Alison Payne [email protected] Newsletter Alison Raju [email protected] Chris George [email protected] Secretary Bronwen Marques bronwyn.marques2hertscc.gov.uk Company Secretary Ian Brodrick [email protected] AIVF Liason Joe Patterson [email protected] Editorial This is the third issue of the Confraternity of Pilgrims to Rome's Newsletter. We started on a modest scale to begin with - two issues a year, June and December, in 2007 - but in 2008 we plan three: April, August and December. Eventually we hope to make it a quarterly publication. There are six articles, four book reviews, a listing of new additions to the CPR library and the section entitled “Secretary's Notebook,” containing short items of information likely to be of interest to our members. Veronica O’Connor has written an account of her experiences on her pilgrimage from Canterbury to Rome in 2002, after which Almis Simans tells us about the Seven Pilgrim Churches in Rome. -
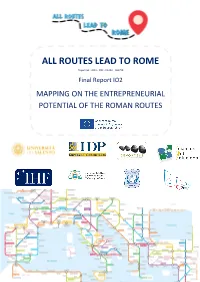
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -

Baixa Descarrega El
Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology - 02 © Material editorial i organització / Editorial material and organization: Universitat de Girona, Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic © Continguts i figures / Content and figures: els autors / the authors Equip editorial, objectius de la revista i instruccions per als autors i política editorial / Editorial team, magazine objectives and instructions for authors and editorial policy: www.documentauniversitaria.media/rodis Contacte / Contact: Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic [email protected] Universitat de Girona Plaça Ferrater Mora, 1 17071 Girona Tel. 972 45 82 90 ISSN: 2604-6679 ÍNDEX / INDEX Presentació Presentation 7 Josep Burch DOSSIER INFRAESTRUCTURES PORTUÀRIES D’ÈPOCA MEDIEVAL I MODERNA A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL MEDIEVAL AND MODERN HARBOUR INFRASTRUCTURES IN THE WESTERN MEDITERRANEAN La Torre de la Trinitat i la pesca de la tonyina (Roses, 1350-1550) Trinity Tower and tuna fishing (Roses, 1350-1550) 11 Marcel Pujol i Hamelink Els ports de Barcelona, Sant Feliu de Guíxols i Roses a la baixa edat mitjana: una comparativa The harbours of Barcelona, Sant Feliu de Guíxols and Roses in the late middle ages: a comparison 21 Marcel Pujol i Hamelink Strutture portuali, architetture e forme urbane medievali tra XI e XIV secolo. Lo spazio tirrenico toscano, la Sardegna, le isole Port structures, architecture and medieval urban forms between the 11th and 14th centuries. The tyrrhenian tuscan space, Sardinia, the islands 57 Marco Cadinu Evolució del front marítim de la zona portuària de Barcelona de la tardoantiguitat a l’edat moderna Evolution of the seafront of the port area of Barcelona from the late antiquity to the modern age 89 Santiago Riera Mora, Ramon Julià Brugués, Carme Miró Alaix VARIA Building in the city. -

Functional Interpretation of Villa Madama
JOHN SHEARMAN FUNCTIONAL INTERPRETATION OF VILLA MADAMA Within the last fifteen years our knowledge of Villa things matter above all: Sperulo’s unambiguous attribu Madama has improved quite unexpectedly1. The text of a tion of the villa to Raphael, and the fact that the descrip lost letter describing the villa, of which Castiglione had a tion which follows is quite clearly based upon the letter. copy and Raphael’s cousin Don Girolamo another, has Further new material has been published by Christoph been published by Philip Foster2. The interpretation of Frommel, particularly two unknown drawings and docu this remarkable document has scarcely begun; its Plinian ments which make it clear that building had begun by the form does not disguise Raphael’s reading of other end of 15184. sources, and perhaps the evidence it provides for his cul Since we are now so much better informed factually it tural expansion in Rome may prove in the long run as seems an appropriate time to stand back and ask more important as what it tells us about the villa. The letter, comprehensive and more awkward questions. How did however, is unsigned and undated in the form in which Villa Madama come about, and why was it built on this we now have it. It may be given a terminus ante quem, particular site and in such exceptional form? As we move and its attribution (which must also be that of the villa) into another phase of the study of the villa have we over may be confirmed, by reference to an unattractive poem simplified the problems, hitherto, in the usual -

Print This Article
Journal of Ancient Egyptian Interconnections ORVIETO AND THE WATERWAYS NETWORK Claudio Bizzarri Fondazione per il Museo C. Faina ABSTRACT In antiquity “road networks” of various kinds played an essential role in defining the territory and determining where settlements and production villas and farms were to be located. This study deals in particular with the waterways in Umbria, involving rivers such as the Tiber, the Paglia and the Chiani, which were all navigable at the time, and how present place names provide an insight into how these waterways were exploited. Corroborated by archaeological finds, descriptions from ancient authors also provide a lively picture of what these villas were like. PREFACE 1 the use of a haulage system, where a system of locks 5 Two distinct methods of analysis can be used in an attempt permitted the exploitation of rivers with a minimum to understand the phenomenon connected to the creation discharge. In Roman times precise laws regulated river and exploitation of a communication and transportation traffic insofar as the flumen (a waterway with a permanent network: physical and chronological. The current flow as distinguished from the rivus and which existed connotation of the term “road network” refers to a even in exceptional periods of drought) vitally enabled complex system dependent in turn on the manner in free circulation. Drawing water from the river was which it is exploited (by rail, wheels, etc.). It might prohibited so as not to interfere with navigation and the therefore be more correct to think of an ancient system as banks were also safeguarded, making access availble to a network of connectivity, that changes, is updated, all. -

1. La Via Cassia-Francigena E L'alto Lazio Xviii
Carlo Bordini Fabrizio Dal Passo Pamela Ferri 1 SOMMARIO INTRODUZIONE LA VIA CASSIA: STORIA, DESCRIZIONI E PERCORSI. 1. La via Cassia a Roma 2. Monte Mario 3. Acquatraversa, Tomba di Nerone e l’Ospedaletto Marziale 4. La via Trionfale e la Giustiniana 5. Torre Spizzichino e La Storta 6. La via Clodia, Isola Farnese, Veio e l’Osteria del Fosso 7. Le Osterie di Pisciacavallo, di Torre del Bosco, della Merluzza e dell’Ellera. La posta del Baccano 8. Settevene e Monterosi 9. Sutri, Capranica 10. Vetralla, Santa Maria di Forcassi 11. Dal Campo di Risieri al Bullicame 12. Dai Monti Cimini a Viterbo 13. Viterbo, Montefiascone e Bolsena 14. S. Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Ponte Centino LE STRUTTURE D’ASSISTENZA A ROMA E LUNGO LA VIA CASSIA: LOCANDE, OSTERIE, OSPIZI, STAZIONI DI POSTA E LUOGHI DI CULTO. 1. Introduzione 2. I poveri negli Anni Santi 3. Conventi e alberghi 4. Gli stranieri in visita a Roma ELENCO DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA LUNGO LA VIA CASSIA ELENCO DELLE PRINCIPALI CHIESE LUNGO LA VIA CASSIA CONFRATERNITE “RIATTAMENTI” E VIABILITA’ DELLA VIA CASSIA A PARTIRE DAL GIUBILEO DEL 1750 1. Ispezioni e progetti sulla via Cassia a partire dal 1749 2. L’assistenza sanitaria a Roma lungo la via Cassia nei Giubilei attraverso le fonti archivistiche BIBLIOGRAFIA 1. Fonti letterarie 2. Bibliografia su Roma 3. Bibliografia sui viaggiatori 4. Bibliografia su ospedali 5. Fonti su ospedali 6. Bibliografia sulla via Cassia 7. Opere di interesse generale FONDI CONSULTATI 2 APPENDICE DOCUMENTI DI INTERESSE PARTICOLARE Archivio di stato di Roma: fondo Buon Governo, serie II, busta n. -

RODAN Sintesi Delle Strade Romane
RODAN Sintesi delle Strade Romane Questa sintesi, meglio descritta altrove, vuole essere uno sprone per molti Cultori di Storia Locale che, ciascuno per il suo paese o città, possa portare avanti questo tipo di indagini, per farle confluire in Questo Sito, punto di convegno degli appassionati archeologi, dove si potrà costituire un Forum di confronto, discussione e messa a punto dei dati, per completare sempre più, una mappa geografico-storica-archeologica dell‘Italia. Io sono troppo vecchio per continuare questo lavoro, perciò spero di suscitare interesse perché lo facciano altri. Si dice che —nisciuno è nato imparato“, non bisogna preoccuparsi del dire solo cose certe, perché di esse non ce ne saranno mai, servono dati ed idee da porre a confronto con altre persone ed altri dati, perché è questo che porterà al compimento di documentazioni di valore, come servono all‘ampliamento della Conoscenza. STRADE RADIALI DI ROMA NOME STRADA ASSE VIARIO COSTRUTTORE COSTRUZIONE UTILIZZO KM NOTE L‘antica Roma dei sette re, 753-609 a.C. ebbe brevi strade suburbane a disposizione radiale: Campana poi Portuense, RomaœPortus, Imp.Claudio I d.C, 28 km. sponda destra Tevere Macarrese poi inizio Aurelia fino a Fregene, 241 a.C., 25 km Boccea poi via Cornelia, 200 a.C., per Boccea, fiume Arrone, 20 km Veientana poi via Trionfale, Roma œ Veio etrusca VIII sec. a., poi romana 392 a.C., 20 km Braccianese poi Clodia 310 a.C. per Lago Bracciano (l‘antica a Tarquinia) Cimina poi Cassia 171 a.C. per Veio e monti Cimini, fu l‘antica Dorsale Etrusca Amerina poi sostituita da Flaminia 220 a.C., per Amelia 132 km Feronia poi Tiberina VIII sec.a.C. -

Renovatio Urbis
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Lincoln Institutional Repository renovatio urbis Architecture, Urbanism and Ceremony in the Rome of Julius II Nicholas Temple 1 Agli amici di Antognano, Roma (Accademia Britannica) e Lincoln 2 Contents Illustration Credits Acknowledgements Introduction Chapter 1 - SIGN-POSTING PETER AND PAUL The Tiber’s Sacred Banks Peripheral Centres “inter duas metas” Papal Rivalries Chigi Chapel Chapter 2 - VIA GIULIA & PAPAL CORPORATISM The Politics of Order The Julian ‘Lapide’ Via Giulia The Legacy of Sixtus IV Quartière dei Banchi Via del Pellegrino, via Papale and via Recta Solenne Possesso and via Triumphalis Papal Corporatism Pons Neronianus and Porta Triumphalis Early Christian Precedents 3 Meta-Romuli and Serlio’s Scena Tragica Crossing Thresholds: Peter and Caesar The Papal ‘Hieroglyph’ and the Festa di Agone Chapter 3 - PALAZZO DEI TRIBUNALI and the Meaning of Justice sedes Iustitiae The Four Tribunals The Capitol and Communal/Cardinal’s Palace St Blaise and Justice Iustitia Cosmica Caesar and Iustitia pax Romana Chapter 4 – CORTILE DEL BELVEDERE, VIA DELLA LUNGARA and vita contemplativa “The Beautiful View” via suburbana/via sanctus Passage and Salvation Chapter 5 - ST. PETER’S BASILICA Orientation and Succession Transformations from Old to New Territorium Triumphale Sixtus IV and the Cappella del Coro Julius II and Caesar’s Ashes Janus and Peter 4 Janus Quadrifrons The Tegurium Chapter 6 - THE STANZA DELLA SEGNATURA A Testimony to a Golden Age Topographical and Geographical Connections in facultatibus Triune Symbolism Conversio St Bonaventure and the Itinerarium Mentis in Deum Justice and Poetry Mapping the Golden Age Conclusion - pons/facio: POPES AND BRIDGES The Julian ‘Project’ Pontifex Maximus Corpus Mysticum Raphael’s Portrait Notes Bibliography Index 5 Illustration Credits The author and publishers gratefully acknowledge the following for permission to reproduce images in the book. -

97 IV Co Cpp Cod 30 TRIBUNALE CORTE APPELLO
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma TRIBUNALE ORDINARIO - CORTE APPELLO E ASSISE D'APPELLO Turni dei difensori di ufficio art. 97 IV co. c.p.p. 1° trimestre 2006 2 gennaio 2006 Aula 1 AVV. SCODANIBBIO PAOLO VIA DELLA BALDUINA, 187 ROMA Aula 2 Aula 3 AVV. SCOGNAMIGLIO EUGENIA VIA DELLA CROCE, 44 ROMA Aula 4 Aula 5 AVV. SCOGNAMIGLIO FEDERICO VIA DELLA GIULIANA, 32 ROMA Aula 6 Aula 7 AVV. SCOPELLITI IRINA VIA AUGUSTO AUBRY, 3 ROMA Aula 8 Aula 9 AVV. SCORSONE MIRKO VIA ANGELO EMO, 106 ROMA Aula 10 Aula 11 AVV. SCROCCA GIULIANA VIALE G. MAZZINI, 134 ROMA Aula 12 Aula 13 AVV. SCUZZARELLA LUCA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 52 ROMA Aula 14 Aula 15 AVV. SEBASTIANI MARCO VIA BELSIANA, 71 ROMA Aula 16 Aula 17 AVV. SEGA LIVIA VIA VIRGINIO ORSINI, 19 ROMA Aula 18 Aula 19 AVV. SEMPRONI LUCA VIA UMBERTO MORICCA, 5 ROMA Aula 20 Aula 21 AVV. SENISE FRANCESCO VIA PANNONIA, 51 ROMA Aula 22 Aula 23 AVV. SERAFINI CLAUDIA VIA NIOBE, 13 ROMA Aula 24 Aula 25 AVV. SERRA CARLA VIA OTTAVIANO, 9 ROMA Aula 26 AVV. SEVERI ISABELLA VIA DEL CASALE DEGLI STROZZI,31 ROMA Aula 27 Sez. I colleg. AVV. SFORZA RICCARDO VIA COLLINA, 24 ROMA Sez. II colleg. Sez. IV colleg. AVV. SGRO' DANIELA VIA CHIANA, 97 ROMA Sez. V colleg. Sez. VI colleg. AVV. SICA PIER FRANCESCO PIAZZALE CLODIO, 22 ROMA Sez. VII colleg. Sez. VIII colleg. AVV. SIGNORETTI ANTONIO VIA A. CARONCINI, 4 ROMA Sez. IX colleg. AVV. SILECCHIA DOMENICA VIA FABIO MASSIMO, 57 ROMA Sez. -

Hospitals in Rome
ENGLISH SPEAKING DOCTORS AND MEDICAL FACILITIES – CONSULAR DISTRICT OF ROME Disclaimer: The Consular Section of the U.S. Embassy in Rome, Italy has prepared the following listings of hospitals, doctors, ambulances, laboratories and pharmacies as a service to U.S. citizens. However, the Consular Section assumes no responsibility for the professional ability or reputation of the persons or medical facilities whose names appear on the lists. Inclusion on these lists is in no way an endorsement by the Department of State or the U.S. Embassy. Names are listed alphabetically and the order in which they appear has no other significance. The information in the list on professional credentials and areas of expertise are provided directly by the medical professional, medical facility or ambulance service; the Embassy is not in a position to vouch for such information. You may receive additional information about the individuals by contacting the local medical boards and associations or the local licensing authorities. • Public Hospitals in Rome • Private Hospitals in Rome • List of Doctors in Rome • Other Public Hospitals within the Consular District of Rome • Ambulance services in Rome • Laboratories in Rome • Pharmacies & Opticians in Rome PUBLIC HOSPITALS IN ROME PLEASE NOTE: The following color code has been created to facilitate locating public hospitals in the city of Rome. COLOR CODE: Black = Center (for example, Vatican, U.S. Embassy, Piazza del Popolo, Colosseum, Pantheon, Termini Train Station), Blue = West (for example, Fiumicino Airport, -

Quaderni Della Scuola Di Specializzazione in Archeologia
ALMA MATER STUDIORUM - U NIVERSITÀ DI BOLOGNA OCNUS Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia 14 2006 ESTRATTO Direttore Responsabile Giuseppe Sassatelli Comitato Scientifico Pier Luigi Dall’Aglio Sandro De Maria Fiorenzo Facchini Maria Cristina Genito Gualandi Sergio Pernigotti Giuseppe Sassatelli Coordinamento Maria Teresa Guaitoli Editore e abbonamenti Ante Quem soc. coop. Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bologna tel. e fax + 39 051 4211109 www.antequem.it Redazione Valentina Gabusi, Flavia Ippolito, Viviana Sanzone Traduzione degli abstracts Marco Podini Abbonamento 40,00 Richiesta di cambi Dipartimento di Archeologia Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna tel. +39 051 2097700; fax +39 051 2097701 Le sigle utilizzate per i titoli dei periodici sono quelle indicate nella «Archäologische Bibliografie» edita a cura del Deutsches Archäologisches Institut. Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6803 del 17.4.1988 Senza adeguata autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione della presente opera e di ogni sua parte, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. ISSN 1122-6315 ISBN 88-7849-019-9 © 2006 Ante Quem soc. coop. IndIce Prefazione di Giuseppe Sassatelli 9 ARTICOLI Viviana Ardesia Sulle dinamiche insediamentali della Valle del Pescara nell’Età del Bronzo (II millennio a.C.) 11 Giovanni Azzena Appunti per una rilettura dell’urbanistica di Atri romana 27 Julian Bogdani Le fortificazioni di età ellenistica di Çuka e Aitoit (Epiro) 43 Fausto Bosi Sul mito dell’Atlantide 61 Domenico Camardo Gli scavi ed i restauri di Amedeo Maiuri. Ercolano e l’esperimento di una città museo 69 Antonella Coralini, Daniela Scagliarini Corlàita, Riccardo Helg, Enrico Giorgi, Massimo Zanfini, Silvia Minghelli, Carolina Ascari Raccagni, Gilda Assenti Domus Herculanensis Rationes (DHER).