HP Lovecraft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Searchers After Horror Understanding H
Mats Nyholm Mats Nyholm Searchers After Horror Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction // Searchers After Horror Horror After Searchers // 2021 9 789517 659864 ISBN 978-951-765-986-4 Åbo Akademi University Press Tavastgatan 13, FI-20500 Åbo, Finland Tel. +358 (0)2 215 4793 E-mail: [email protected] Sales and distribution: Åbo Akademi University Library Domkyrkogatan 2–4, FI-20500 Åbo, Finland Tel. +358 (0)2 -215 4190 E-mail: [email protected] SEARCHERS AFTER HORROR Searchers After Horror Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction Mats Nyholm Åbo Akademis förlag | Åbo Akademi University Press Åbo, Finland, 2021 CIP Cataloguing in Publication Nyholm, Mats. Searchers after horror : understanding H. P. Lovecraft and his fiction / Mats Nyholm. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2021. Diss.: Åbo Akademi University. ISBN 978-951-765-986-4 ISBN 978-951-765-986-4 ISBN 978-951-765-987-1 (digital) Painosalama Oy Åbo 2021 Abstract The aim of this thesis is to investigate the life and work of H. P. Lovecraft in an attempt to understand his work by viewing it through the filter of his life. The approach is thus historical-biographical in nature, based in historical context and drawing on the entirety of Lovecraft’s non-fiction production in addition to his weird fiction, with the aim being to suggest some correctives to certain prevailing critical views on Lovecraft. These views include the “cosmic school” led by Joshi, the “racist school” inaugurated by Houellebecq, and the “pulp school” that tends to be dismissive of Lovecraft’s work on stylistic grounds, these being the most prevalent depictions of Lovecraft currently. -

Extraterrestrial Places in the Cthulhu Mythos
Extraterrestrial places in the Cthulhu Mythos 1.1 Abbith A planet that revolves around seven stars beyond Xoth. It is inhabited by metallic brains, wise with the ultimate se- crets of the universe. According to Friedrich von Junzt’s Unaussprechlichen Kulten, Nyarlathotep dwells or is im- prisoned on this world (though other legends differ in this regard). 1.2 Aldebaran Aldebaran is the star of the Great Old One Hastur. 1.3 Algol Double star mentioned by H.P. Lovecraft as sidereal The double star Algol. This infrared imagery comes from the place of a demonic shining entity made of light.[1] The CHARA array. same star is also described in other Mythos stories as a planetary system host (See Ymar). The following fictional celestial bodies figure promi- nently in the Cthulhu Mythos stories of H. P. Lovecraft and other writers. Many of these astronomical bodies 1.4 Arcturus have parallels in the real universe, but are often renamed in the mythos and given fictitious characteristics. In ad- Arcturus is the star from which came Zhar and his “twin” dition to the celestial places created by Lovecraft, the Lloigor. Also Nyogtha is related to this star. mythos draws from a number of other sources, includ- ing the works of August Derleth, Ramsey Campbell, Lin Carter, Brian Lumley, and Clark Ashton Smith. 2 B Overview: 2.1 Bel-Yarnak • Name. The name of the celestial body appears first. See Yarnak. • Description. A brief description follows. • References. Lastly, the stories in which the celes- 3 C tial body makes a significant appearance or other- wise receives important mention appear below the description. -

S67-00104-N218-1995-07 08.Pdf
Issue 1218, July/August 1995 IN THIS ISSUE: SFRA INTERNAL AFFAIRS: President's Message (Sanders) 3 Minutes of Meeting Between Members of SmA and IAFA at the Annual ICFA (Gordon) 3 Corrections/Additions 4 SmA Members & Friends 5 Editorial (Sisson) 5 NEWS AND INFORMATION 7 SPECIAL FEATURE: "The Worlds of David Lynch": Lavery, David (Ed). Full of Secrets: Critical Approaches to 7Win Peaks. (Davis) 11 Gifford, Barry. Hotel Room Trilogy; and Lynch, David. David Lynch's Hotel Room. (umland) 13 SPECIAL FEATURE: "Lovecraft the Man": Lovecraft, H.P. (S.T. Joshi, Ed). Miscellaneous Writings. (Anderson) 17 Squires, Richard D. Stern Fathers 'neath the Mould: The Lovecraft Family in Rochester. (Bousfield) 20 Barlow, Robert H. and H.P. Lovecraft (S.T. Joshi, Ed). The Hoard of the Wizard Beast and One Other; and Joshi, S.T. & David schultz (Eds). H.P. Lovecraft Letters 7b SaJIlJel Loveman & vincent Starrett (Kaveny) 21 REVIEWS: Nonfiction: Barron, Neil (Ed). Anato~ Of Wonder, 4th Edition. (Kaveny & Bogstad) 23 Heller, Steven and Seynour Chwast. Jackets Required: An Illustrated History of American Book Jacket Design, 1920-1950. (Barron) 27 Kessler, carol Farley. Charlotte Perkins Gilman: her progress toward utopia with selected writings. (Orth) 29 Korshak, Stephen D. (Ed). A Hannes Bok Showcase. (Albert) 34 McCarthy, Helen. AniIoo J : A Beginner's Guide to Japanese Animation. (Klossner) 35 SFRA Re\liew#218. July/August 1995 Scheick, william J. (Ed). The Critical Resp:Jnse to H.G •. ~lls. (Huntington) 36 Schlobin, Roger C. and Irene R. Harrison. Andre Norton: A primaIy and Secondary Bibliography (Bogstad) 38 silver, Alain and Janes Ursini. -

GEOLOGY THEME STUDY Page 1
NATIONAL HISTORIC LANDMARKS Dr. Harry A. Butowsky GEOLOGY THEME STUDY Page 1 Geology National Historic Landmark Theme Study (Draft 1990) Introduction by Dr. Harry A. Butowsky Historian, History Division National Park Service, Washington, DC The Geology National Historic Landmark Theme Study represents the second phase of the National Park Service's thematic study of the history of American science. Phase one of this study, Astronomy and Astrophysics: A National Historic Landmark Theme Study was completed in l989. Subsequent phases of the science theme study will include the disciplines of biology, chemistry, mathematics, physics and other related sciences. The Science Theme Study is being completed by the National Historic Landmarks Survey of the National Park Service in compliance with the requirements of the Historic Sites Act of l935. The Historic Sites Act established "a national policy to preserve for public use historic sites, buildings and objects of national significance for the inspiration and benefit of the American people." Under the terms of the Act, the service is required to survey, study, protect, preserve, maintain, or operate nationally significant historic buildings, sites & objects. The National Historic Landmarks Survey of the National Park Service is charged with the responsibility of identifying America's nationally significant historic property. The survey meets this obligation through a comprehensive process involving thematic study of the facets of American History. In recent years, the survey has completed National Historic Landmark theme studies on topics as diverse as the American space program, World War II in the Pacific, the US Constitution, recreation in the United States and architecture in the National Parks. -

Universidade Federal De Santa Catarina Pós
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS E LITERATURA CORRESPONDENTE WEIRD FICTION AND THE UNHOLY GLEE OF H. P. LOVECRAFT KÉZIA L’ENGLE DE FIGUEIREDO HEYE Dissertação Submetida à Universidade Federal de Santa Catarina em cumprimento dos requisitos para obtenção do grau de MESTRE EM LETRAS Florianópolis Fevereiro, 2003 My heart gave a sudden leap of unholy glee, and pounded against my ribs with demoniacal force as if to free itself from the confining walls of my frail frame. H. P. Lovecraft Acknowledgments: The elaboration of this thesis would not have been possible without the support and collaboration of my supervisor, Dra. Anelise Reich Courseil and the patience of my family and friends, who stood by me in the process of writing and revising the text. I am grateful to CAPES for the scholarship received. ABSTRACT WEIRD FICTION AND THE UNHOLY GLEE OF H. P. LOVECRAFT KÉZIA L’ENGLE DE FIGUEIREDO HEYE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2003 Supervisor: Dra. Anelise Reich Corseuil The objective of this thesis is to verify if the concept of weird fiction can be classified not only as a sub-genre of the horror literary genre, but if it constitutes a genre of its own. Along this study, I briefly present the theoretical background on genre theory, the horror genre, weird fiction, and a review of criticism on Lovecraft’s works. I also expose Lovecraft’s letters and ideas, expecting to show the working behind his aesthetic theory on weird fiction. The theoretical framework used in this thesis reflects some of the most relevant theories on genre study. -

Carnival Weekend Begins April 30
FBW, Games, Mixer, Prizes Carnival Weekend Begins April 30 By Dave Tietyen pus with males in garish and in containers in the first floor lob over a 25 foot patch of mud in grotesque costumes along with a way" will open to reveal a variety Fun, games, prizes, excitement, by of the Union. Proceeds are the 2nd annual Powder Puff tug- of booth designs and games. enjoyment, laughs await the spec parade of young ladies. donated to charities. of-war. Phi Sigma Epsilon will have a tators of the 16th annual Campus The Beauty and Beast contest Greased Pole Thursday evening, groups will Carnival weekend beginning returns the "ugly man en campus" The grunts and groans of the begin the construction of the castle 30 feet wide rising into the Thursday, April 30. to UWM. Along with Walt Disney greased pole contest will begin at "Midway" and transform the air above the entire carnival. Campus Carnival is the largest beauties, the "Beast" will reign 4 p.m. on Thursday. Sixty men fieldhouse into a replica of the Their game will include throwing event held on the campus of during three dc.ys of activity. will attempt to scale a 20 foot famed Disneyland. More than 150 circular objects at a mat-covered .UWM. Contestants will be competing heavily greased pole and capture students will be working to pre drawbridge. Beginning Thursday morning, for "votes" from the student body. the Playboy garter placed on top. sent to the campus an outstanding Alpha Omicron Pi sorority will April 30, students will be seen pa These "votes" are in the form of This will be followed with more carnival. -

1894. Congressional Record-Senate. 2829
1894. CONGRESSIONAL RECORD-SENATE. 2829 SENATE. of December 21, 1893, a report from the Commissioner of Indian Affairs, containing copies of papers bearing upon the Sioux MONDAY, March 12, 1894. mixed-blood question; which, with the accompanying papers, was, on motion of Mr. KYLE, raferred to the Committee on In Prayer by the Chaplain, Rev. W. H. MILBURN, D. D. dian Affairs, and ordered to be printed. The Journal of the proceedings of Friday last was read and ap proved. SENATOR FROM LOffiSIANA. MESSAGE FROM THE HOUSE. Mr. CAFFERY presented the credentials of Newton C. Blanch· A message from the House of Representatives, by Mr. T. 0. ard, appointed by the governor of Louisiana a Senator from that TOWLES, its Chief Clerk, announced that the House insisted State to fill, until the next meeting of the Legislature thereof, upon its amendment to the concurrent resolution of the Sen the vacancy caused by the resignation of Edward D. White in ate to print 6,000 copies of all papers and messages sent to Con the term ending March 3, 1897. gress by the President since January 1, 1893, relating to Ha The credentials were read, as follows: waiian affairs; agreed to the conference asked for by the Senate UNITED STATES OF AMERICA, State of Louisiana. on the disagreeing votes of the two Houses thereon, and had To Hon. ADLAI E. STEVENSON, appointed Mr. RICHARDSON of Tennessee, Mr. McKAIG, and President of the Senate of the Unitul States: Sm: This is to certify that on the 7th day of March, 18;!4, as governor of Mr. -
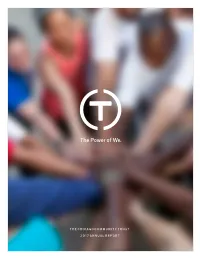
2017 Annual Report Table of Contents
The Power of We. THE CHICAGO COMMUNITY TRUST 2017 ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS In Appreciation: Terry Mazany . 2 Year in Review . 4 Our Stories: Philanthropy in Action . 8 In Memoriam . 20 Competitive Grants . 22 Grants from the Searle Funds at The Chicago Community Trust . 46 Searle Scholars . 47 Donor Advised Grants . 48 Designated Grants . 76 Matching Gifts . 77 Grants from Identity-Focused Funds . 78 Grants from Supporting Organizations . 80 Grants from Collaborative Funds . 84 Funds of The Chicago Community Trust and Affiliates . 87 Contributors to Funds at The Chicago Community Trust and Affiliates . 99 The 1915 Society . 108 Professional Advisory Committee and Young Professional Advisory Committee . 111 Financial Highlights . 112 Executive Committee . 116 Trustees Committee and Banks . 117 The Chicago Community Trust Staff . 118 Trust at a Glance . 122 The power to reach. The power to dream. The power to build, uplift and create. The power to move the immovable, to align our reality to the best of our ideals. That is the power of we. We know that change doesn’t happen in silos. From our beginning, The Chicago Community Trust has understood that more voices, more minds, more hearts are better than one. It is our collective actions, ideas and generosity that propel us forward together. We find strength in our differences, common ground in our unparalleled love for our region. We take courage knowing that any challenge we face, we face as one. We draw power from our shared purpose, power that renews and emboldens us on our journey – the world-changing power of we. Helene D. -

Midwest Historical & Genealogical Society Wichita, Kansas 1902 Wichita City Directory
Midwest Historical & Genealogical Society Wichita, Kansas 1902 Wichita City Directory Transcribed by Nancy Lou Welshimer Fincham A Abbott E, glazier r 238 s Mosley Abbott H T, laborer, r 1105 rm 1 e Douglas Abott John, packer, r 238 s Mosley Abbott John, carpenter r 1105 e Murdock Abbott M, harness maker r 536 s Emporia Abbott Thomas, Laborer, r 2237 n Main Abbott Thomas, gardener r 630 n Mead Abbott Will, switchman r 611 n Washington Abbott W J, teamster r 623 s Water Abercrombie H N, trav salesman r 1046 n Topeka Abernathy Ed, porter r 1140 n Mead Abernathy S, laborer r 1140 n Mead Able Mrs Florence, r 122 n Emporia Able Geo, poultry r 228 n Mead Able Jonas, chicken picker r 202 n Mead Able Mrs Mary, r 228 n Mead Abrian Mrs Lena widow r 1429 w Douglas Acken Mrs G A r 1145 n Topeka Acken Miss Mabel V stenographer r 1145 n Topeka Acuff C M tinner Steel Bros r 602 s Market Adams A, engineer r 329 n St Francis Adams Mrs Addie seamstress r 208 n Waco Adams & Adams, (JWA and GWA) lawyers 105-107 e Douglas Adams Austin J, lawyer Winne bldg r 425 n Topeka Adams Clarence D, carpenter r 1702 n Topeka Adams Mrs Cathrine, widow r 456 n St Francin Adams, Chester F, pres Wichita Business College r 730 n Lawrence Adams Dr C G, dentist 106 e Douglas r 1130 n Lawrence Adams Davis, retired r 900 s Water Adams Miss Ethel, teacher r 729 s Elizabeth Adams Mrs E L, widow, r 527 s Water Adams F, wks L C Jackson Coal Co r cor Decatur and Mosley Adams Mrs F S dressmaker rm 212 e Second Adams Miss Grace r 340 n Water Adams Geo W, Adams & Adams, r 327 n Lawrence -

Education Companion Guide
EDUCATION COMPANION GUIDE Sponsored by DEAR EDUCATORS AND PARENTS, Welcome to THE QUEST FOR SOLOMON’S TREASURE, a brand-new online treasure hunt with First Stage! Over the next seven exciting episodes, you will not only have the opportunity to watch the mystery unfold virtually, but to join along and solve the mystery yourself. This companion guide will help you keep track of your clues, learn about the history of Milwaukee, and provide you with activities and tips to make your treasure hunt fun and successful. Enclosed in this enrichment guide is a range of materials and activities intended to help you discover connections within the play through the curricula. It is our hope that you will use the experience of attending the theater and seeing THE QUEST FOR SOLOMON’S TREASURE with your students as a teaching tool. Use this guide to best serve your children — pick and choose, or adapt, any of these suggestions for discussions or activities. We encourage you to take advantage of the enclosed student worksheets—please feel free to photocopy the sheets for your students, or the entire guide for the benefit of other teachers. Enjoy the show! Julia Magnasco Education Director (414) 267-2971 [email protected] HOW TO BE AN EFFECTIVE DETECTIVE To help Frannie and her friends solve the mystery and discover Solomon Juneau’s treasure, you will need to do some sleuthing of your own. Here are some quick tips to get the most out of your online searches: 1. SEARCH SPECIFICALLY: Save yourself time by using the most specific words or combination of words possible when you search online. -
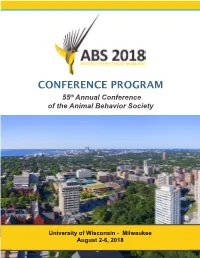
ABS-2018-Program.Pdf
CONFERENCE PROGRAM 55th Annual Conference of the Animal Behavior Society University of Wisconsin - Milwaukee August 2-6, 2018 2 ESCAPE THE CITY Discover the Natural World August 3-6, 2018 Show this ad or your conference badge to receive $5 OFF ADMISSION. MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM 800 West Wells Street, Milwaukee, WI 53233 ABS 2018 | AUGUST 2-6 414-278-2702 | www.mpm.edu 1 TABLE OF CONTENTS TABLE TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION 2 WELCOME LETTER 3 AWARDS 4 PLENARIES & FELLOW TALKS 5 SYMPOSIA 6 WORKSHOPS 8 EVENTS & MEETINGS 9 FILM FESTIVAL 10 ABS 2019 - SAVE THE DATE 11 PROGRAM SUMMARY 12 THURSDAY, AUGUST 2 14 FRIDAY, AUGUST 3 14 SATURDAY, AUGUST 4 18 SUNDAY, AUGUST 5 21 MONDAY, AUGUST 6 24 POSTER SESSIONS 26 TALK INDEX 32 SPONSORS & EXHIBITORS 36 CAMPUS MAP OUTSIDE BACK COVER ABS 2018 | AUGUST 2-6 UNIVERSITY OF WISCONSIN - MILWAUKEE 2 GENERAL INFORMATION DATES CAMPUS HOUSING CHECK-IN The 55th Annual Animal Behavior Society Conference begins Delegates who are staying on campus will proceed to the Sandburg Thursday, August 2nd and concludes Monday, August 6th, 2018. Hall (3400 N. Maryland Avenue, Milwaukee, WI 53201) or River View Residence Hall (2340 North Commerce Street, Milwaukee, REGISTRATION INFORMATION WI 53211 ) to check in. The Front Desk will be available 24 hrs The Registration Desk is located in the Student Union “Pangaea at both Residence Halls for check-in. Please note that there is a Mall” on Level 1, and will be open during the following hours: $25.00 lost key fee. Wednesday 6:00 pm - 8:00 pm PRE-ORDERED MEAL PLAN CARDS & PARKING Thursday- Sunday 7:30 am - 7:30 pm PASSES Monday 7:30 am - 2:00 pm Please note that your pre-purchased meal plan card and pre- purchased parking passes will be available for pick-up at University INSTRUCTIONS TO TALK PRESENTERS Housing check-in. -

THEUWM Friday, Mar
Why Extracurricular? Conservation Club Stresses Outdoors By Ron Lamboy information with those who want structive and money making, have Projects alone do not take all done. Girls do not do the cooking The man who can live without to learn about these areas. But been undertaken each semester. the time the members can devote on these outings. the wildness of nature should not the club is not so scientific as to The over-all project for the year to the club. There are other activi There is a hardening up process join the Aldo Leopold Conserva exclude those who just like to be is exploring Wisconsin. Five ties such as frequent outings to the that the softer members undergo. tion club, the third largest student out of doors. thousand miles have been logged Whitford farm in Marquette coun One girl who found a piece of The club has taken the name in this activity. Another project ty. Whitford has allocated his straw floating in her milk just organization on the campus. The of a late UW professor of wild included the burning of a prairie weathered barn as the club lodge. club has 130 student members and life management, who died in to preserve it from growth that fished it out and drank the milk. a large number of alumni. The 1949. Leopold was the founder of would change its milieu. The club Visit Farm Other discomforts are really minor phrase "on campus" means on today's conservation philosophy. selectively cut Christmas trees on Last Saturday morning, for ex in the overall Excitement of the campus for classes.