2000 Parte 1 Pp. 1-317
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
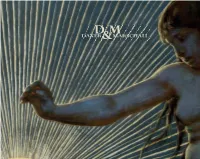
Daxer & Marschall 2015 XXII
Daxer & Marschall 2015 & Daxer Barer Strasse 44 - D-80799 Munich - Germany Tel. +49 89 28 06 40 - Fax +49 89 28 17 57 - Mobile +49 172 890 86 40 [email protected] - www.daxermarschall.com XXII _Daxer_2015_softcover.indd 1-5 11/02/15 09:08 Paintings and Oil Sketches _Daxer_2015_bw.indd 1 10/02/15 14:04 2 _Daxer_2015_bw.indd 2 10/02/15 14:04 Paintings and Oil Sketches, 1600 - 1920 Recent Acquisitions Catalogue XXII, 2015 Barer Strasse 44 I 80799 Munich I Germany Tel. +49 89 28 06 40 I Fax +49 89 28 17 57 I Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] I www.daxermarschall.com _Daxer_2015_bw.indd 3 10/02/15 14:04 _Daxer_2015_bw.indd 4 10/02/15 14:04 This catalogue, Paintings and Oil Sketches, Unser diesjähriger Katalog Paintings and Oil Sketches erreicht Sie appears in good time for TEFAF, ‘The pünktlich zur TEFAF, The European Fine Art Fair in Maastricht, European Fine Art Fair’ in Maastricht. TEFAF 12. - 22. März 2015, dem Kunstmarktereignis des Jahres. is the international art-market high point of the year. It runs from 12-22 March 2015. Das diesjährige Angebot ist breit gefächert, mit Werken aus dem 17. bis in das frühe 20. Jahrhundert. Der Katalog führt Ihnen The selection of artworks described in this einen Teil unserer Aktivitäten, quasi in einem repräsentativen catalogue is wide-ranging. It showcases many Querschnitt, vor Augen. Wir freuen uns deshalb auf alle Kunst- different schools and periods, and spans a freunde, die neugierig auf mehr sind, und uns im Internet oder lengthy period from the seventeenth century noch besser in der Galerie besuchen – bequem gelegen zwischen to the early years of the twentieth century. -

Premio Campiello
PREMI LETTERARI ITALIANI ACCREDITATI: PREMIO STREGA Dal 1947 sinonimo del più importante premio letterario italiano. È nato all’interno del salotto letterario di Goffredo e Maria Bellonci dove si riunivano i suoi frequentatori gli “Amici della domenica”. La famiglia Alberti, azienda produttrice del liquore Strega Ha da sempre sostenuto l’evento culturale. Nel comitato di premiazione oltre ai 400 amici della domenica ci sono 60 “lettori forti” segnalati dall’ALI (Associazione Librai Italiani). Per il 2016 l’assegnazione del premio avverrà giovedì 2 luglio. Intanto il 13 giugno è stato reso noto il vincitore del Premio Strega Giovani, eletto da una giuria di 500 rappresentanti di studenti delle scuole medie superiori, Dove troverete un altro padre come il mio (Ponte delle Grazie) di Rossana Campo. ULTIMI VINCITORI: 2015 La ferocia di NICOLA LAGIOIA (1973) Un noir ambientato nella Bari bene. Famiglie benestanti con misteri e trame in cui si rispeccHia la società odierna. 2014 Il desiderio di essere come tutti di FRANCESCO PICCOLO (1964) Una rilettura degli ultimi 50 anni della storia italiana cHe lo scrittore ripercorre attraverso il suo vissuto. 2013 Resistere non serve a niente di WALTER SITI (1947) Un’analisi appassionata della realtà cHe ci inquieta ma forse non ci sorprende. 2012 Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi di ALESSANDRO PIPERNO (1972) Collegato come storia al precedente Persecuzioni affonda il dito nelle dinamiche di una famiglia che, nascondendo le proprie debolezze e colpe al suo interno rischia di spaccarsi. → Hier sind die UnzertrennlicHen: Im Feuer der Erinnerungen; FisHer Verlag 2011 Storia della mia gente di EDOARDO NESI (1964) Storia di una vitalissima piccola provincia che non riesce a contrapporsi e ad evitare la decadenza economica. -

PROGRAMMA LETTERARIO Realizzato a Cura Del Centro Per Il
PROGRAMMA LETTERARIO realizzato a cura del Centro per il Libro e la Lettura della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’ AIE - Associazione Italiana Editori Aggiornato al 22 ottobre 2008 SABATO 29 NOVEMBRE Ore 13.30 L’Italia e gli occhi Padiglione Italia Inaugurazione del Padiglione Italia e della mostra fotografica Le città invisibili . Immagini e sguardi Caffè letterario inediti sull’Italia. Intervengono le autorità italiane e gli autori presenti Il Padiglione Italia è connotato da un percorso visivo che rimanda allo slogan della partecipazione Italia e italianidad. La memoria, gli scambi, gli occhi, il desiderio e che è ripreso da Le città invisibili di Italo Calvino. In questo viaggio per immagini il visitatore può immergersi nell’Italia del passato e della memoria, della mescolanza secolare di culture e della nuova integrazione, della bellezza classica e delle nuove frontiere della ricerca tecnologica. Ore 17 L’Italia e la memoria Padiglione Italia Protagonisti: Italo Calvino. Caffè letterario La memoria, gli scambi, gli occhi, il desiderio. Un percorso biografico. Presentazione della mostra dedicata a Italo Calvino. Intervengono Marco Belpoliti , Vincenzo Cerami , Alain Elkann , Ernesto Franco , Paolo Mauri Modera Danilo Manera Omaggio al grande narratore e studioso del Novecento a cui si ispira la partecipazione italiana, che viene ricordato anche in un piccolo percorso per immagini attraverso la sua vita, la sua opera e i suoi rapporti con l’America Latina. DOMENICA 30 NOVEMBRE Ore 10 L’Italia e la memoria Padiglione Italia L’ultima Italia tra prosa e poesia. -

Gianluigi Simonetti
Come e cosa desidera la narrativa italiana degli anni Zero Gianluigi Simonetti 1. Circa vent’anni fa, a Pisa, quando cominciai gli studi universitari, alcuni dei miei insegnanti di allora spiegavano che anche la letteratura più apparentemente frigida ed asettica ha molto a che fare col desiderio. Un po’ perché la letteratura serve a esprimere, in una struttura di compromesso, desideri consci o inconsci – con qualche preferenza per quelli socialmente o ideologicamente incompatibili; un po’ perché se il desiderio si manifesta nell’uomo, almeno apparentemente, come grandezza infinita, l’arte, soprattutto nella modernità, si è spesso pensata come ‘infinito possibile’, e quindi come equivalente stilistico del desiderio stesso 1. Sono considerazioni che continuano a sembrarmi valide, ma che andranno in parte corrette o integrate se si guarda, come ci accingiamo a fare, al modo in cui desidera la narrativa italiana contemporanea, con un interesse particolare alla situazione degli ultimi anni. Impossibile investigare tutti i desideri – innumerevoli – che attraversano il nostro campo letterario; più banalmente si potrà tentare un’umile, schematica ricognizione della situazione della narrativa, attraverso l’analisi di alcuni testi esemplari. Esemplari, voglio dire, perché rappresentativi di tendenze corpose; non sempre e non solo opere d’arte riuscite, quindi, ma piuttosto indicatori sociologici in grado di darci un’idea non troppo imprecisa dei processi in atto. Al centro della nostra attenzione scegliamo inoltre di mettere un solo tipo di desiderio – il desiderio 1 Cfr. Orlando 1971, poi ripreso in Id. 1973, in particolare pp. 24 3 sgg. (ma cfr. anche Id. 1985). Between, vol. III, n. 5 (Maggio/May 2013) Gianluigi Simonetti, Come e cosa desidera la narrativa italiana degli anni Zero ‘forte’ per eccellenza, il più incline alla mimesi e alla ricerca dell’infinito, ovvero il desiderio erotico (senza privarci di qualche puntata in sfere contigue, quando se ne presenterà l’occasione). -

Estate 2019 Xx Edizione
XX EDIZIONE ESTATE 2019 2 BENVENUTI Dieci anni di Una Montagna di Libri. Era il 2009 quando, venti edizioni fa, cominciavamo a chiamare a Cortina narratori, intelligenze, idee, scritture. Iniziò quasi per scherzo. Oggi, in un momento storico segnato dalla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, in mezzo a urgenze che diventano drammatiche, e parlando dalla grande nazione dei boschi che sono le Dolomiti, Una Montagna di Libri si ispira alla vita degli alberi. Che crescono secondo solidità e robustezza, lontani dai tempi frenetici della vita umana, tenendo le radici nel terreno. Così festeggiamo i nostri primi dieci anni. Sarebbe bello fotografare la scintilla di meraviglia che si accende nello sguardo degli scrittori che vengono da tutto il mondo a Una Montagna di Libri, quando per la prima volta vedono queste montagne. Forse scopriremmo che è la stessa dei loro lettori, anche in questo accomunati da un segreto legame. Succede anche a chi è già viaggiatore cosmopolita, a chi ha già visto così tante cose in giro per il mondo, a chi credeva esaurita la sua "capacità di meraviglia", come scriveva Francis Scott Fitzgerald. Anche questa estate vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma che tenete tra le mani. È un riflesso della grande varietà di esperienze, di incontri, di viaggi che si possono fare quassù. Partiamo insieme, per una nuova avventura. Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers together in Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts and sciences with audiences of all ages. -

Premio Strega
VINCITORI E FINALISTI DAL 2000 Agosto – Settembre 2018 BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG Via Genova, 10 / Bologna / Bus 19 e 27 B Tel. 051/46.63.07 [email protected] www.bibliotechebologna.it 1 PREMIO STREGA Il Premio Strega è un premio letterario che viene assegnato annualmente all'autore o autrice di un libro pubblicato in Italia, tra il 1º aprile dell'anno precedente ed il 31 marzo dell'anno in corso. Dal 1986 è organizzato e gestito dalla Fondazione Bellonci. È universalmente riconosciuto come il premio letterario più prestigioso d'Italia, oltre a godere di una consolidata fama in Europa e nel resto del mondo. Fonte: Wikipedia 2018 Vincitore: Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda Inv. GIN 34424 - Coll. N JANEH RAG Marco Santagata. :Biografia, romanzo storico, romanzo sentimentale? La ragazza con la Leica è tutte queste cose e, forse, qualcosa di più: è la fotografia di un intero gruppo di giovani esuli, per lo più di origine ebraica, che si incontra e si unisce nella Parigi degli anni Trenta. Benedetta Tobagi :Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Finalisti: Carlo D’Amicis, Il gioco, Mondadori. Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Pozza. Inv. GIN 34830 - Col. MAZ 928 GIN Lia Levi, Questa sera è già domani, E/O. Inv. GIN 34732 - Col. N LEVIL QUE Marco Balzano, Resto qui, Einaudi. Inv. GIN 34906 - Col N BALZM RES 2017 Vincitore: Paolo Cognetti , Le otto montagne, Einaudi. -

Současná Italská Literatura V Českých Překladech Bibliografie
Současná italská literatura v českých překladech (Zuzana Šebelová, [email protected]) Bibliografie: KŘESÁLKOVÁ, Jitka. Italská literatura v Čechách a na Slovensku: bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny, vydaných od počátku knihtisku do současnosti, a přeložených netištěných divadelních her a operních libret inscenovaných od 18. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 Obec překladatelů – Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945 (italská literatura) http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/ZZPREKLADY/totalitalstina.htm Antologie: BOHADLOVÁ, Kateřina a Alice FLEMROVÁ. Hořký život: antologie současné italské prózy a dramatu. Praha: Havran, 2007. http://www.iliteratura.cz/Clanek/%2022459 ŠPIČKA, Jiří. Italská čítanka: Gutenbergova čítanka současné italské prózy: italsko-české vydání. Praha: Labyrint revue, 2008. http://www.iliteratura.cz/Clanek/22547/spicka-jiri-ed-italska-citanka Jako příloha Literárních novin 1/2018 vyšla Pražská knižní revue věnovaná italské literatuře v českých překladech. https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/cs/gli_eventi/calendario/2018/02/serata-con-la- letteratura-italiana.html Malé ohlédnutí do historie Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 1896 – 1957) Gepard (Il gattopardo, 1958; česky 1963) Carlo Levi (Turín, 1902 – 1975) Kristus se zastavil v Eboli (Cristo si è fermato a Eboli, 1945; česky 1957) Alberto Moravia (Řím, 1907 – 1990) Lhostejní (Gli indifferenti, 1929; česky 1964) Agostino (Agostino, 1943; česky 1964) Římanka (La -

Regatul Romaniei
RegatulRomaniei file:///C:/Programele%20Mele/IstorieRomania1/RegatulRomaniei/Regat... Regatul României Visul unirii tuturor românilor sub un singur steag a frământat mințile conducătorilor încă din cele mai vechi timpuri, dar alianțele militare și interesele de ordin comercial nu au fost în favoarea simplificării relațiilor dintre diferitele formațiuni statale. În vechime, țările românești au negociat protecția celor două mari imperii ale romanilor, apoi începând cu secolul al XIII-lea au întreținut legături de prietenie și ajutor mutual cu Polonia și Lituania. Din secolul al XV-lea, ca state vasale Imperiului Otoman dar sub protecția directă a Hanatului Crimeei, s-a pus problema formării unui eyalat turcesc comun. Proiectul a fost însă refuzat cu dârzenie, ca urmare a divergențelor de ordin religios. Ca o soluție de compromis, sultanii au permis independența religioasă a celor trei principate, în schimbul dependenței economice. Situația de criză a intervenit o dată cu revoluția și apoi războiul de independență purtat de greci și sârbi. Sub aripa ocrotitoare a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, creștinii din toate țările Balcanice au ridicat la început glasul, apoi armele, cerând vehement ieșirea din situația de compromis religios. Ca rezultat, boierii și dragomanii greci au fost maziliți, iar mănăstirile filiale ale celor de la Muntele Athos au fost secularizate. În urma grecilor au rămas nenumăratele lor rude născute din alianțe cu casele boierești autohtone, practic aproape toată crema boierimii. Pentru a umple vidul administrativ rămas s-a hotărât instituirea unei locotenențe domnești, ajutată de o Adunare Constituantă a fruntașilor celor două țări. În ambele principate, toate sufragiile au fost întrunite în anul 1859 de Colonelul Alexandru Ioan Cuza, cu funcția de Ministru de Război, fost deputat de Galați și fost șef al Miliției de la Dunărea de Jos. -

Elenco Libri Completo Al 4-11-2017 in Ordine Di Autore E Titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod
Elenco libri completo al 4-11-2017 in ordine di Autore e titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod. Classificazione Il Cerchio n.9 Da Macao a Napoleone A Enciclopedia1976 29 Enciclopedia Egenio Oneghin A.A. Puskin Libro 1967 2686 Romanzo in versi Cremona fedelissima A.Campi Libro 1990 2943 Storia cremonese Anni verdi A.J. Cronin Libro 1972 2864 Narrativa ragazzi E le stelle stanno a guardare A.J. Cronin Libro 1974 3790 Romanzo Gran Canaria A.J. Cronin Libro 1956 4438 Romanzo Il medico dell'isola A.J. Cronin Libro 1966 4424 Narrativa La Cittadella A.J. Cronin Libro 1974 3787 Romanzo Dizionario illustrato della lingua latina AA Libro 1974 42 Dizionario 1945 La Liberazion. Pagina giornale AA.VV. Libro 1986 2276 Narrativa storica 24H MountainBike Cremona KulaMula AA.VV. Libro 2013 5221 Sport 25 anni dell'Espresso AA.VV. Libro 1981 1592 Narrativa storica 50 anni fa Crema e i cremaschi dal '43 al '45 AA.VV. Libro 1995 4867 Storia Acque bonifica e irrigazione in Lombardia AA.VV. Libro 2001 4294 Territorio Acque dolci sotterranee raccolta dati Agip AA.VV. Libro 1972 200 Territorio After effect 4 AA.VV. Libro 2000 4916 Computer Alla scoperta del modo ANIMALI AA.VV. Libro 1998 4782 Scienza Alla scoperta del modo DINOSAURI AA.VV. Libro 1997 4789 Scienza Alla scoperta del modo IL MARE AA.VV. Libro 1998 4787 Scienza Alla scoperta del modo IL MEDIOEVO AA.VV. Libro 2001 4786 Storia Alla scoperta del modo LA FORESTA AA.VV. Libro 2002 4788 Scienza Alla scoperta del modo LA NATURA AA.VV. -

Premio Strega
Anno Vincitore Opera Editore La nave di 2020 Sandro Veronesi Colibrì Teseo 2019 Antonio Scurati M. Il figlio del secolo Bompiani 2018 Helena Janeczek La ragazza con la Leica Guanda 2017 Paolo Cognetti Le otto montagne Einaudi 2016 Edoardo Albinati La scuola cattolica Rizzoli 2015 Nicola Lagioia La ferocia Einaudi 2014 Francesco Piccolo Il desiderio di essere come tutti Einaudi 2013 Walter Siti Resistere non serve a niente Rizzoli 2012 Alessandro Piperno Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi Mondadori 2011 Edoardo Nesi Storia della mia gente Bompiani 2010 Antonio Pennacchi Canale Mussolini Mondadori 2009 Tiziano Scarpa Stabat Mater Einaudi 2008 Paolo Giordano La solitudine dei numeri primi Mondadori 2007 Niccolò Ammaniti Come Dio comanda Mondadori 2006 Sandro Veronesi Caos Calmo Bompiani 2005 Maurizio Maggiani Il viaggiatore notturno Feltrinelli 2004 Ugo Riccarelli Il dolore perfetto Mondadori 2003 Melania Gaia Mazzucco Vita Rizzoli 2002 Margaret Mazzantini Non ti muovere Mondadori 2001 Domenico Starnone Via Gemito Feltrinelli 2000 Ernesto Ferrero N. Einaudi 1999 Dacia Maraini Buio Rizzoli 1998 Enzo Siciliano I bei momenti Mondadori 1997 Claudio Magris Microcosmi Garzanti Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, 1996 Alessandro Barbero Mondadori gentiluomo 1995 Mariateresa Di Lascia Passaggio in ombra Feltrinelli 1994 Giorgio Montefoschi La casa del padre Bompiani 1993 Domenico Rea Ninfa plebea Leonardo 1992 Vincenzo Consolo Nottetempo, casa per casa Mondadori 1991 Paolo Volponi La strada per Roma Einaudi 1990 Sebastiano Vassalli La -

La «Strega» Isabella Cacciata Dallo Strega
18/04/2012 Il Tempo - Ed. nazionale (diffusione:50651, tiratura:76264) La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa pagina. Il ritaglio stampa da intendersi per uso privato La «strega» Isabella cacciata dallo Strega Di Lidia Lombardi Come Lucifero «punita» per l'atto di insubordinazione? Viene da pensarlo a proposito della «indisciplinata» Isabella Santacroce. Non è stata ammessa tra i dodici autori che concorreranno al Premio Strega 2012. Lo ha deciso il comitato direttivo del Premio - Tullio De Mauro e Valeria della Valle della Fondazione Bellonci, Giuseppe D'Avino e Alberto Foschini di Strega Alberti Spa, Dino Gasperini, assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandro Barbero, Melania Mazzucco e Ugo Riccarelli premiati nelle precedenti edizioni , Giuseppe De Rita e Fabiano Fabiani, due giurati. La lista dei candidati è uscita che ormai era sera, segno forse di appassionato dibattito in via dei Fratelli Ruspoli, una volta salotto pariolino di Maria Bellonci, ora sede della Fondazione che ne porta il nome. La decisione, comunque, è stata presa all'unanimità, recita il comunicato del Premio. E davvero a sorpresa il libro della Santacroce non è entrato a far parte della dozzina che affronterà il giudizio dei 400 Amici della Domenica (più i 60 «lettori forti» segnalati dalle librerie indipendenti). Eppure la ex-cannibale pubblica con Bompiani il suo romanzo «più maestoso», come recita il risvolto di copertina di «Amorino». Eppure era presentata da due Amici della Domenica del calibro di Enrico Ghezzi e Angelo Guglielmi. Vai a capire se è stata proprio la casa editrice di Moravia a premere per l'esclusione, preoccupata del «fuoco amico» che «Amorino» avrebbe potuto sparare contro «Il silenzio dell'onda» del magistrato-giallista Gianrico Carofiglio, pubblicato dalla consociata in Rcs, la Rizzoli, e presentato addirittura dal direttore del Corrierone, Ferruccio De Bortoli, in coppia con Rosellina Archinto. -
Universidade De São Paulo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM LÍNGUA, LITERATURA E CULTURA ITALIANAS CLARA MARIA SALVADOR PEREIRA DA COSTA Narrativa italiana no século XXI segundo o Premio Strega Versão corrigida São Paulo 2019 Narrativa italiana no século XXI segundo o Premio Strega Versão corrigida Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Letras. Orientadora: Profª. Drª. Doris Nátia Cavallari São Paulo 2019 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. I authorize the total or partial reproduction and release of this work, by any conventional or electronic means, for the purpose of study and research, provided the source is cited. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTAÇÃO/TESE Termo de Ciência e Concordância do (a) orientador (a) Nome do (a) aluno (a): Clara Maria Salvador Pereira da Costa Data da defesa: 11/10/2019 Nome do Prof. (a) orientador (a): Doris Nátia Cavallari Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da comissão Julgadora na sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente favorável ao seu encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP.