Tempo E Memoria Nella Lingua E Nella Letteratura Italiana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Colloquium Helveticum 47/2018
Cahiers suisses de littérature générale et comparée Schweizer Hefte für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Quaderni svizzeri di letteratura generale e comparata Swiss Review of General and Comparative Literature Revue publiée par l’Association suisse de littérature générale et comparée Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft A cura dell’Associazione svizzera di letteratura generale e comparata Published by the Swiss Association of General and Comparative Literature Redaktion: Edith Anna Kunz und Joëlle Légeret Präsidium: Thomas Hunkeler, Université de Fribourg, Département des langues et littératures, Domaine Français, Av. de Beauregard 13, CH-1700 Fribourg ([email protected]) Sekretariat: Julian Reidy, Attinghausenstrasse 29, CH-3014 Bern ([email protected]) Wissenschaftlicher Beirat: Arnd Beise (Fribourg), Corinne Fournier Kiss (Bern), Nicola Gess (Basel), Sabine Haupt (Fribourg), Ute Heidmann (Lausanne), Martine Hennard Dutheil (Lau- sanne), Edith Anna Kunz (St. Gallen), Joëlle Légeret (Lausanne), Oliver Lubrich (Bern), Dagmar Reichardt (Groningen), Martin Rueff (Genève), Niccolò Scaffai (Lausanne), Michel Viegnes (Fribourg), Markus Winkler (Genève), Sandro Zanetti (Zürich) Beiträge zu Themenschwerpunkt oder Varia können beim Sekretariat eingereicht werden. Über die Publikation entscheidet die Redaktion auf der Grundlage eines Peer-Review. Weitere Informationen zum Colloquium Helveticum sowie zur Mitgliedschaft bei der SGAVL: www.sagw.ch/sgavl. -

Omaggio a Italo Calvino
Italo Calvino 1 Omaggio a Italo Calvino Torino, 13 febbraio - 24 marzo 2016 OMAGGIO A ITALO CALVINO `eun progetto che nasce nel giugno del 2015 da un’Idea di Ocra Lab idee per comunicare, Impresa culturale torinese di Cristina Ballerini, e che viene presentato alla Citt`adi Torino Biblioteche Civiche e alla Regione Piemonte, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, insieme all’Associazione d’Arte e Cultura Leon Battista Alberti alla vigilia della ricorrenza del trentennale dalla scomparsa del grande scrittore, con l’obiettivo di realizzare un Programma di iniziative culturali a lui dedicate, aventi come cifra comune la PLURALITA’, di linguaggi e di territori, e il luogo BIBLIOTECA ad ospitare e promuovere tutti gli eventi per continuare, o tornare a essere, punto di riferimento per la ’comunit`adel libro’ per la sua funzione di presidio alla LETTURA, luogo di democrazia e libert`a,principi dai quali ITALO CALVINO fu sempre animato. L’ADESIONE di SANREMO E TORINO, che condividono il progetto, vuole essere un ulteriore OMAGGIO, in quanto citt`achiave per la sua formazione e maturit`a,di pensiero e scrittura. Da questo embrione `enato il PROGRAMMA di iniziative inaugurate il 19 settembre 2015 con EVENTI E LETTURE AD ALTA VOCE organizzate nelle due citt`apartner, che prosegue fra febbraio e marzo con MOSTRE, SPETTACOLI, LETTURE, grazie al sostegno della Regione Piemonte e con le Part- nership di Citt`adi Torino Biblioteche Civiche, Comune di Sanremo, Biblioteca Civica F. Corradi e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Gli eventi verranno ospitati nella Rete delle Biblioteche torinesi e nel la casa del Quartiere di San Salvario. -

Society for Italian Studies Biennial Conference 2019
Society for Italian Studies Biennial Conference 2019 University of Edinburgh 26-28 June 2019 Programme Welcome Benvenute! Benvenuti! Italian Studies at the University of Edinburgh are truly delighted to welcome you all to the 2019 Biennial Conference of the Society for Italian Studies. We are celebrating the Centenary of Italian at the University of Edinburgh (1919-2019), and we are proud to be hosting this major conference with nearly 300 delegates, including some of the most distinguished keynote speakers, leading academics, and inspiring students from Europe, Australia, North America and beyond. Thank you for your participation. Enjoy the Conference! The Edinburgh Team Edinburgh Team The Edinburgh team consists of staf and students of the University of Edinburgh. Lead Organisers Davide Messina Federica G Pedriali Co-Organisers Nicolò Maldina Carlo Pirozzi Information Desk Marco Palone Daniela Sannino Marialaura Aghelu Helpers Simone Calabrò Daniele Falcioni Niamh Keenan Alessandra Pellegrini De Luca Marco Ruggieri University of Ediburgh School of Literatures, Languages and Cultures Department of European Languages & Cultures 50 George Square Edinburgh EH8 9LH www.llc.ed.ac.uk/delc/italian/sis-2019 For further information, please email the Lead Organisers Davide Messina ([email protected]) and Federica G. Pedriali ([email protected]) Keynote Lectures On Ulysses: in Praise The Changing Fortunes Speaking in Cultures of Literature of Translations Wednesday 26 June Wednesday 26 June Wednesday 26 June 11:00-12:00, Room G.03 1:00-2:00, Room G.03 6:15-6:50, Scottish Parliament Lino Pertile is Carl A. Susan Bassnett is Professor Jhumpa Lahiri is Professor Pescosolido Research of Comparative Literature at of Creative Writing at the Professor of Romance the University of Glasgow, Lewis Center for the Arts, Languages and Literatures, and Professor Emerita of Princeton. -

Elio Gioanola Carlo Bo Charles Singleton Gianfranco Contini
Elio Gioanola Introduzione Carlo Bo Ricordo di Eugenio Montale Charles Singleton Quelli che restano Gianfranco Contini Lettere di Eugenio Montale Vittorio Sereni Il nostro debito verso Montale Vittore Branca Montale crìtico di teatro Andrea Zanzotto La freccia dei diari Luciano Erba Una forma di felicità, non un oggetto di giudizio Piero Bigongiari Montale tra il continuo e il discontinuo Giovanni Macchia La stanza dell'Amiata Ettore Bonora Un grande trìttico al centro della « Bufera » (La primavera hitleriana, Iride, L'orto) Silvio Guarnieri Con Montale a Firenze http://d-nb.info/945512643 Pier Vincenzo Mengaldo La panchina e i morti (su una versione di Montale) Angelo Jacomuzzi Incontro - Per una costante della poesia montaliana Marco Forti Per « Diario del '71 » Giorgio Bàrberi Squarotti Montale o il superamento del soggetto Silvio Ramat Da Arsenio a Gerti Mario Martelli L'autocitazione nel secondo Montale Rosanna Bettarini Un altro lapillo Glauco Cambon Ancora su « Iride », frammento di Apocalisse Mladen Machiedo Una lettera dì Eugenio Montale (e documenti circostanti) Claudio Scarpati Sullo stilnovismo di Montale Gilberto Lonardi L'altra Madre Luciano Rebay Montale, Clizia e l'America Stefano Agosti Tom beau Maria Antonietta Grignani Occasioni diacroniche nella poesia di Montale Claudio Marabini Montale giornalista Gilberto Finzi Un'intervista del 1964 Franco Croce Satura Edoardo Sanguineti Tombeau di Eusebio Giuseppe Savoca L'ombra viva della bufera Oreste Macrì Sulla poetica di Eugenio Montale attraverso gli scritti critici Laura Barile Primi versi di Eugenio Montale Emerico Giachery La poesia di Montale e il senso dell'Europa Giovanni Bonalumi In margine al « Povero Nestoriano smarrito » Lorenzo Greco Tempo e «fuor del tempo» nell'ultimo Montale . -

B I B L I O T E
ASSOCIAZIONE IMPIEGATI IN QUIESCENZA DELLA REGIONE SICILIANA via Siracusa, 10 - 90141 PALERMO Tel. 091/6259314 -091/6259216 FAX 091/6259721 sito: www.aiqres.com - email: [email protected] BIBLIOTECA CATALOGO GENERALE PER AUTORI Angolo di lettura "Felice Giacone" CATALOGO GENERALE PER AUTORI Autore Titolo argomento pagine serie prot. Anna Maida Adragna Cento Richiami poesie 95 Sicilia 375 Henry Miller Tropico Del Cancro romanzo 296 Estero 232 Franco Venturi Giovinezza Di Diderot narrativa 337 Italia 316 Nando "russo Antologia Della Mafia saggio 647 Sicilia 615 Emanuela E Abbadessa Capo Scirocco romanzo 373 Sicilia 478 La Luce Del Nord - La Storia Dello Fbi - Verdi reportage Altro 0 Dimore - La Citta Prigioniera Luigi Accattoli Wojtyla narrativa 168 Italia 105 Peter Ackroyd Il Ragazzo Meraviglioso (chatterton) romanzo 280 Estero 1 Adler La Funzione Simbolica saggio 317 Estero 2 Susanna Agnelli Addio, Addio Mio Ultimo Amore romanzo 189 Italia 1 Beatrice Agnello La Sicilia Del Gattopardo narrativa 106 Sicilia 293 Simonetta Agnello Hornbv Boccamurata romanzo Sicilia 476 Il Veleno Dell'oleandro romanzo 217 Sicilia 548 L' Amante Inglese romanzo 322 Sicilia 230 La Mennulara romanzo 209 Sicilia 2 La Monaca narrativa 296 Sicilia 134 La Zia Marchesa romanzo 322 Sicilia 1 Via Xx Settembre romanzo 225 Sicilia 557 Pagina 2 di 92 CATALOGO GENERALE PER AUTORI Autore Titolo argomento pagine serie prot. Giovanna Agrò I Colori Della Mia Terra catalogo 13 Sicilia 527 Milena Agus Mal Di Pietre romanzo 119 Italia 342 R. Alaimo L' Arte Di Annacarsi - Un Viaggio -

GESTIONE BIBLIOTECA Comunale Di Bonito (AV) Codice Genere Titolo Sottotitolo Autore Pagine Editore Anno Ubicazione 1 Ubicazione 2 Disponib
GESTIONE BIBLIOTECA Comunale di Bonito (AV) Codice Genere Titolo Sottotitolo Autore Pagine Editore Anno Ubicazione 1 Ubicazione 2 Disponib. 4928 Poesia dialettale 'A Storia 'E Roma Sonetti dialettali Ernesto Murolo 88 F. Bideri 1957 S17 P2 P 322 Novelle Il dolce frutto Fiducia 170 Società editrice internazionale 1926 S2 P4 F.D.P. 371 Storia La spedizione italiana in Cina (1900-1901) Cap. Amedeo Tosti 147 Roma 1926 S3 P1 F.D.P. 4271 Romanzo Le anime morte N. V. Gogol' 314 Edipem 1973 S14 P4 1333 Storia Le meraviglie della pace e della guerra Supka - faver 92 Genio 1941 S7 P1 P 5072 Teatro ' O voto -'O mese mariano Assunta Spina Salvatore Di Giacomo 206 Arnoldo Mondadori 1966 S17 P6 P 4358 Saggistica Renato Sandri un italiano comunista Roberto Borroni 223+illustrazioni Tre lune 2010 S15 P2 5297 Diario " Diario di una maestra " Arcangelo Musto 39 Poligrafica Irpina 1991 S17 P9 P 2190 Teatro " E il sordomuto udì, parlo: mistero!" Maria Luigia Cipriano 43 Menna (AV) 2003 S9 P4 P 2761 Saggistica " San Francesco D'Assisi Pace e Bene! " Dott. Prof. Arcangelo Musto 156 Lioni (AV) 2003 S10 P5 P 5056 Teologia "Apostolicam actuositatem" Decreto Conciliare sull'apostolato dei laici 55 Edizioni Paoline 1965 S17 P5 P 5460 Storia locale "Dal Palazzo Nuovo alla Vita Nuova" centenario maggio 1898 - maggio 1998 AA.VV. 31 Delta 3 1998 s17 p11 p 2128 Diario "Diario di una maestra" Arcangelo Musto 39 Montemiletto 1990 S9 P3 P 1438 Poesia "'E Ventagliere" Ermanno Comite 78 Equilibrio nelle Arti (NA) 1979 S7 P4 P 4954 Teologia "Ebbe compassione delle folle" Meditazioni pastorali a 25 anni dal Concilio Giovanni B. -

Tempo E Memoria Nella Lingua E Nella Letteratura Italiana
Civiltà Italiana Pubblicazioni dell’Associazione Internazionale Professori d’Italiano Nuova serie 5 - 2009 Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006 Vol. III: Narrativa del Novecento e degli anni Duemila Associazione Internazionale Professori d’Italiano 2009 www.infoaipi.org Comitato di redazione Michel Bastiaensen (Bruxelles) Alberto Bianchi (Wheaton College) Pietro De Marchi (Zurigo/Neuchâtel) Dagmar Reichardt (Brema) Daragh O’ Connell (Cork) Corinna Salvadori Lonergan (Dublino) Roman Sosnowski (Cracovia) Bart Van den Bossche (Lovanio, coordinatore) Ineke Vedder (Amsterdam) A.I.P.I. – Associazione Internazionale Professori d’Italiano sede giuridica: Place Anneessens 11, 1000 Bruxelles ISBN 978 90 8142 540 7 “Civiltà Italiana” è la collana dell’A.I.P.I. - Associazione Internazionale Professori d’Italiano. I contributi vengono selezionati mediante revisione paritaria da parte di due membri del Comitato di Redazione. “Civiltà Italiana” is the peer-reviewed series of the A.I.P.I. - Associazione Internazionale Professori d’Italiano; each paper submitted for publication is judged independently by at least two members of the Editorial Board of the Series. INDICE DEL TERZO VOLUME I. TEMPO E MEMORIA NELLA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO KARL CHIRCOP (University of Malta / L’-Università ta’ Malta), pag. 11 Tempo e memoria nell’epifania di Joyce e Pirandello BARBARA MEAZZI (Université de Savoie), Enif Robert e Filippo » 23 Tommaso Marinetti: «Un ventre di donna» e l’autobiografia futurista FRANCO MUSARRA (K.U.Leuven) «I pensionati della memoria» di » 43 Pirandello tra ironia e metadiscorsività FULVIO SENARDI (Università di Trieste), Italo Svevo ultima » 59 maniera: gli ironici ricordi e le paradossali riflessioni del «vecchione» II. -

Riattivazione Del Premio Letterario IILA a Roberto Fernández Retamar Indice
iila NUOVO PREMIO LETTERATURAiila Riattivazione del Premio Letterario IILA A Roberto Fernández Retamar Indice Introduzione 3 di Donato Di Santo, Segretario Generale IILA Premio Letterario IILA 5 a cura della Segreteria Culturale - Breve storia del Premio - I vincitori 1969-1996 - La giuria - Il logo - Progetto pilota 2019-2020 Galleria degli autori vincitori 10 Biografia di Roberto Fernández Retamar 23 2 Introduzione L’IILA, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, formata dai governi dell’Italia e di 20 paesi dell’America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela), sta vivendo la sua “rinascita” anche in ambito culturale. Una delle tappe più importanti di questo percorso, che trae la propria forza evocativa dalle radici stesse dell’IILA, è la riattivazione (dopo ben 23 anni!), del suo prestigioso Premio Letterario. Nelle varie edizioni - dal 1969 al 1996 - sono stati premiati autori del calibro di: José Lezama Lima (Cuba), Juan Carlos Onetti (Uruguay), Jorge Amado (Brasile), Antonio Di Benedetto (Argentina), Manuel Puig (Argentina), Mario Vargas Llosa (Perù), Ignácio de Loyola Brandão (Brasile), Adolfo Bioy Casares (Argentina), Carlos Fuentes (Messico), Álvaro Mutis (Colombia), Augusto Monterroso (Guatemala), Guillermo Cabrera Infante (Cuba), Francisco Coloane (Cile). Di grande valore sono stati anche i vincitori della “Sezione traduttori”, tra cui Francesco Tentori Montalto, Giuliana Segre Giorgi, Pino Cacucci, tra gli altri. Nel corso della storia del Premio, si sono avvicendati nella Giuria personalità come Leonardo Sciascia, Giovanni Macchia, Guido Piovene, Mario Luzi, Dario Puccini, Angelo Maria Ripellino, Carmelo Samonà, tra gli altri. -

1861-2011. L'italia Dei Libri, Esposta Al XXIV Salone Internazionale Del Libro Di Torino
1861-2011. L'Italia dei Libri I 150 Grandi Libri che - anno dopo anno – dal 1861 al 2011 hanno scandito la storia d’Italia e contribuito a plasmare il nostro costume, il gusto, il nostro pensiero. I libri che ci hanno resi un po’ più italiani. Proponiamo i 150 libri scelti dai curatori della mostra 1861-2011. L'Italia dei Libri, esposta al XXIV Salone internazionale del Libro di Torino. Narrativa, fiabe, poesia, storia e divulgazione scientifica, storia dell’arte e teologia, sperimentazione e umorismo, antropologia criminale e manuali di cucina, bestseller e rarità particolarmente significativi per la storia culturale del nostro Paese. E’ indicata la breve descrizione bibliografica e la collocazione per i libri presenti in biblioteca. 1862 - Paolo Giacometti, La morte civile 1866 - Massimo d’Azeglio, I miei ricordi Massimo d'Azeglio, I miei ricordi, Torino, Einaudi, 1971 853.8 DAZ 1868-1869 - Giuseppe Rovani, Cento anni Giuseppe Rovani, Cento anni, Torino, Einaudi, 2005 853.8 ROV 1869 - Igino Ugo Tarchetti, Fosca Igino Ugo Tarchetti, Una nobile follia; Fosca, Novara, Edizioni per il Club del libro, 1971 853.8 TAR 1871 - Vittorio Bersezio, Le miserie del signor Travetti 1873 - Paolo Mantegazza, Fisiologia dell’amore 1873 - Graziadio Isaia Ascoli, Proemio all’«Archivio glottologico italiano» 1876 - Cesare Lombroso, L’uomo delinquente 1876 - Antonio Stoppani, Il Bel Paese 1877 - Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti), Postuma 1877 - Vittorio Imbriani, Fame usurpate 1878 - Pasquale Villari, Lettere meridionali 1879 - Paolo Valera, Milano sconosciuta 1881 - Giovanni Verga, I Malavoglia Giovanni Verga, I Malavoglia, Milano, Bompiani, 1990 853.8 VER 1882 - Renato Fucini, Le veglie di Neri Renato Fucini, Le veglie di Neri, Roma, TEN, 1993 mag. -

Italo Calvino the Sun and the Moon Cesare Cases
OCTOBER 1986 THE ITALIAN REVIEW OF BOOKS - LIT. 5.000 Tullio Pericoli: Italo Calvino Italo Calvino The Sun and the Moon by Natalia Ginzburg Cesare Cases: Rethinking the Absurd Salvatore Settis: The Importance of Being Originai Giorgio Caproni: Sbarbaro s Asparagus Francis Haskell: The Enlightenment of Franco Venturi pag. 2 L'INDICE N.8 • dei libri del meseBì A Note front the Editor As the subtitle of this special issue indicates, "L'In- Wie der Untertitel dieser Sonderausgabe verrat, dice" likes to think of itself as the Italian review of books. versteht sich "L'Indice" als die italienische True, it is a mere two years old: but it has illustrious Buchkritikzeitschrift. Sie existiert zwar erst seit zwei foster parents, and like most children it strives to live up Jahren, hat aber dafiir illustre Vorfahren und ist bemiiht, to their fame while maintaining a distinct identity of its ihren Ruf zu nahren, indem sie eine klare Eigenidentitat own. Though published in Italian, it hopes to build up a aufrechterhàlt. Obwohl sie nur auf Italienisch erscheint, readership in other countries. hofft sie auf weitere Leserschaft aufierhalb Italiens. This special issue in English offers a sample for those Diese Sonderausgabe auf Englisch bietet eine who do not read Italian but are interested in Italian Kostprobe fiir diejenigen, die zwar kein Italienisch books. It is, of course, much briefer than a regular verstehen, aber an italienischen Buchern interessiert sind. monthly issue (only 16 pages instead of 48, reviewing up- Natiirlich ist sie mit nur 16 gegeniiber 48 Seiten einer wards of a hundred books); stili, we trust that it will give regularen Monatsausgabe, welche iiber 100 the reader a good idea of the kind of service "L'Indice" of- Neuerscheinungen rezensiert, wesentlich kiirzer gefafit; fers. -

Department of Italian Student Handbook 2018–2019
3rd edition (1.03.19) www.tcd.ie/italian Department of Italian Student Handbook 2018–2019 1 Dates 2018/19 Outline Structure of Academic Year Deadlines and notes TSM JF Orientation on Thursday, 6 September, 03-Sep-18 Orientation Week/ Freshers' Week Emmet Theatre, Arts Building. 10-Sep-18 Teaching Week 1 Michaelmas lecture term begins 17-Sep-18 Teaching Week 2 SS Grammar Assessment Test 1 during class. 24-Sep-18 Teaching Week 3 01-Oct-18 Teaching Week 4 SS Grammar Test 1. 08-Oct-18 Teaching Week 5 JF and SF Language Assessment Tests 1. 15-Oct-18 Teaching Week 6 22-Oct-18 Study/Review Week 29-Oct-18 Teaching Week 8 (Monday Public Holiday) JF Writing Test; JS Translation into Italian Test. SF ES Writing Test 1; JS Language Test 1; SS ES 05-Nov-18 Teaching Week 9 minor Translation Test 1. 12-Nov-18 Teaching Week 10 JF and SF Language Tests 2; SS Translation Test 1. JF ES and SF ES Reading Module Term Tests (two hours). SF: MT Dante assignment to be set. JS: MT 19-Nov-18 Teaching Week 11 Renaissance assignment to be set. JS The Modern Age assignment to be set. SS Cultural Texts class test; JS: submit major/minor choice forms online by Friday. SS: submit first draft of dissertation by Friday at 4.00pm. 26-Nov-18 Teaching Week 12 Michaelmas term ends Friday 30 November 2018. 03-Dec-18 Revision Week 10-Dec-18 Assessment Week Christmas period (College closed 24 17-Dec-18 December 2018 to 1 January 2019 incl) Note: it may be necessary to hold some exams in the 07-Jan-19 Foundation Scholarship Examinations preceding week 14-Jan-19 Marking/Results Week Hilary term begins. -
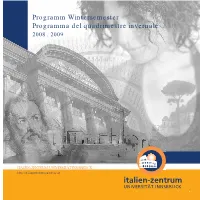
Programm Wintersemester Programma Del Quadrimestre Invernale 2008
Programm Wintersemester Programma del quadrimestre invernale 2008 . 2009 ITALIEN-ZENTRUM UNIVERSITÄT INNSBRUCK http://italienzentrum.uibk.ac.at p_sp_s 1 Deutsch / Tedesco Italienisch / Italiano Eintritt frei / Entrata libera OmU / Versione originale con sottotitoli Inhaltsverzeichnis / Indice Kontakt / Contatti p_s 2 Vorwort / Prefazione p_s 4 Vortragsreihe / Ciclo di Conferenze p_s 5 “Italia e Italie” – Identitäten eines Landes Italia e “Italie“ – identità di un paese al plurale Schwerpunkt / Focus: „Sog Sizilien“ p_s 22 Buchpräsentation / Presentazione libro: Roberto Alajmo: Mammaherz p_s 22 Vincenzo Consolo: Palermo. Der Schmerz p_s 23 Filmvorführung / Proiezione film: Sicilia! p_s 24 La terra trema p_s 25 Konzerte / Concerti Cappella Artemisia: Funkelt, ihr Sterne p_s 26 Duende: Storie di Tango p_s 27 ITALIEN-ZENTRUM DER LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK Theateraufführung / Rappresentazione teatrale Herzog-Friedrich-Straße 3, 1. Stock / 1o piano Compagnia Cantiere Centrale: Mela p_s 28 A-6020 Innsbruck ( (Altstadt / Centro storico) Kontakt . Contatti Ankündigungen / Annunci p_s 29 Tel. +43 (0)512 507 9085 Fax +43 (0)512 507 9824 Veranstaltungen im Überblick / Agenda delle manifestazioni p_s 30 E-Mail [email protected] Web http://italienzentrum.uibk.ac.at Impressum / Colofone p_s 35 Öffnungszeiten / Orari di apertura: Mo.–Fr. / lun.–ven. 09:00–17:00 p_s 2 p_s 3 VORWORT / PREFAZIONE VORTRAGSREIHE (RINGVORLESUNG) / CICLO DI CONFERENZE 08.10.2008 – 28.01.2009 “Italia e Italie” – Identitäten eines Landes Italia e “Italie” – identità di un paese al plurale Vorwort / Prefazione In Zusammenarbeit mit Dr. Angelo Pagliardini, Institut für Romanistik, Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Tilmann Märk und Mag. Saverio Carpentieri, Institut für Translationswissenschaft, Vizerektor für Forschung und Leiter der Koordinationsstelle für Länderschwerpunkte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Prorettore per la ricerca e Direttore per la coordinazione dei poli internazionali mirati sul Canada, La Francia e l’Italia Dr.