Venti Anni Lunghi Due Secoli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Relazione Sul Governo Societario E Gli Assetti Proprietari Modello Di Amministrazione E Controllo Tradizionale Terna S.P.A
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE TERNA S.P.A. E GRUPPO TERNA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2016 Trasmettiamo energia RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE TERNA S.P.A. E GRUPPO TERNA Emittente: «Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (in forma abbreviata Terna S.p.A.) Sito Web: www.terna.it Esercizio al quale si riferisce la Relazione: 2015 Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2016 Sommario 4 Executive Summary 12 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 4 Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2015 Struttura e composizione degli organi Assemblea degli azionisti Consiglio Collegio Società di Amministrazione Sindacale di Revisione Presidente Catia Bastioli Presidente Pricewaterhouse- Coopers S.p.A. Riccardo Enrico Maria Amministratore delegato Matteo Del Fante Schioppo Consiglieri* Sindaci effettivi Cesare Calari Vincenzo Simone Carlo Cerami Maria Alessandra Zunino de Pignier Fabio Corsico Luca Dal Fabbro Sindaci supplenti Yunpeng He Raffaella Annamaria Pagani Gabriella Porcelli Cesare Felice Mantegazza Stefano Saglia Renata Maria Ricotti Segretario del Consiglio di Ammininstrazione Filomena Passeggio * Legenda Comitato Remunerazione - Presidente Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance - Presidente Comitato Nomine - Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate - Coordinatore Componenti dei Comitati Executive Summary 5 Azionariato di Terna Il capitale sociale di Terna al 31 dicembre 2015 ammonta a 442.198.240,00 euro interamente versato ed è rappresentato da 2.009.992.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,22 ciascuna e risulta invariato alla data della presente Relazione. -

142Nd Annual Report
142 nd Annual report 2014 “What sets BSI apart are the origins which shape our approach to private banking. To our clients we offer all the certainties derived from over 140 years of Swiss private banking experience, together with the characteristics born of our Latin roots: the passion and that human touch we bring to each professional relationship. Together these characteristics ensure the flexibility and responsiveness critical to serving clients in a changing world. BSI is excited about the future and committed to creating an even more dynamic and innovative international Bank to meet the evolving needs of our clients wherever they are in the world.” Stefano Coduri Group CEO BSI – Contents Contents Annual report as submitted to the Ordinary General Shareholders’ Meeting of 21 April 2015 Highlights 2014 5 Foreword 7 Corporate governance 10 Human resources 18 BSI and Corporate Responsibility 19 Our identity 27 Management report 2014 31 Group financial statements 37 Consolidated balance sheet as of 31 December 2014 Consolidated profit and loss statement 2014 Consolidated cash flow statement 2014 Notes to the 2014 Group financial statements Report of the statutory auditor on the consolidated financial statements BSI Ltd. financial statements 77 Parent Bank balance sheet as of 31 December 2014 Parent Bank profit and loss statement 2014 Notes to the 2014 Parent Bank financial statements Report of the statutory auditor on the financial statements Glossary of selected terms and abbreviations 88 Contacts 91 This is a translation into English of the Annual Report issued in the Italian language and is intended solely for the convenience of English-speaking readers. -

Bilancio Consuntivo
BILANCIO CONSUNTIVO PER L‟ESERCIZIO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2012 (Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella Seduta del 22 aprile 2013) Fondazione Cassa di Risparmio di Torino pag.2 Principali risultati del 2012 Proventi totali 27 milioni di euro Avanzo dell’esercizio 12 milioni di euro Patrimonio netto 1.917 milioni di euro Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 0,6% Erogazioni deliberate nell’esercizio 43,5 milioni di euro Fondo stabilizzazione delle erogazioni 134 milioni di euro Accantonamento al Fondo per il Volontariato 0,3 milioni di euro Numero richieste esaminate 2.762 Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 65 milioni di euro pag. 3 ORGANI DELLA FONDAZIONE ......................................................................................... 5 RELAZIONE SULLA GESTIONE ........................................................................................ 8 RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA .................................................................... 8 BILANCIO DI MISSIONE ................................................................................................ 33 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 ......................................................... 68 SCHEMI DI BILANCIO .......................................................................................................... 68 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ..................................................................... 71 Informazioni generali sul bilancio d‟esercizio .......................................................................................... -

Liste Dal Catalogo Di Biblioteca: Politica Estera Italiana / Subject Lists
Liste dal catalogo di biblioteca – maggio 2021 Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library Subject lists from Library catalogue – May 2021 Politica estera italiana / Italian foreign policy LISTE DAL CATALOGO DI BIBLIOTECA SUBJECT LISTS FROM LIBRARY CATALOGUE maggio 2021 May 2021 Politica estera italiana Italian foreign policy 2nd international conference on the Mediterranean region on the subject "Security, stability and cooperation in the Mediterranean Region" / proceedings elaborated by Lorena Di Placido, Maria Egizia Gattamorta. - Roma : Centro militare di studi strategici, 2008. - 170 p. Pubbl. in: Osservatorio strategico, suppl. al n. 3 (marzo 2008) PM 1377 Il 18 aprile 1948 nella storia d'Italia : un contributo all'unità europea : bibliografia e riflessioni / [a cura di Giampaolo Malgeri e Maria Benedetta Francesconi ; saggio di Agostino Giovagnoli]. - Roma : Associazione popolo parlamento istituzioni, 1998. - 94 p. Bibliogr.: p.72-88. - Pubbl. come: Bollettino dell'Associazione popolo parlamento istituzioni, a.1., n.2 (settembre-dicembre 1998) DO 1286 150 anni di Unità d'Italia: aspetti istituzionali / Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. - Milano : EDUCatt, 2011. - 213 p. - (Quaderni del Dipartimento di Scienze politiche Università Cattolica del Sacro Cuore ; 2/2011). - ISBN 978-88-8311-879-1 Contiene anche gli atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 10 maggio 2011 Testo online: http://www.educatt.it/libri/ebooks/A-00000314%20QDSP02_2011.pdf O 2608 1990 : il nuovo quadro mondiale / Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 1989. - 28p. - (Documenti Iai ; 8929) IAI 1989 1992 : la crisi doppia. - Roma : Istituto affari internazionali, 1992. - 32 p. - (Documenti Iai ; 9238) Sul front.: Rapporto dell'Istituto affari internazionali in occasione della presentazione del XIX volume dell'annuario L'Italia nella politica internazionale : Progetto Rondinini, Roma 15 dicembre 1992. -

IMPRENDITORI, MANAGER, COMUNICATORI ECCO LE NUOVE CLASSIFICHE DEL POTERE L’Attimon
IMPRENDITORI, MANAGER, COMUNICATORI ECCO LE NUOVE CLASSIFICHE DEL POTERE l’attimoN. 45 - Luglio 2020 fuggentedirettore Cesare Lanza Francesco Starace Alessandro Profumo Matteo Del Fante Stefano Donnarumma Claudio Descalzi Guido Bastianini Fabio Maria Lazzerini Luciano Carta Lucia Calvosa Patrizia Grieco www.lamescolanza.com IMPRENDITORI, MANAGER, COMUNICATORI ECCO LE NUOVE CLASSIFICHE DEL POTERE l’attimoN. 45 - Luglio 2020 fuggentel’attimo fuggentedirettore Cesare Lanza Francesco Starace Alessandro Profumo Matteo Del Fante Stefano Donnarumma Claudio Descalzi Guido Bastianini Fabio Maria Lazzerini Luciano Carta Lucia Calvosa Patrizia Grieco www.lamescolanza.com Direttore Responsabile Cesare Lanza Direttore editoriale Antonio Eustor l’attimo fuggente rivista bimestrale, n. 45 / Luglio 2020 L’Attimo Fuggente Editore, direzione, redazione, amministrazione: Via Marcello Prestinari, 13 00195 Roma – tel. 06.93574813 [email protected], www.attimo-fuggente.com Stampato dalla Tipografia SAN VIA AURELIA 424 - 00165 ROMA (RM) Per gli abbonamenti: annuale 120? - Iban IT30R0103003217000001244481; Via Marcello Prestinari, 13 00195 Roma Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale D.L.353/03 70%Roma Aut C/RM/41/2407 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA – N°242\2007 DEL 12 GIUGNO 2007 sommario INTRODUZIONE 4 Anche per i grandi manager sono preziosi gli attimi fuggenti .. 4 LA LUNA NEL POZZO Corrado Calabrò 7 IL GOTHA DELL’ECONOMIA 9 Quelli che determinano il destino dell’Italia.......................... 9 IL TOP DELL’ECONOMIA 31 Quelli che detengono importanti posizioni di potere............... 31 MANAGERS & AMMINISTRATORI 71 I GRANDI COMUNICATORI 103 Specialisti dell’immagine e delle relazioni ............................ 103 I PROFESSIONISTI CHE CONTANO 113 Nelle relazioni istituzionali, esterne e comunicazione ............ 113 COMUNICATION, MARKETING AND SOCIAL MEDIA 139 2 CENTRI MEDIA 155 GRANDI AGENZIE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE 163 “Non è l’azienda che paga i salari. -

Driving Energy
Driving Energy We are engaged in driving and enabling the ecological transition in order to create a new development model based on renewable sources and respect for the environment. Sustainability, innovation and distinctive competencies are behind everything we do, with the aim of providing the generations to come with a clean, accessible and emission-free energy future. We are Europe’s largest independent electricity transmission system operator. We have the major responsibility for providing the country with energy, ensuring security, quality and cost-effectiveness over time. We manage Italy’s high-voltage electricity transmission grid, one of the most modern and technologically advanced in Europe, which we are working to develop and integrate with the European grid, guaranteeing secure and equal access to all grid users. We are developing Non-regulated Activities and new business opportunities, making our expertise and experience available in Italy and overseas. Executive Summary 4 Report on Corporate Governance and Ownership Structures for 2020 20 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES 2020 • Executive Summary Executive Summary Structure and composition of corporate bodies BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE VALENTINA BOSETTI STEFANO ANTONIO GIUSEPPE FERRI FABIO CORSICO PAOLA GIANNOTTI DONNARUMMA Chairwoman Chief Executive Officer Director Director Director M M M M m Non-executive Executive Non-executive Non-executive Non-executive Independent as Not independent Independent Independent Independent per the CLF MARCO GIORGINO HE YUNPENG GABRIELLA PORCELLI ALESSANDRA FAELLA ANTONELLA BALDINO Director Director Director Director Director m M m M M Non-executive Non-executive Non-executive Non-executive Non-executive Independent Independent Independent Independent Independent ERNESTO CARBONE VALENTINA CANALINI JEAN-MICHEL AUBERTIN Director Director Director M M m Non-executive Non Esecutivo Non-executive Independent Indipendente ai Independent sensi del TUF M = Majority slate; m = Minority slate. -

La Nuova Era Della Comunicazione Influencer
IMPRENDITORI, MANAGER, COMUNICATORI ECCO LE NUOVE CLASSIFICHE DEL POTERE l’attimoN. 42 - Luglio 2019 fuggentedirettore Cesare Lanza LA NUOVA ERA DELLA COMUNICAZIONE Patrizia Grieco INFLUENCER www.lamescolanza.com Separatori.qxp_Layout 1 27/10/16 13:02 Pagina 3 l’attimo fuggente Direttore Responsabile Cesare Lanza Direttore editoriale Antonio Eustor l’attimo fuggente rivista bimestrale, n. 42 / Luglio 2019 L’Attimo Fuggente Editore, direzione, redazione, amministrazione: Via Marcello Prestinari, 13 00195 Roma – tel. 06.93574813 [email protected], www.attimo-fuggente.com Stampato dalla Tipografia CTR Via delle Idrovore della Magliana, 181 - 00148 Roma Tel. 329.5389733 www.tipografiactr.it Per gli abbonamenti: annuale 120? - Iban IT30R0103003217000001244481; Via Marcello Prestinari, 13 00195 Roma Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale D.L.353/03 70%Roma Aut C/RM/41/2407 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA – N°242\2007 DEL 12 GIUGNO 2007 sommario INTRODUZIONE 4 Comunicazione, decadenza senza fine e chiunque diventa testimone e cronista esplodono gli influencer ............ 4 LA LUNA SPENTA Corrado Calabrò 9 INSTAGRAM: TOP 10 BRAND AUTOMOBILISTICI NEL MONDO 11 INSTAGRAM: TOP 10 FITNESS INFLUENCERS NEL MONDO 16 INSTAGRAM: TOP 10 PIU’ SEGUITI IN ITALIA 21 INSTAGRAM: TOP 10 PIU’ SEGUITI NEL MONDO 26 INSTAGRAM: TOP 10 ACCOUNT TRAVEL NEL MONDO 31 TWITTER: TOP 10 PIU’ SEGUITI IN ITALIA 36 TWITTER: TOP 10 PIU’ SEGUITI NEL MONDO 41 IL GOTHA DELL’ECONOMIA 47 Quelli che determinano il destino dell’Italia.......................... 47 2 IL TOP DELL’ECONOMIA 69 Quelli che detengono importanti posizioni di potere............... 69 MANAGERS & AMMINISTRATORI 109 I GRANDI COMUNICATORI 133 Specialisti dell’immagine e delle relazioni ........................... -

REPORT on CORPORATE GOVERNANCE and OWNERSHIP STRUCTURES TERNA S.P.A
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES TERNA S.p.A. TRADITIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MODEL Transmitting energy REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES TERNA S.p.A. TRADITIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MODEL Issuer: «Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (Terna S.p.A.) Website: www.terna.it Reporting period: 2016 Date of approval: 15 March 2017 Contents 06 Executive Summary 16 Report on corporate governance and ownership structures 6 Report on corporate governance and ownership structures 2016 EXECUTIVE SUMMARY Structure and members of bodies SHAREHOLDERS’ MEETING Board of Directors CHAIRWOMAN DIRECTORS Catia Bastioli Cesare Calari Carlo Cerami CHIEF EXECUTIVE Fabio Corsico OFFICER Matteo Del Fante Luca Dal Fabbro Yunpeng He Gabriella Porcelli SECRETARY Filomena Passeggio Stefano Saglia Remuneration Committee - Chairman Audit and Risk, Corporate Governance and Sustainability Committee - Chairman Appointments Committee - Chairman Related-Party Transactions Committee - Chairman Members of the Committees Board of Statutory Auditors CHAIRMAN STANDING AUDITORS ALTERNATE AUDITORS Riccardo Enrico Maria Schioppo Vincenzo Simone Raffaella Annamaria Pagani Maria Alessandra Zunino Cesare Felice Mantegazza de Pignier Renata Maria Ricotti Audit Company PricewaterhouseCoopers S.p.A. Executive Summary 7 Terna's Shareholders Terna's share capital at December 31, 2016 amounted to € 442,198,240 fully paid up, represented by 2,009,992,000 ordinary shares, with a par value of € 0.22 each, and was unchanged at the date of this Report. With reference to the above share capital and on the basis of the shareholder register, of the communications received under the terms of the Issuer Regulation and of the information available, the stakes in Terna’s shareholdings of an amount over the significance thresholds specified by CONSOB at 31 December 2016, are shown in the chart below. -

ENERGY IS OUR RESPONSIBILITY 2018 Annual Report Integrated Report OUR MISSION
Terna S.p.A. and Terna Group S.p.A. and Terna Terna Annual Report Report - Integrated 2018 ENERGY IS OUR RESPONSIBILITY 2018 Annual Report Integrated Report OUR MISSION Energy is our responsibility. Responsibility is our energy. To play a leading role in the coming sustainable energy transition, by leveraging our distinctive innovation capabilities, competencies and technologies for the benefit of all stakeholders. We are a major operator of grids used to transport energy. We manage the high-voltage transmission of electricity in Italy, ensuring security, quality and cost-effectiveness over time. We are working hard on development of the electricity grid, the achievement of ongoing improvements in operational efficiency and integration with the European grid. We guarantee equal access to all grid users. We are developing Non-regulated Activities and new business opportunities, building on the experience and technical expertise gained in managing complex systems and on our technological excellence. The ongoing energy transition towards an increasingly sustainable electricity system poses new challenges and opportunities. Terna is at the centre of this process of achieving decarbonisation goals, guaranteeing the security of the system and minimising the total cost for Italian households and businesses. This commitment will gain momentum with the objectives set out in the Strategic Plan 2019-2023, which provides for investment in expanding the national electricity grid in order to respond to the new needs of the system. In this process, innovation, digital transformation and people underpin our strategy. The quest for innovative solutions and technologies to be used in managing and developing the national transmission grid is one of the enabling factors for dealing with the growing complexity of the system. -

Bilancio Consuntivo
BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2010 (approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 18 aprile 2011) Fondazione Cassa di Risparmio di Torino pag.2 Principali risultati del 2010 Proventi totali 161 milioni di euro (172 milioni di euro con il risultato della gestione straordinaria) Avanzo dell’esercizio 161 milioni di euro Patrimonio netto 2.858 milioni di euro Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 5,7% Erogazioni deliberate nell’esercizio 123 milioni di euro Fondo stabilizzazione delle erogazioni 167 milioni di euro Accantonamento al Fondo per il Volontariato 4,3 milioni di euro Numero richieste esaminate 3.337 Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 96 milioni di euro Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 6,4% (Sistema fondazioni: 9,3%; Fondazioni Grandi: 7,2%) pag. 3 ORGANI DELLA FONDAZIONE ......................................................................................... 5 RELAZIONE SULLA GESTIONE ........................................................................................ 8 RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA .................................................................... 8 IL BILANCIO DI MISSIONE ............................................................................................ 34 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010 ......................................................... 70 SCHEMI DI BILANCIO .......................................................................................................... 70 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO .................................................................... -

Fabio Corsico
Fabio Corsico Fabio Corsico was born in Turin on 20 October 1973. He achieved a secondary school diploma in Classical Studies (46/60) and graduated in Political Sciences (110/110). In 1997, he worked at the Italian Ministry of Defence, Office of the Diplomatic Councillor for the Minister, Beniamino Andreatta, dealing with the preparation of international dossiers, and at the Military Centre for Strategic Studies. Between 1998 and 2001 he worked for Olivetti/Mannesmann, firstly in Ivrea and then in Rome, and at Infostrada in the communication and HR sectors, until taking the role of head of Public Affairs. During this period he represented the company in Assinform (Italian Association for Information Technology) and AIP (Italian Association for Industrial Policies). In 2001 he worked for the Economy and Finance Ministry as Head of the Technical Secretariat of the Minister Giulio Tremonti. During this period he was also a member of the Committee for the introduction of the Euro. In autumn 2003, he was hired by Enel as Head of Institutional and Territorial Affairs and of the relations with Confindustria. Since February 2005, he has been the Director of External Relations, Institutional Affairs and Development for the Caltagirone Group. For the Caltagirone Holding he also deals with regulatory issues for the Group’s companies and oversees the various industrial and financial holdings. He is a member of the Board of Directors of Cementir Holding, of “Il Gazzettino”, of Terna and of NTV. He has been Senior Advisor at Credit Suisse AG for Italy since 2009. In 1998, he edited the book “Interessi nazionali e identità italiana” (National interests and Italian identity) for the publishing company Franco Angeli in the Studi Strategici (Strategic Studies) series, and in 2011, together with Paolo Messa, he was the author of “Da Frankenstein a principe azzurro, breve storia delle fondazioni bancarie” (From Frankenstein to Prince Charming, a brief history of banking foundations) for Marsilio, with a preface by Carlo Azeglio Ciampi. -
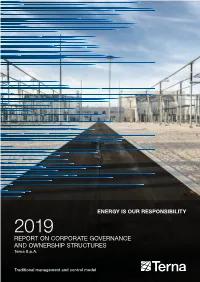
2019 REPORT on CORPORATE GOVERNANCE and OWNERSHIP STRUCTURES Terna S.P.A
ENERGY IS OUR RESPONSIBILITY 2019 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES Terna S.p.A. Traditional management and control model Report on Corporate Governance and Ownership Structures Terna S.p.A. Traditional management and control model Issuer: «Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (in abbreviated form TERNA S.p.A.) Website: www.terna.it/en Annual reporting period to which the Report refers: 2019 Date of approval of the Report: 10 March 2020 After the date of approval of this Report, and in view of the current health emergency linked to the Covid-19 epidemic and the legislation introduced in order to contain the outbreak, the Company has announced a new date for Terna S.p.A.’s Annual General Meeting, which is now scheduled for 18 May 2020. 2019 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES | TERNA S.P.A. 1 TERNA S.P.A. | 2019 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES Executive Summary 4 2019 Report on Corporate Governance and Ownership Structures 20 2019 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES | TERNA S.P.A. Executive Summary Structure and composition of corporate bodies BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE Catia Luigi Paolo Yunpeng Elena Bastioli Ferraris Calcagnini He Vasco Chairwoman Chief Executive Officer Director Director Director M M M M M Non-executive Executive Non-executive Non-executive Non-executive Independent as Not independent Not independent Not independent Independent as per the per the CLF CLF and the Corporate Governance Code Fabio Gabriella Paola Marco Corsico Porcelli Giannotti Giorgino Director Director Director Director M m m m Non-executive Non-executive Non-executive Non-executive Independent as per the Independent as per the Independent as per the Independent as per the CLF and the Corporate CLF and the Corporate CLF and the Corporate CLF and the Corporate Governance Code Governance Code Governance Code Governance Code M = Majority slate; m = Minority slate 4 TERNA S.P.A.