Guida Degli Archivi Capitolari D'italia. II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thecupof the New Covenant
MISSIONARIES OF THE PRECIOUS BLOOD The No. 37 - October 2014 Cofup the New Covenant Living a Consecrated Life by William Nordenbrock, C.PP.S. he Church has declared 2015 a year dedicated to a celebration Tof Consecrated Life. This issue of The Cup of the New Covenant anticipates that commemoration and we hope that this issue will be a cata- lyst for personal and communal re - flection on how we live the consecrat- ed life as incorporated members and how the lay faithful who associate with us, share in the call to holiness in their own particular way. In this issue Robert Schreiter provides a foundation for our reflection with a brief historical sketch of the Congre - gation as a Society of Apostolic Life and then shines the light of the Apostolic Exhortation Evangelii Gau - on the three pillars of the So - dium ciety: mission, community and spiri- tuality. Barry Fischer continues to See page 16 Meeting in Tanzania reflects the multicultural face of the C.PP.S. The C.PP.S. as a Society of Apostolic Life by Robert Schreiter, C.PP.S. 1 Francis’ Call to Religious The C.PP.S. as a Society by Barry Fischer, C.PP.S. 5 of Apostolic Life The Gift of Joy: The Challenge of Consecrated by Robert Schreiter, C.PP.S. Life in Latin America by Angelmiro Granados, C.PP.S. 8 INTRODUCTION in the Western Church. In the Middle The challenge Consecrated Life has taken on many Ages, groups of diocesan priests gath- of living evangelical poverty ered around collegiate churches as for the service of the poor forms through the course of the by Walter Milandu, C.PP.S. -

Virtue Program Strengthens Athletes Accident Victim Advocated for Catholic Schools Page 4
Serving the Diocese of Fort Wayne-South Bend April 29, 2018 Child protection Parental FAQs/Pope hears ’’ from commission ODAYODAYSS ATHOLICATHOLIC Pages 2, 3 TT CC Volume 92 No. 17 50¢ TODAYSCATHOLIC.org Southwest Airlines Virtue program strengthens athletes accident Victim advocated for Catholic schools Page 4 ‘The Dating Project’ Documentary reintroduces singles to dating skills Page 8 Faith and determination Gifts go hand in hand for mother and daughter following injury Page 9 Provided by Bishop Luers High School St. Vincent de Paul Bishop Luers High School football team members gathered in the Chapel of Saint Francis of Assisi earlier this school year to present letters, which were read Society of aloud, and roses to their mothers. Ceremonies like this one, in Fort Wayne, are components of a comprehensive Catholic school sports culture program called St. Joseph County SportsLeader, which devotes itself to encouraging virtuous behavior among student athletes. Dinner underscores value of BY DEB WAGNER Painting of saint blessed safety-net organizations wo years ago Bishop Luers Bishop Kevin C. Rhoades Page 11 High School Principal Jim THuth, who was assistant venerates a relic of St. José principal at the time, attended Sánchez del Río at Our a SportsLeader conference in Cincinnati, Ohio, to learn about Lady of Guadalupe Church, the Catholic, virtue-based for- Warsaw, April 8. The bishop mation program for coaches. He became eager to bring it the Fort conferred the sacrament Wayne school, and at the begin- of confirmation to candi- ning of the 2017-18 school year it was implemented. dates at the parish and then Athletic programs at Bishop Luers have long incorporated the blessed a painting of the Catholic faith, but SportsLeader recently canonized Mexican offers an intentional way for student-athletes to grow their martyr, seen behind him. -

Andrés Bello: La Pasión Por El Orden
Fundación Ignacio Larramendi Andrés Bello: La pasión por el orden IMAGEN DE CHILE Fundación Ignacio Larramendi © 2001, IVÁN JAKSIC´ ANDRADE. Inscripción Nº 119.537, Santiago de Chile. Derechos reservados para los territorios de habla castellana por © EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A. María Luisa Santander 0447. Fax 56-2-2099455 Santiago de Chile. www.universitaria.cl Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o electrónicos, incluidas las fotocopias, sin permiso escrito del editor. ISBN 956–11–1577-8 Texto compuesto en tipografía Bembo 11/13 Se terminó de imprimir esta PRIMERA EDICIÓN de 1.000 ejemplares, en los talleres de Imprenta Salesianos, General Bulnes 19, Santiago de Chile, en octubre de 2001. DISEÑO Jorge Flores P. IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE Fundación Ignacio Larramendi A la memoria de William Lewers, C.S.C. Fundación Ignacio Larramendi Grabado en acero realizado por J. M. Macrae, 1846. Fundación Ignacio Larramendi Iván Jaksic´ A. Andrés Bello: La pasión por el orden Universidad de Chile EDITORIAL UNIVERSITARIA Fundación Ignacio Larramendi Ya dos generaciones de mortales habían perecido mientras que él estaba aún con vida, los cuales juntos a él, anteriormente se habían criado y nacieran en Pilo muy divina, y él era el rey de los de la tercera HOMERO, La Ilíada, I, 250 Fundación Ignacio Larramendi ÍNDICE Prefacio 13 Prólogo 17 Nota sobre las Obras completas de Andrés Bello 27 I. LA FORMACIÓN DE UN INTELECTUAL EN LA COLONIA, 1781-1810 29 La educación de Bello 33 Bolívar y Humboldt 35 Funcionario de gobierno 38 La Junta Central de Vacuna 39 La Gazeta de Caracas 41 Los eventos de 1810 45 El perfil intelectual y político de Bello 48 II. -

1 Santo Spirito in Florence: Brunelleschi, the Opera, the Quartiere and the Cantiere Submitted by Rocky Ruggiero to the Universi
Santo Spirito in Florence: Brunelleschi, the Opera, the Quartiere and the Cantiere Submitted by Rocky Ruggiero to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Art History and Visual Culture In March 2017. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. (Signature)…………………………………………………………………………….. 1 Abstract The church of Santo Spirito in Florence is universally accepted as one of the architectural works of Filippo Brunelleschi (1377-1446). It is nevertheless surprising that contrary to such buildings as San Lorenzo or the Old Sacristy, the church has received relatively little scholarly attention. Most scholarship continues to rely upon the testimony of Brunelleschi’s earliest biographer, Antonio di Tuccio Manetti, to establish an administrative and artistic initiation date for the project in the middle of Brunelleschi’s career, around 1428. Through an exhaustive analysis of the biographer’s account, and subsequent comparison to the extant documentary evidence from the period, I have been able to establish that construction actually began at a considerably later date, around 1440. It is specifically during the two and half decades after Brunelleschi’s death in 1446 that very little is known about the proceedings of the project. A largely unpublished archival source which records the machinations of the Opera (works committee) of Santo Spirito from 1446-1461, sheds considerable light on the progress of construction during this period, as well as on the role of the Opera in the realization of the church. -

Il Caso Di Don Tonino Bello
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE L’ANTIMAFIA ETICA: IL CASO DI DON TONINO BELLO Elaborato finale di: Valeria Biasco Relatore: Prof. Fernando dalla Chiesa Anno Accademico 2014 / 2015 ! 1! A Seba, il mio angelo biondo. ! 2! “L’etica è il primo argine all’illegalità. Nei contesti professionali non può mai essere vista come un <<di più>>: non è un obiettivo fra gli altri, ma ciò che deve fare da sfondo a ogni progetto, a ogni investimento e scelta strategica. Essa è il fine di un’attività professionale, raggiungibile solo se le persone che coinvolge (i dipendenti, i collaboratori) sono a loro volta fine, e mai strumento. Il nostro lavoro è <<etico>> quando non presta il fianco ai compromessi, alle scorciatoie, alle prepotenze di chi vuole calpestare i diritti in nome del privilegio. Dunque, non solo <<etica delle professioni>>, ma etica come professione di tutti” don Luigi Ciotti ! 3! Indice 6 INTRODUZIONE Capitolo primo: 10 IL RAPPORTO TRA DON TONINO BELLO E LA SOCIETÀ: UN APOSTOLATO SENZA CONFINI 11 1.1: Il rapporto tra la chiesa e la comunità 23 1.2: L’impegno quotidiano con i più deboli 29 1.3: L’attenzione costante ai giovani Capitolo secondo: 37 LA TESTIMONIANZA LOCALE DI DON TONINO BELLO 37 2.1: La responsabilità dell’impegno: continuità, condivisione e corresponsabilità 42 2.2: Tre casi di impegno civile e sociale: 42 • Casa per la Pace e La Meridiana 46 • Comunità di Accoglienza, Solidarietà e Amicizia Capitolo Terzo: 50 DAVANTI ALLA CRIMINALITA’ PUGLIESE 53 3.1: La criminalità pugliese fino agli anni Ottanta 59 3.2: La nascita -
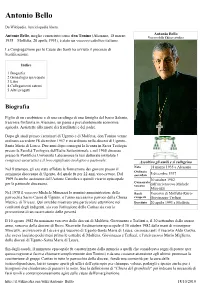
Antonio Bello
Antonio Bello Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Antonio Bello Antonio Bello, meglio conosciuto come don Tonino (Alessano, 18 marzo Vescovo della Chiesa cattolica 1935 – Molfetta, 20 aprile 1993), è stato un vescovo cattolico italiano. La Congregazione per le Cause dei Santi ha avviato il processo di beatificazione. Indice 1 Biografia 2 Genealogia episcopale 3 Libri 4 Collegamenti esterni 5 Altri progetti Biografia Figlio di un carabiniere e di una casalinga di una famiglia del basso Salento, trascorse l'infanzia in Alessano, un paese a prevalentemente economia agricola. Assistette alla morte dei fratellastri e del padre. Dopo gli studi presso i seminari di Ugento e di Molfetta, don Tonino venne ordinato sacerdote l'8 dicembre 1957 e incardinato nella diocesi di Ugento- Santa Maria di Leuca. Due anni dopo conseguì la licenza in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e nel 1965 discusse presso la Pontificia Università Lateranense la tesi dottorale intitolata I congressi eucaristici e il loro significato teologico e pastorale. Ascoltino gli umili e si rallegrino Nato 18 marzo 1935 a Alessano Nel frattempo, gli era stata affidata la formazione dei giovani presso il Ordinato seminario diocesano di Ugento, del quale fu per 22 anni vice-rettore. Dal sacerdote 8 dicembre 1957 1969 fu anche assistente dell'Azione Cattolica e quindi vicario episcopale 30 ottobre 1982 per la pastorale diocesana. Consacrato vescovo dall'arcivescovo Michele Mincuzzi Nel 1978 il vescovo Michele Mincuzzi lo nominò amministratore della Ruoli Vescovo di Molfetta-Ruvo- parrocchia Sacro Cuore di Ugento, e l'anno successivo parroco della Chiesa ricoperti Giovinazzo-Terlizzi Matrice di Tricase. -

Catalogo Librario Per Titoli.Pdf
1 Elenco del patrimonio librario della Biblioteca "Don Peppino Lannia" ( per titoli e in corso di aggiornamento) C.° inv. Autore Titolo Gen. N° Sez. Collocazione C. 2068 George Orwell 1984 C.Str.139 Sez.2 Scaffale B C. 2763 Aleksandr Solzenitsyn ago-14 R.Str.625 Sez. 2 Scaffale C C. 1736 Ugo Piscopo Bigiaretti libero R.Ita.360 Sez.1 Scaffale B C. 1452 CEI Roma/Milano I protagonisti della Storia Universale numero 5 R.Ita.066 Sez.1 Scaffale B C. 1780 Giorgio Scerbanenco I ragazzi del Massacro R.Ita.404 Sez.1 Scaffale B C. 1453 Alessandro de Stefani La crociera del "Colorado" R.Ita.067 Sez.1 Scaffale B C. 1684 Enzo Biagi "I" come italiani R.Ita.297 Sez.1 Scaffale B C. 0719 D.L. e Larry Collins "Pargi Brugia?" Sto.046 Sez.2 Scaffale A C. 1228 Alberto Moravia /1934 C.Ita.136 Sez.4 Scaffale A C. 0144 Francesco Deliziosi < 3 P > Padre Pino Pugliesi Re.144 Sez.1 Scaffale A C. 0650 Quaderni cenac 3 …e lasciate che le reti lo seguirono Re.650 Sez.2 Scaffale A C. 2697 John Gardner 007- Vendetta privata R.Str.559 Sez.1 Scaffale C C. 2064 Agatha Christie 10 piccoli indiani C.Str.135 Sez.2 Scaffale B C. 3038 Q8 100 itinerari italiani Turismo.026 Sez.3 Scaffale C C. 1907 Enzo Biagi 1935 e dintorni R.Ita 531 Sez.2 Scaffale B C. 0716 Paola Pavolini 1943, La Caduta del Fascismo - 1 Sto.043 Sez.2 Scaffale A C. 0785 P.Pavolini 1943-la caduta del fascismo 2-la fuga dei Savoia Sto.124 Sez.3 Scaffale A C. -

Goes Virtual
JUNE 28TH - JULY 2ND, 2021 POWER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS GOES VIRTUAL 1 JUNE 28TH - JULY 2ND, 2021 POWER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS GOES VIRTUAL CONTENTS WELCOME FROM CONFERENCE CHAIRS I Pag. 3 ORGANIZING COMMITTEES I Pag. 4 PROGRAM AT A GLANCE I Pag. 7 OPENING CEREMONY I Pag. 11 PLENARY SESSIONS I Pag. 12 SPECIAL SESSIONS I Pag. 13 EUROPEAN PROJECT SESSIONS I Pag. 18 TUTORIALS I Pag. 21 DETAILED PROGRAM I Pag. 28 MONDAY, June 28th I Pag. 28 TUESDAY, June 29th I Pag. 40 WEDNESDAY, June 30th I Pag. 52 THURSDAY, July 01st I Pag. 64 SUPPORTING COMPANIES I Pag. 76 JUNE 28TH - JULY 2ND, 2021 POWER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS GOES VIRTUAL WELCOME TO THE 14TH IEEE POWERTECH We welcome all participants to the 2021 IEEE Madrid PowerTech conference. Sincere thanks to all Authors that made this conference possible by means of their Finally, despite our initial hope to celebrate Power Tech in person in Madrid, participation and papers. Despite uncertainties and challenging circumstances the pandemic made it impossible. In any case, we wish all of you a fruitful and due to the pandemic, we received 532 paper submissions from 49 different participative conference! countries worldwide. This overwhelming response required organizing a careful and time-demanding review process in which the support of all the members of PowerTech is the anchor conference of IEEE PES in Europe. It provides a forum for the International Steering Committee, the International Advisory Committee, the engineers and scientists in electric power and energy systems to present their work Basil Papadias Award Committee, and the contributions of about 740 reviewers Prof. -

St. Joseph Catholic Church Iglesia Católica San José
ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH fàAGLESIA ATÓLICA AN OSÉ ]ÉáxÑ{I C S J APRIL 30, 2017 30 DE ABRIL. 2017 CONTACT INFORMATION Address .............. 1115 College Avenue, Conway, AR 72032 Phone .............................(501) 327-6568 E-Mail .................... [email protected] Hispanic Min ... [email protected] Website ....................... www.sjparish.org Diocese of Little Rock ......www.dolr.org WEEKEND MASSES/MISAS Saturday /Sábado ..................... 4:00 pm Sunday /Domingo ................... 8:00 am, WEEKDAY MASSES/ ROSARY/ROSARIO 10:30 am, 5:00 pm MISAS DE SEMANA Sunday in Church 7:35 am Mon. & Fri./Lun. & Vier .. 12:15 pm Spanish/Español .................... 12:30 pm Tues. & Thur./Mar. & Juev 6:00 pm DEVOTIONS TO OUR MOTHER Wed./Mier ............................. 9:00 am OF PERPETUAL HELP/ Anointing of the Sick, after Mass DEVOCION A NUESTRA MADRE 1st Friday & Saturday Only DEL PERPETUO SOCORRO Unción de los Enfermos Solo después Tuesday/Martes after the 6:00 pm Mass Third Sunday of Easter de 1er Misa de Viernes & Sábado de mes 1st Friday of the Month/ er er PERPETUAL ADORATION 3 Domingo de Pascua 1 Viernes del mes .............. 12:15pm 24 hours a day in the Adoration Chapel 1st Saturday of the month/ 1er Sábado del mes ................. 9:00am ADORACIÓN AL SANTISIMO Las 24 horas al día en la Capilla CONFESSION/CONFESIONES Tuesday & Thursday/Martes & Jueves 5:00-5:55 pm Saturday/Sábado 8:00-9:00 am 2 WELCOME to ST. JOSEPH’S PARISH St. Joseph’s is a Catholic Christian Faith Community whose mission is to evangelize people to Christ. In doing this, we are guided by the Holy Spirit through prayer, sacraments, and diverse charisms. -

C:\Users\Eileend.STKILIAN\Documents\6-4
Sunday, June 4, 2017 Saint Kilian Parish 485 Conklin Street, Farmingdale, NY 11735 MISSION STATEMENT The Catholic family of St. Kilian Parish seeks to be a vibrant, welcoming community of faith, guided by the Holy Spirit, nourished by God’s word and the Eucharist, and committed to witnessing God in and through our neighbors. PASTORAL TEAM THE ST. KILIAN VISION STATEMENT Rev. Bruce J. Powers, Pastor - + Hospitality: St. Kilian parish strives to be a [email protected] welcoming, dynamic faith community. Rev. Michael F. Duffy, Parochial Vicar - [email protected] + The Eucharist and liturgy: We seek to nourish the Mrs. Claire Stiglic, Associate Director Religious faith life of the parish by celebrating meaningful Education liturgies, and offering opportunities for a wide range Mrs. Kathleen Singleton, Associate Director of prayerful experiences. Religious Education - Mrs. Nina Petersen, Social Ministry/Outreach + Lifelong Faith Formation: We are dedicated to Mr. Paul C. Phinney, Music Director - inspiring the young and the old through lifelong Mr. Edward Fronckwicz - Business Manager education, and formation of minds and hearts. Mrs. Barbara Geary, Director of Stewardship / Pastor’s Secretary + Stewardship: In all aspects of our faith we share our time, talent, and treasure through stewardship. HISPANIC MINISTRY Rev. José Luis Tenas + Parish Social Ministry: We bring our faith to life by serving others through compassionate personal RETIRED CLERGY IN RESIDENCE outreach and commitment to social justice. Most Rev. John C. Dunne Rev. Augustine Fernando DEACONS SCHEDULE OF MASSES Deacon Frank D. Barone SATURDAY EVENING: 5:00p.m. Deacon Francis P. Marino MISAS EN ESPAÑOL: 6:30 p.m. Saturday Cada Sábado Deacon Mark Wetzel SUNDAY: 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m. -

Pope Commemorates Life of Beloved Italian Bishop Who Served Poor
Pope commemorates life of beloved Italian bishop who served poor The church needs courageous men and women like Italian Bishop Antonio Bello of Molfetta, who imitated Jesus’ closeness to the poor and the downtrodden, Pope Francis said. Visiting the birthplace of the beloved bishop affectionately known as “Don Tonino,” the pope said Bishop Bello’s life and ministry “remind us to not theorize closeness to the poor but to be close to them as Jesus did.” “Don Tonino did not do this because it was convenient or because he was seeking approval, but because he was moved by the Lord’s example. Out of love for him, we find the strength to rid ourselves of the garments that get in the way so that we can dress ourselves in service, to be ‘the church of the apron, which is the only priestly vestment recorded in the Gospel,'” he said April 20. Pope Francis arrived in the morning by helicopter in the town of Alessano, located in the southern Italian province of Lecce, where Bishop Bello was born and buried. Landing near the town’s cemetery, the pope carried a bouquet of white lilies and yellow sunflowers and laid them in front of the bishop’s tomb. Surrounded by palm trees and an olive tree adorned with rosaries and multicolored peace flags, Pope Francis spent nearly five minutes praying silently. He also prayed in front of the tomb of the bishop’s parents, who were buried nearby. Born in 1935, Don Tonino spent his first years of priestly ministry as vice rector of a seminary while collaborating with the Catholic charitable organization, Caritas. -

Dolentium Hominum N
DOLENTIUM HOMINUM N. 54 – Year XVIII – No. 3, 2003 JOURNAL OF THE PONTIFICAL COUNCIL FOR HEALTH PASTORAL CARE CARDINAL JAVIER LOZANO BARRAGÁN, Editor-in-Chief CORRESPONDENTS BISHOP JOSÉ L. REDRADO, O.H., Executive Editor REV.FELICE RUFFINI, M.I., Associate Editor REV. MATEO BAUTISTA, Argentina MONSIGNOR J. JAMES CASSIDY, U.S.A. REV.RUDE DELGADO, Spain REV.RAMON FERRERO, Mozambique REV.BENOIT GOUDOTE, Ivory Coast EDITORIAL BOARD PROFESSOR SALVINO LEONE, Italy REV. JORGE PALENCIA, Mexico REV. CIRO BENEDETTINI REV. GEORGE PEREIRA, India DR. LILIANA BOLIS MRS.AN VERLINDE, Belgium SR.AURELIA CUADRON PROFESSOR ROBERT WALLEY, Canada REV. GIOVANNI D’ERCOLE, F.D.P. DR. MAYA EL-HACHEM REV. GIANFRANCO GRIECO REV. BONIFACIO HONINGS EDITORIAL STAFF MONSIGNOR JESÚS IRIGOYEN REV.JOSEPH JOBLIN DR. COLETTE CHALON REV. VITO MAGNO, R.C.I. MRS.STEFANIA CASABIANCA DR. DINA NEROZZI-FRAJESE DR. ANTONELLA FARINA DR. FRANCO PLACIDI DR. MATTHEW FFORDE REV. LUCIANO SANDRIN REV.BERNARD GRASSER, M.I. MONSIGNOR ITALO TADDEI DR.GUILLERMO QWISTGAARD Editorial and Business Offices: PONTIFICAL COUNCIL FOR HEALTH PASTORAL CARE VATICAN CITY; Tel. 06-6988-3138, 06-6988-4720, 06-6988-4799, Fax: 06-6988-3139 www.healthpastoral.org - e-mail: [email protected] Published three times a year. Subscription rate: 32 for Europe, 30 $ for countries outside Europe, € postage included Printed by Editrice VELAR, Gorle (BG) Cover: Glass window Rev. Costantino Ruggeri Spedizione in a.p. - art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Roma Contents 4 XII World Day of the Sick TOPICS Programme 14 Respect and Lack of Respect 5 Message of His Holiness for the Disabled Person John Paul II for the in Contemporary Culture Twelfth World Day of the Sick H.Em.