Vp Vita E Pensiero
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Repertorium Der Steierischen Mã¼nzkunde
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin- nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. Nutzungsrichtlinien Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. -

Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian
Epidamnus S tr Byzantium ym THRACE on R Amphipolis A . NI PROPONTIS O Eion ED Thasos Cyzicus C Stagira Aegospotami A Acanthus CHALCIDICE M Lampsacus Dascylium Potidaea Cynossema Scione Troy AEOLIS LY Corcyra SA ES Ambracia H Lesbos T AEGEAN MYSIA AE SEA Anactorium TO Mytilene Sollium L Euboea Arginusae Islands L ACAR- IA YD Delphi IA NANIA Delium Sardes PHOCISThebes Chios Naupactus Gulf Oropus Erythrae of Corinth IONIA Plataea Decelea Chios Notium E ACHAEA Megara L A Athens I R Samos Ephesus Zacynthus S C Corinth Piraeus ATTICA A Argos Icaria Olympia D Laureum I Epidaurus Miletus A Aegina Messene Delos MESSENIA LACONIA Halicarnassus Pylos Sparta Melos Cythera Rhodes 100 miles 160 km Crete Map 1 Greece. xvii W h i t 50 km e D r i n I R. D rin L P A E O L N IA Y Bylazora R . B S la t R r c R y k A . m D I A ) o r x i N a ius n I n n ( Epidamnus O r V e ar G C d ( a A r A n ) L o ig Lychnidus E r E P .E . R o (Ochrid) R rd a ic s u Heraclea u s r ) ( S o s D Lyncestis d u U e c ev i oll) Pella h l Antipatria C c l Edessa a Amphipolis S YN E TI L . G (Berat) E ( AR R DASS Celetrum Mieza Koritsa E O O R Beroea R.Ao R D Aegae (Vergina) us E A S E on Methone T m I A c Olynthus S lia Pydna a A Thermaic . -
![An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography](https://docslib.b-cdn.net/cover/8605/an-atlas-of-antient-i-e-ancient-geography-1938605.webp)
An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography
'V»V\ 'X/'N^X^fX -V JV^V-V JV or A?/rfn!JyJ &EO&!AElcr K T \ ^JSlS LIBRARY OF WELLES LEY COLLEGE PRESENTED BY Ruth Campbell '27 V Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofantientieOObutl AN ATLAS OP ANTIENT GEOGRAPHY BY SAMUEL BUTLER, D.D. AUTHOR OF MODERN AND ANTJENT GEOGRAPHY FOR THE USE OF SCHOOLS. STEREOTYPED BY J. HOWE. PHILADELPHIA: BLANQHARD AND LEA. 1851. G- PREFATORY NOTE INDEX OF DR. BUTLER'S ANTIENT ATLAS. It is to be observed in this Index, which is made for the sake of complete and easy refer- ence to the Maps, that the Latitude and Longitude of Rivers, and names of Countries, are given from the points where their names happen to be written in the Map, and not from any- remarkable point, such as their source or embouchure. The same River, Mountain, or City &c, occurs in different Maps, but is only mentioned once in the Index, except very large Rivers, the names of which are sometimes repeated in the Maps of the different countries to which they belong. The quantity of the places mentioned has been ascertained, as far as was in the Author's power, with great labor, by reference to the actual authorities, either Greek prose writers, (who often, by the help of a long vowel, a diphthong, or even an accent, afford a clue to this,) or to the Greek and Latin poets, without at all trusting to the attempts at marking the quantity in more recent works, experience having shown that they are extremely erroneous. -

5ASMOSIA.Pdf
Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009) Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA) Conference (Tarragona 2009) Edited by Anna Gutiérrez Garcia-M. Pilar Lapuente Mercadal Isabel Rodà de Llanza 23 INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA Tarragona, 2012 Biblioteca de Catalunya - Dades CIP Association for the Study of Marble and Other Stones used in Antiquity. International Symposium (9è : 2009 : Tarragona, Catalunya) Interdisciplinary studies on ancient stone : proceedings of the IX Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA) Conference (Tarragona 2009). – (Documenta ; 23) Bibliografi a ISBN 9788493903381 I. Gutiérrez Garcia-Moreno, Anna, ed. II. Lapuente Mercadal, Pilar, ed. III. Rodà, Isabel, 1948- ed. IV. Institut Català d’Arqueologia Clàssica V. Títol VI. Col·lecció: Documenta (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) ; 23 1. Escultura en marbre – Roma – Congressos 2. Construccions de marbre – Roma – Congressos 3. Marbre – Roma – Anàlisi – Congressos 4. Pedres de construcció – Roma – Anàlisi – Congressos 5. Pedreres – Roma – Història – Congressos 904-03(37):552.46(061.3) Aquesta obra recull les aportacions (comunicacions orals i pòsters) que es van presentar durant el IX Congrés Internacional de l’Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA), organitzat per l’ICAC en el marc del programa de recerca HAR2008-04600/HIST, amb el suport del programa d’Ajuts ARCS 2008 (referència expedient IR036826) de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Ciència i Innovació (Accions Complementàries HAR2008- 03181-E/HIST), i celebrat a Tarragona entre el 8 i el 13 de juny del 2009. -

The History and Antiquities of the Doric Race, Vol. 1 of 2 by Karl Otfried Müller
The Project Gutenberg EBook of The History and Antiquities of the Doric Race, Vol. 1 of 2 by Karl Otfried Müller This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: The History and Antiquities of the Doric Race, Vol. 1 of 2 Author: Karl Otfried Müller Release Date: September 17, 2010 [Ebook 33743] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF THE DORIC RACE, VOL. 1 OF 2*** The History and Antiquities Of The Doric Race by Karl Otfried Müller Professor in the University of Göttingen Translated From the German by Henry Tufnell, Esq. And George Cornewall Lewis, Esq., A.M. Student of Christ Church. Second Edition, Revised. Vol. I London: John Murray, Albemarle Street. 1839. Contents Extract From The Translators' Preface To The First Edition.2 Advertisement To The Second Edition. .5 Introduction. .6 Book I. History Of The Doric Race, From The Earliest Times To The End Of The Peloponnesian War. 22 Chapter I. 22 Chapter II. 39 Chapter III. 50 Chapter IV. 70 Chapter V. 83 Chapter VI. 105 Chapter VII. 132 Chapter VIII. 163 Chapter IX. 181 Book II. Religion And Mythology Of The Dorians. 202 Chapter I. 202 Chapter II. 216 Chapter III. 244 Chapter IV. 261 Chapter V. 270 Chapter VI. 278 Chapter VII. 292 Chapter VIII. 302 Chapter IX. -

The Cult of Bendis in Athens and Thrace
GRAECO-LATINA BRUNENSIA 18, 2013, 1 PETRA JANOUCHOVÁ (CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE) THE CULT OF BENDIS IN ATHENS AND THRACE The Thracian goddess Bendis was worshipped in Classical Athens, and her cult became very popular in the 5th and 4th century BC. This article explores the available historiographical and archaeological record of an existing foreign cult within a Greek polis, and compares it to the data from the Thracian inland. As the literary sources limit themselves only to the Greek point of view, a combination of archaeological and epigraphical evidence has to be consulted in the case of Thrace. The aim of this paper is to determine and discuss the uni- formity or potential discrepancies in the presentation of Bendis in the place of her origin, as well as in her new context. The mutual relations between Bendis and her Greek counterpart is not to be omitted. Key words: Bendis, Athens, foreign cults, Attica, Thrace, iconography, nature deity The goddess Bendis is usually seen as a prototypical Thracian deity that was worshipped in Classical Athens from the 5th century BC onwards. The image presented by Greek authors is the most complete and cohesive repre- sentation of any Thracian deity that we have. On the other hand, the sources from the homeland of Bendis are mute or provide slightly confusing infor- mation. The fact that we are without any written literary sources from Thra- ce itself is amplified by discrepancies in the interpretation of archaeological and epigraphical evidence, which lacks uniformity in its study of the com- plexities of Bendis. This article presents a dichotomous image of Bendis, as perceived in Athens and in Thrace itself, and will attempt to coherently portray and understand the nature of the so called Thracian goddess. -

Proceedings of the United States National Museum
THE TrPE-SPECIES OF THE NORTH AMERICAN GENERA OF DIPTERA. By D. W. COQUILLETT, Custodian of Dipfera, U. S. National Museum. The great importance of knowing definitely what species is the type of any given genus is now recognized by practically every worker in the field of biology. For several 3"ears past the writer has been engaged in ascertaining the types of the genera of Diptera reported as occurring in North and Middle America, and the present paper gives the results of these labors. The rules adopted by the Interna^ tional Zoological Congress, as amended at the 1907 (Boston) meeting and the later decisions, published in Science for October 29, 1909, have been followed in all cases. The following rules or articles more especially concern us in the present work: Article 2. "The scientific designation of animals is uninominal for subgenera and all higher groups." A genus or subgenus, to which no species was originally referred by name, dates from its earliest published description or figure. Article 3 specifies that the scientific names of animals must be in Latin or, at least, must be latinized. This excludes certain works where only French or other vernacular names are employed, such as Dumeril's Exposition dime Methode Naturelle, published in 1801; his Considerations Generales, 1823; Schinz's Das Thierreich, 1823, and Latreille's Families Naturelles du Regne Animal, 1825. Article 19. "The original orthography of a name is to be preserved unless an error of transcription, a laj^sux calami, or a typographical error is evident." The so-called emended names are to be regarded only as misspelled names, and as such have no permanent place in the nomenclature. -
11 Morphological Science
BIOCELL ISSN 0327 - 9545 2006, 30(3): 501-529 PRINTED IN ARGENTINA X Argentine Congress of Morphological Sciences (X Congreso Argentino de Ciencias Morfológicas) ABSTRACTS March 15-17, 2006 Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ARGENTINA 502 ABSTRACTS BIOCELL, 30(3), 2006 BIOCELL, 30(3), 2006 ABSTRACTS 503 1. 3. S-100 AND GLIAL FIBRILLARY ACIDIC (GFAP) ELECTRON MICROSCOPY OBSERVATION OF THE PROTEINS: IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS OF BOVINE PARS TUBERALIS (LIGHT-DRAKNESS CYCLE THE FOLLICULO-STELLATE CELLS OF THE Lagostomus 12:12) maximus maximus PITUITARY Alzola R, Felipe A, Solana H, Maiarú ME. Acosta M, Filippa V, Mohamed F. Depto de Cs. Biológicas Fac. Cs. Veterinarias. Unicen. Tandil. Bs. Cátedra de Histología y Embriología, Proyecto 22/Q303 As. Argentina. E-mail: [email protected] Universidad Nacional de San Luis. E-mail: [email protected] The pars tuberalis is a well defined area of the vertebrates adeno- Immunohistochemical techniques has enabling to extend the mor- hypophysis. It consists of cells that can be classified in two groups: phological study of the folliculo-stellate (FS) cells. The pituitary one of follicular cells, and the other one of secretory cells. Secre- gland of viscacha (Lagostomus maximus maximus) exhibits folli- tory cells can divided in two types: one kind of cells that are present cular structures formed by FS cell. The aim of this work was to in other regions of the adenohypophysis, namely “pars distalis like immunohistochemically identify FS cells of pituitary gland using cells” and the other group, that differs ultrastructurally from the anti-S-100 and anti-GFAP antisera. -
1 SPAIN 1 SPAIN 1.1 Hispania 1.1.1 Osicerda
Table 1 List originally created by AE AR EL&AV RP Kenneth Steiglitz 1 SPAIN 1 SPAIN 1.1 Hispania 1.1.1 Osicerda, Hispania 1.2 Hispania Citerior 1.2.1 Emporiae, Hispania Citerior 1.2.2 Rhoda, Hispania Citerior 1.2.3 Kissa, Hispania Citerior 1.2.4 Tarraco, Hispania Citerior 1.2.5 Dertosa, Hispania Citerior 1.2.6 Celsa, Hispania Citerior 1.2.7 Ilercavonia with Dertosa, Hispania Citerior 1.2.8 Ilerda, Hispania Citerior 1.2.9 Osca, Hispania Citerior 1.2.10 Cascantum, Hispania Citerior 1.2.11 Graccurris, Hispania Citerior 1.2.12 Calagurris Julia, Hispania Citerior 1.2.13 Clunia, Hispania Citerior 1.2.14 Segovia, Hispania Citerior 1.2.15 Erala, Hispania Citerior 1.2.16 Ercavica, Hispania Citerior 1.2.17 Segea, Hispania Citerior 1.2.18 Bilbilis, Hispania Citerior 1.2.19 Numantia, Hispania Citerior 1.2.20 Caesaraugusta, Hispania Citerior 1.2.21 Turiaso, Hispania Citerior 1.2.22 Damania, Hispania Citerior 1.2.23 Saguntum, Hispania Citerior 1.2.24 Valentia, Hispania Citerior 1.2.25 Segobriga, Hispania Citerior 1.2.26 Carthago Nova, Hispania Citerior 1.2.27 Illici (Ilici ?), Hispania Citerior 1.2.28 Saetabis, Hispania Citerior 1.2.29 Segisa, Hispania Citerior 1.2.30 Castulo, Hispania Citerior 1.2.31 Acci, Hispania Citerior !1 List originally created by AE AR EL&AV RP Kenneth Steiglitz 1.3 Hispania Ulterior 1.3.1 Corduba, Hispania Ulterior 1.3.2 Obulco, Hispania Ulterior 1.3.3 Abdera, Hispania Ulterior 1.3.4 Sexsi, Hispania Ulterior 1.3.5 Malaca, Hispania Ulterior 1.3.6 Irippo, Hispania Ulterior 1.3.7 Urso, Hispania Ulterior 1.3.8 Ebora, Hispania -

Arqueologia I Història Antiga La Muralla
ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA LA MURALLA REPUBLICANA DE TÀRRACO. ELS SEUS REFERENTS CONSTRUCTIUS D'ÈPOCA HEL·LENISTICA* GUERAU PALMADA 1. INTRODUCCIÓ L'arribada de l'arquitectura militar republicana a Hispània té lloc amb posterioritat a l'inici de la II Guerra Púnica (218-202 aC) que enfrontà romans i cartaginesos en els territoris peninsulars. Un cop vençuda l'amenaça cartagi nesa, s'inicia una important estratègia expansionista de Roma per tenir el domini militar, comercial i econòmic d'Hispània al llarg del segle II aC. És precisament dins del segle II aC i els primers decennis del I aC que es docu menten les primeres fortificacions i muralles urbanes itàliques bastides en terres peninsulars. Les tècniques emprades mostren, tot sovint, una procedèn cia itàlica, encara que hi són presents indicis de les tècniques locals i indíge nes, a més a més d'una destacada influència hel·lenística en el disseny de determinades obres militars. De forma majoritària, aquestes fundacions urba nes i fortificacions de la província de la Hispània Citerior foren posicionades estratègicament al llarg del trajecte de la Via Heraclea: Emporiae, Gerunda, Baetulo, Olèrdola, Tarraco, etc. Aquest article forma part del treball de recerca de tercer cicle universitari Els sistemes defen sius romano-repubUcans de la Hispània Citerior: els casos d'Olèrdola, Emporiae i Tàrraco i la seva confrontació amb les fortificacions de la península itàlica. Recerca dirigida pel Dr Xavier Dupre' (Vicedirector de la Escuela Espafiola) i pel Dr. Xavier Aquilué (Director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Emptiries) i realitzada gràcies a una beca predoctoral de la Escuela EspaRola de Historia y Arqueologia en Roma-CSIC els anys 1998 i 1999. -

Numismata Graeca; Greek Coin-Types, Classified for Immediate Identification
NUMISMATA GRAEGA GREEK GOIN-TYPES CLASSIFIED FOR IMMEDIATE IDENTIFIGATION PHOTAT HHOTIIRRS, PHINTERS, MACON (ihANCe). NUMISMATA GRAEGA GREEK GOIN-TYPES CLASSIFIED FOR IMMEDIATE IDENTIFICATION BY C ANSON TEXT OF PART VI SCIENCE AND THE ARTS ASTRONOMY, SCULPTURE, MUSIC, COMEDY, GAMES, ETC, CRESCENT, STARS, SUN, ZODIAC SIGN OF, STATUES, BELLOWS, LYRES, SISTRUM, SYRINX, TINTINNABULUM, MASKS, ASTRAGALOS. VARIOUS k.NKH, ARM BENT, BALANCE OR SCALES, BOOT, CIPPUS, CROSS, CROWNS, CUNEIFORM STROKES DIADEM, DISK, DOUBLE FLORAL PATTERN, EYES, FISH-SPINE, FOOT, HANDS, HEART, IIOOF OF ANIMAL, HOOK, LABARUM, LABYRINTH, LAMP, LION'S SCALP, MAEANDER SYMBOL, MARKS OF VALUE, MONOGRAM IN WREATH, PARAZONIUM, PENTAGRAM, PEDUM, PINNA NOBILIS, PLAIN REVERSE. PLOUGH, SCARAB, SCEPTRE, SPOKE OF WHEEL, STELE, SWASTIKA, TIARA, UMBRELLA, WHEELS, WING, WITHOUT DENOMINATION OF TYPE (DOUBTFUL), ETC. LONDON KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO., L^ BROADWAY HOIISE, CARTER LANE, E. C. 1916 CJ ph(o GRESGENT Metal Place Obvehse Revebse No. SlZE CRESCENT AND LEAF No. ; GKESCENT AND STAR Metal No. Plack Obversi-: Revehse \Vt. Denom. D.A Pl.ATE R EFEREXCR SlZE Crescent and Slar •21 Populonia. Head of Pallas, Cull face, Y^i. Crescent, horns up- .i\.85 Etruria. towards 1., wearing wards, enclosing star 21 earring, necklace, and of four rays, the whole Athenian iielmet with wilhin a border of dots three crests ; hair half oir the coin ; to the loose ; border of dots. !., outside of this border, are traces of the obverse- typc and border of ano- ther specimen, incuse, also half olV the coin ; the two borders forni langent semicircles. 22 Aes Grave. Wheel of eight spoiies, Crescent; above whicii, star Cenlral each terminating in of eight rays ; bencath, Itali/. -
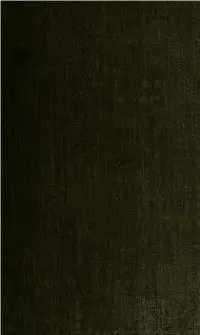
Atlas of Ancient & Classical Geography
mm '> Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofancientclOO EVERYMAN'S LIBRARY EDITED BY ERNEST RHYS REFERENCE ATLAS OF ANCIENT AND CLASSICAL GEOGRAPHY this is no. 451 of ere'Rjr&izdstis LIB%tA CRjT. THE PUBLISHERS WILL BE PLEASED TO SEND FREELY TO ALL APPLICANTS A LIST OF THE PUBLISHED AND PROJECTED VOLUMES ARRANGED UNDER THE FOLLOWING SECTIONS! TRAVEL ^ SCIENCE ^ FICTION THEOLOGY & PHILOSOPHY HISTORY ^ CLASSICAL FOR YOUNG PEOPLE ESSAYS ^ ORATORY POETRY & DRAMA BIOGRAPHY REFERENCE ' ROMANCE THE ORDINARY EDITION IS BOUND IN CLOTH WITH GILT DESIGN AND COLOURED TOP. THERE IS ALSO A LIBRARY EDITION IN REINFORCED CLOTH J. M. DENT & SONS LTD. ALDINE HOUSE, BEDFORD STREET, LONDON, W.C.2 E. P. DUTTON & CO. INC. 286-302 FOURTH AVENUE, NEW YORK ATLAS OF>S ANCIENT Jg & CLASSICAL GEOGRAPHY (EVERY LONDON &.TORONTO PUBLISHED BYJ M DENT &SONS DP &.IN NEWYORK BY E P DUTTON & CO First Issue of this Edition . 1907 Reprinted .... 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, i9*7> 1921, 1925, 1928 1 3"537& Or 1033 A8 All rights reserved PRINTED IN GREAT BRITAIN INTRODUCTION Dr. Butler's atlas, which for a time filled the place in the series taken by this volume, has only been laid aside in response to a demand for better maps, clearer in detail. The new maps are designed to lighten the search for the place-names and the landmarks they contain by a freer spacing and lettering of the towns, fortresses, harbours, rivers and so forth, likely to be needed by readers of the classical writers and the histories of Greece and Rome.