Banditismo E Sequestri Di Persona in Sardegna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Corso Di Formazione Per Operatore Socio Sanitario
UNIONE EUROPEA PROVINCIA DI NUORO Fondo Sociale Europeo Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITÀ 2011-2012 CIG. 4810202044 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO GRADUATORIA RESIDENTI IN PROVINCIA DI NUORO IN ORDINE DI PUNTEGGIO Sono evidenziati in verde gli ammessi alla prova orale Prova 1 Prova 2 Titoli Titoli Valutazione Test Posizione Cognome Nome Data di nascita Luogo residenza Prov residenza Esperienza disoccupazione TOTALE competenze psicoattitudinale (MAX 17 Punti) (MAX 8 punti) (MAX 25 punti) (MAX 30 punti) 1 SANNA MARIA FRANCESCA 08/11/1972 MEANA SARDO NUORO 4,8 4 20 28,23 57,03 2 SALIS PIETRINA 22/03/1978 OLIENA NUORO 5 8 21 22,64 56,64 3 TIDU BARBARA 23/09/1971 TETI NUORO 12,2 8 23 12,33 55,53 4 CURRELI GIUSEPPINA 16/11/1977 ARITZO NUORO 13 1,5 25 15,58 55,08 5 SEDDA MARTA 13/08/1984 OLLOLAI NUORO 12 1,5 25 15,49 53,99 6 CONGIU GIOVANNA MARIA 08/12/1973 SILANUS NUORO 4,8 8 25 15,80 53,60 7 LICHERI BARBARA 29/12/1977 OLZAI NUORO 9 0 25 19,31 53,31 8 SECHI JENNIFER MARIA LUISA 16/11/1980 BORORE NUORO 7,8 8 25 12,34 53,14 9 DELIGIA SALVATORANGELA 29/06/1981 BORORE NUORO 12,4 1,5 25 14,18 53,08 10 MORO ANTONIETTA 30/09/1966 OLZAI NUORO 10 8 23 12,01 53,01 11 MELONI RITA 05/09/1966 ORTUERI NUORO 15,2 8 15 14,68 52,88 12 CARBONI FRANCESCA 31/10/1969 TONARA NUORO 17 8 12 15,64 52,64 13 TALLORU SERGIO MAURO 26/05/1985 TONARA NUORO -

GIS-Based Landscape Analysis of Megalithic Graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2
GIS-based landscape analysis of megalithic graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2 1. Department of History, Cultural Heritage and Territory, University of Cagliari. Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari, Italy. Email: [email protected] 2. Ph.D. Candidate, Doctorado en Historia y Artes – Arquelogía y Cultura Material, Universidad de Granada. Via Is Mirrionis 119, 09121 Cagliari, Italy. Email: [email protected] Abstract: One of the most important megalithic groups in Western Europe in terms of number and characteristics is the group of over 200 monuments of various types in Sardinia. It now seems to be confirmed that the rise of the megalithic phenomenon was during the culture of San Michele of Ozieri (Late Neolithic, 4000-3300 B.C.E.). The Sardinian dolmen graves, however, had a maximum distribution during the Chalcolithic, as evidenced by most of the finds from excavations. The phenomenon also shows a close relationship beyond Sardinia and especially with the monuments of Catalonia, Pyrenees, non-coastal departments of French-midi, Corsica and Puglia. About 90 dolmen graves of various types have been investigated, namely the simple type, “corridor” type, “allée couverte” type, and others of uncertain attribution, located in central-western Sardinia, and particularly in a significant area of ca. 3500 km2 coinciding with the historical regions of Marghine-Planargia, Middle Valley of Tirso and Montiferru. This includes some 40% of all Sardinian dolmens. Locational trends and relationships with regard to landscape elements were studied with the aid of GIS methodologies such as viewshed and cost surface analysis. -

Determinazione ATS N.6235 Del 07/08/2019
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ Proposta n. 6166 del 15/07/2019 STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE Dr.ssa Patrizia Sollai OGGETTO: Convenzione tra l'ATS Sardegna ASSL Nuoro e il Servizio Politiche per l'impresa dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale finalizzata alla prosecuzione nel triennio 2019/2021 dei cantieri occupazionali ai sensi dell'art. 5 comma 13 L.R. N. 5/2015 con integrazioni introdotte dalla L.22/2017 art. 1 comma 7, in attuazione dell'art. 8 comma 45 LR n. 48/2018. Avvio dei progetti presso l'ASSL di Nuoro. Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE Estensore Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu Responsabile del procedimento La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute SI [ ] NO [ X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. SI [ ] NO [ X] Pagina 1 di 6 IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. -

Archivio D'autore: Le Carte Di Fabrizio De André
STRUMENTI CXCIV OSCADELLI M ANO F TE Nella facciata anteriore della sovracoperta: e S Particolare di una stesura, di mano di Fabrizio De André, del testo della canzone Crêuza de ABBRINI (AFDA, G.V.28 [1997, novembre]). F mä ante © «Fondazione Fabrizio De André onlus». ARTA M Nella facciata posteriore della sovracoperta: Fabrizio De André in concerto al Teatro Tenda di Firenze (gennaio 1982). Archivio d’Autore: Fotografia di Lorenzo Maffei. le carte di Fabrizio De André © «Archivio Lorenzo Maffei». Inventario a cura di Inventario Archivio d’Autore: le carte di Fabrizio De André d’Autore: le carteArchivio di Fabrizio Le scansioni dei documenti sono state realizza- te presso l’Università degli studi di Siena, Inventario a cura di Sistema Bibliotecario di Ateneo. MARTA FABBRINI e STE F ANO MOSCADELLI I curatori e l’editore del volume ringraziano Introduzione di la «Fondazione Fabrizio De André onlus» e STE F ANO MOSCADELLI l’«Archivio Lorenzo Maffei» per aver messo gentilmente a disposizione i documenti che R O M A compaiono nelle facciate della sovracoperta. 2012 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI La riproduzione sotto qualsiasi forma di tali DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI documenti non può avvenire senza specifica 2012 autorizzazione da parte degli aventi diritto. PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO STRUMENTI CXCIV STRUMENTI CXCIV 978-88-7125-323-7 N SB I Archivio d’Autore: OSCADELLI M le carte di Fabrizio De André ANO F TE e S ABBRINI Inventario a cura di F MARTA FABBRINI e STE F ANO MOSCADELLI ARTA M Introduzione di STE -

Fabrizio De André
Facoltà di Medicina e Psicologia Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamico-Clinica nell’Infanzia, nell’Adolescenza e nella Famiglia Tesi di Laurea PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ DELLA CANZONE D’AUTORE: FABRIZIO DE ANDRÉ Relatore Prof. Accursio Gennaro Laureando Davide Corradetti Matricola 854256 Anno Accademico 2010/2011 “...per chi viaggia in direzione ostinata e contraria...” INDICE PREMESSA pag. 1 CAPITOLO 1: EVENTI DI VITA E PROFILO DI FABRIZIO DE ANDRÉ pag. 4 1.1 INTRODUZIONE pag. 4 1.2 L'INFANZIA E LA GIOVINEZZA pag. 4 1.2.1 Il periodo nell'Astigiano pag. 5 1.2.2 Il ritorno a Genova pag. 6 1.2.3 Genova per Fabrizio pag. 6 1.2.4 L'educazione paterna ed il rapporto con il fratello Mauro pag. 7 1.2.5 Il primo incontro con Paolo Villaggio pag. 7 1.2.6 La passione per la musica e l'anarchia: Brassens e Stirner pag. 8 1.2.7 Le prime esperienze sessuali, la strada e l'alcol pag. 10 1.3 LA NASCITA DELL'ARTISTA DE ANDRÉ pag. 11 1.3.1 Fabrizio e il periodo con “la Puny” pag. 11 1.3.2 La svolta decisiva e il successo pag. 12 1.3.3 L'importanza di Dori Ghezzi pag. 13 1.4 IL SEQUESTRO NEL 1979 pag. 14 1.5 GLI ULTIMI ANNI pag. 15 1.5.1 La scomparsa del fratello Mauro e il matrimonio con Dori pag. 15 1.5.2 La scoperta di un male incurabile pag. 16 CAPITOLO 2: L'EVOLUZIONE DELL'ARTISTA ATTRAVERSO LO STRUMENTO CANZONE pag. -

Graduatoria Idonei - Eta' Superiore a 25 Anni
Unione Europea Repubblica Italiana REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA Fondo Sociale Europeo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessoradu de su Traballu, Formatzione Professionale, Cooperatzione e Segurantzia Sotziale Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO. - DISOCCUPATI/INOCCUPATI- LOTTO N.8 AZIONE "A" PROV. NUORO Selezione Candidati GRADUATORIA IDONEI - ETA' SUPERIORE A 25 ANNI AGENZIA FORMATIVA EVOLVERE POSIZIONE PUNTEGGIO NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA NOTE GRADUATORIA PROVINCIA DI COMPLESSIVO RESIDENZA (sigla) 1 Sale Loretina 10/10/56 Mamoiada Mamoiada NU 75 2 Ganga Graziano 18/12/57 Nuoro Nuoro NU 70 3 Fele Giovanna Maria 07/09/60 Oliena Oliena NU 70 4 Gioi Anna 27/02/64 Desulo Desulo NU 70 5 Sanna Adriana 23/10/68 Solarussa Ovodda NU 70 6 Sotgiu Antonella 31/05/70 Sorgono Belvì NU 70 7 Zedda Graziella 21/08/71 Tiana Tiana NU 70 8 Picca Enrica 30/09/75 Nuoro Oliena NU 70 9 Moi Milvia 10/01/68 Urzulei Nuoro NU 65 10 Mureddu Tiziana 16/07/74 Austis Austis NU 65 11 Nuvoli Elisa 10/04/76 Nuoro Ollollai NU 65 12 Zoroddu Tonina 24/07/84 Nuoro Ottana NU 65 13 Mura Valentina 11/08/84 Nuoro Silanus NU 65 14 Morittu Giovanna 30/12/84 Nuoro Orotelli NU 65 15 Nieddu Caterina 21/08/72 Dorgali Dorgali NU 61,35 16 Sale Maria Grazia 12/02/81 Nuoro Fonni NU 60,6 17 Manca Grazia 23/05/60 Nuoro Nuoro NU 60 18 Curreli Rosalba 01/03/63 Ovodda Ovodda NU 60 La Croce Battistina 19 16/07/64 Tonara Tonara NU 60 Carmen 20 Carta Anna Rita 14/06/66 -

L'italia E L'eurovision Song Contest Un Rinnovato
La musica unisce l'Europa… e non solo C'è chi la definisce "La Champions League" della musica e in fondo non sbaglia. L'Eurovision è una grande festa, ma soprattutto è un concorso in cui i Paesi d'Europa si sfidano a colpi di note. Tecnicamente, è un concorso fra televisioni, visto che ad organizzarlo è l'EBU (European Broadcasting Union), l'ente che riunisce le tv pubbliche d'Europa e del bacino del Mediterraneo. Noi italiani l'abbiamo a lungo chiamato Eurofestival, i francesi sciovinisti lo chiamano Concours Eurovision de la Chanson, l'abbreviazione per tutti è Eurovision. Oggi più che mai una rassegna globale, che vede protagonisti nel 2016 43 paesi: 42 aderenti all'ente organizzatore più l'Australia, che dell'EBU è solo membro associato, essendo fuori dall'area (l’anno scorso fu invitata dall’EBU per festeggiare i 60 anni del concorso per via dei grandi ascolti che la rassegna fa in quel paese e che quest’anno è stata nuovamente invitata dall’organizzazione). L'ideatore della rassegna fu un italiano: Sergio Pugliese, nel 1956 direttore della RAI, che ispirandosi a Sanremo volle creare una rassegna musicale europea. La propose a Marcel Bezençon, il franco-svizzero allora direttore generale del neonato consorzio eurovisione, che mise il sigillo sull'idea: ecco così nascere un concorso di musica con lo scopo nobile di promuovere la collaborazione e l'amicizia tra i popoli europei, la ricostituzione di un continente dilaniato dalla guerra attraverso lo spettacolo e la tv. E oltre a questo, molto più prosaicamente, anche sperimentare una diretta in simultanea in più Paesi e promuovere il mezzo televisivo nel vecchio continente. -

Archivio Nisseno N. 3
Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” - Caltanissetta ARCHIVIO NISSENO Rassegna di storia, lettere, arte e società Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 Paruzzo Printer editore - Caltanissetta 1 ARCHIVIO NISSENO Rassegna semestrale di storia, lettere, arte e società dell’Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” di Caltanissetta Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 2 Torniamo a parlare dei Fasci dei Lavoratori. La drammatica vicenda dei Fasci dei Lavoratori in Sicilia rappresenta la fase conclusiva di un lungo processo di crisi che si manifestò nel distorto svi- luppo dell’economia siciliana dell’Ottocento e nelle forme che assunse la politica a livello delle amministrazioni locali ma anche a livello nazionale. Se si guarda bene alle cause di questa crisi, molte di esse vanno individua- te nel mancato “governo” dei processi che determinarono una aberrante ridi- stribuzione della grande proprietà fondiaria. L’idea che fu alla base dell’ever- sione delle terre feudali (1812) e delle ricorrenti confische delle terre eccle- siastiche, cioè che si potesse creare una piccola proprietà contadina attraver- so la quotizzazione delle proprietà divenute demaniali, fallì miseramente a causa dell’ingordigia dei proprietari terrieri che aggirarono in tanti modi la legge, grazie anche alla connivenza del potere politico. Si andò così determinando, specialmente dal 1860 in poi, una situazione paradossale: la ridistribuzione delle terre, che era una delle grandi aspirazio- ni dei contadini siciliani alimentata anche dalle promesse di Garibaldi, non solo non si realizzò nei modi sperati, ma divenne un grande inganno che determinò un progressivo impoverimento del mondo contadino e braccianti- le, fino a giungere alle condizioni di estremo degrado e di miseria dei primi anni ‘90. -

Post/Teca 10.2010
Post/teca materiali digitali a cura di sergio failla 10.2010 ZeroBook 2011 Post/teca materiali digitali Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”? Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un ennesimo modo per tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/ godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? Beh, questo proprio non sta a me dirlo. Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore. Questo archivio esce diviso in mensilità. Per ogni “numero” si conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -
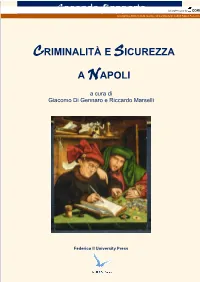
Secondo Rapporto
Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche, Giuridiche, e Sociali View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk econdo apporto brought to you by CORE 2 S R provided by Archivio della ricerca - Università degli studi di Napoli Federico II 2 Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiet- tivo, questa volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni crimi- nali che caratterizzano la città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi affrontati riguardano alcuni temi quali la persi- stenza dell’agire deviante grave di minori e criminale di adulti, la formazione di ag- RIMINALITÀ E ICUREZZA gregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le diverse sperimentazioni in C S tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di una C riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpre- RIMINALITÀ E A APOLI tazione della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi N strati sociali l’esito dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che Gennaro Di Giacomo deprime le opportunità legali e favorisce la convinzione in molti che le carriere cri- a cura di minali siano più convenienti. Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli Oltre ai curatori del volume Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, hanno con- tribuito: Aldo Corvino, Maria Di Pascale, Giuseppina Donnarumma, Debora Amelia Elce, Filomena Gaudino, Fausto Lamparelli, Elia Lombardo, Elisabetta Morazio, S - ICUREZZA A Andrea Procaccini, Francesco Rattà, Luigi Rinella, Rodolfo Ruperti, Riccardo Marselli Riccardo Sgobbo, Michele Maria Spina, Pasquale Troncone. -
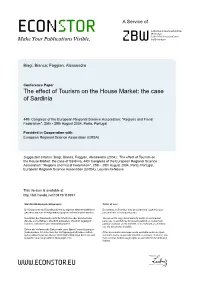
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.