11 Daniele Benati LA PALA DA ALTARE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Storia Pittorica Della Italia Dell'abate Luigi Lanzi
STORIA PITTORICA DELLA ITALIA DELL’ABATE LUIGI LANZI ANTIQUARIO DELLA R. CORTE DI TOSCANA TOMO SECONDO PARTE SECONDA OVE SI DESCRIVONO ALTRE SCUOLE DELLA ITALIA SUPERIORE , LA BOLOGNESE , LA FERRARESE , E QUELLE DI GENOVA E DEL PIEMONTE BASSANO A SPESE REMONDINI IN VENEZIA 1795 - 1796 [1] DELLA STORIA PITTORICA DELLA ITALIA SUPERIORE LIBRO TERZO SCUOLA BOLOGNESE Abbiam osservato nel decorso di questa opera che la gloria del dipingere, non altrimenti che quella delle lettere e delle armi, è ita di luogo in luogo; e ovunque si è ferma ha perfezionata qualche parte della pittura meno intesa da' precedenti artefici o meno curata. Quando il secolo sestodecimo eclinava all'occaso non vi era oggimai in natura o genere di bellezza, o aspetto di essa, che non fosse stato da qualche professor grande vagheggiato e ritratto; talché il dipintore, voless'egli o non volesse, mentre era imitatore della natura, dovea esserlo a un tempo de' miglior maestri, e il trovar nuovi stili dovea essere un temperare in questo o in quell'altro modo gli antichi. Adunque la sola via della imitazione era aperta per distinguersi all'umano ingegno; non sembrando poter disegnar figure più maestrevolmente di un Bonarruoti o di un Vinci, o di aggraziarle meglio di Raffaello, o di colorirle più al vivo di Tiziano, o di muo[2]verle più spiritosamente che il Tintoretto, o di ornarle più riccamente che Paolo, o di presentarle all'occhio in qualunque distanza e prospetto con più arte, con più rotondità, con più incantatrice forza di quel che già facesse il Coreggio. Questa via della imitazione batteva allora ogni Scuola; ma veramente con poco metodo. -

Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art
Athens Journal of Humanities & Arts - Volume 8, Issue 3, July 2021 – Pages 189-208 Li Pittori Parlano con l’Opere: Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art By James Hutson* The relative sophistication of artists in the early modern era is contested, especially with regards to their educational backgrounds. On one hand, Dempsey-esque intellectual history is vested in touting the structured, literary curricula in art-educational institutions; while on the other, a complete rejection of the ‚artist-philosopher‛ as historical fiction seeks to undermine this hegemonic construct. This study argues that the lack of early formal education in the cases of artist like Annibale Carracci and Nicolas Poussin, who, unlike Peter Paul Rubens, did not have a firm foundation in the classics and languages that would allow them to engage directly with source material, would later be supplemented through their relationships with literary figures in the circles of Torquato Tasso, Giambattista Marino, and the Accademia dei Gelati. In addition to such relationships, informal exchanges, gatherings, and supplemental materials like Giovanni Paolo Gallucci’s Della Simmetria could be called upon when treating poetic subjects. With intimate knowledge of vernacular poetry, literati themselves participating in lectures and studio visits, and, finally, quick reference guides for subject matter, these artists were able to produce works that spoke to both poetic and artistic theory of the day, as one naturally informed the other. Introduction ‚Poets paint with words, painters speak with their works.‛1 This aphorism of Annibale Carracci (1560-1609) followed a superb rendering of the Laocoön in charcoal, expertly rendered from memory. -

Imagines N. 3 (2020, Marzo)
Imagines è pubblicata a Firenze dalle Gallerie degli Uffizi Direttore responsabile Eike D. Schmidt Redazione Dipartimento Informatica e Strategie Digitali Coordinatore Gianluca Ciccardi Coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie degli Uffizi Fabrizio Paolucci Hanno lavorato a questo numero Andrea Biotti, Antonella Madalese, Gianluca Matarrelli, Patrizia Naldini, Marianna Petricelli ISSN n. 2533-2015 3 marzo 2020 indice n. 3 (2020, Marzo) 6 EIKE D. SCHMIDT FLORENTIA QUANTA FUIT 8 ANNAMARIA PETRIOLI TOFANI LA COLLEZIONE DI APOLLONIO BASSETTI AL GABINETTO DISEGNI DEGLI UFFIZI 100 NOVELLA LAPINI UN NUOVO ADDETTO ALL’OFFICIUM ADMISSIONIS: TITUS AELIUS PROCULUS, LIBERTO ADRIANEO 116 AURORA TAIUTI SULLA STORIA COLLEZIONISTICA DELLE C.D. IULIAE TITII IN GALLERIA 136 JENNIFER CANTU VERONESE’S ANNUNCIATIONS 144 FABIANA CAZZOLA-SENKPIEL L’ATTO DEL DIVENIRE DELL’IMMAGINE. MEDIALITÀ E TEMPORALITÀ NELL’AUTORITRATTO POIETICO DI ALESSANDRO ALLORI (1555) 156 VALESKA VON ROSEN THE GALLERIA DEGLI AUTORITRATTI IN THE UFFIZI Notes on a research project on the conditions of artistic production, modes of reception and systems of organisation in the context of an early modern ‘special collection’ 170 MARIA VITTORIA THAU ALESSANDRO MAZZANTI, RESTAURATORE DI “SOMMA DILIGENZA E RARA PERIZIA” Eike D. Schmidt FLORENTIA QUANTA FUIT Con l’acquisto, nel dicembre 2018, dell’inedita urna cineraria di Titus Aelius Proculus, adiutor ab admissione alla corte dell’imperatore Adriano, gli Uffizi hanno ripreso in mano un campo del collezionismo – quello dell’epigrafia antica – che si era interrotto nel pri- mo Ottocento. Eppure fu proprio alla Galleria delle statue e delle pitture del complesso vasariano che all’inizio del Settecento l’architetto di corte, Giovanni Battista Foggini, al- lestì per Cosimo III de’ Medici un “ricetto”, ossia un ambiente a lato del corridoio di Po- nente, decorato con un tripudio di iscrizioni. -

La Golden Age Bolognese
PREVIEW La ragazza con l’orecchino di perla Il mito della Golden Age. Da Vermeer a Rembrandt - Capolavori dl Mauritshuis 8 febbraio - 25 maggio 2014 Palazzo Fava via Manzoni Bologna www.bolognadavivere. com/2014/01/vi- Agenda presento-la-ragazza- con-lorecchino-di-perla-in- anteprima-esclusiva-dal- 31-gennaio Il mistero dell’orecchino di perla Inaugurazione: Sabato 8 Febbraio ore 17,30 ABC, Bologna Via Farini 30 Apertura al pubblico: da martedì 9 a sabato 28 febbraio 2014 Giorni di chiusura: lunedì Ingresso da: Galleria Maurizio Nobile Via S.Stefano 19/a – Bologna Orario: da martedì a sabato dalle 11 alle 19, domenica dalle 11 alle 17 Ingresso:gratuito www.bolognadavivere. com/2014/02/il-mistero- dellorecchino-di- perla/?preview=true (ATTIVO DAL 7 FEBBRAIO) 14 febbraio 2014 Mi illumino di meno Giovedì 20 febbraio 2014 Tosca di Giacomo Puccini Teatro Comunale di Bologna ore 20.00 Sala Bibiena del Teatro Comunale di Bologna debutta Tosca di Giacomo Puccini. Repliche fino al 2 marzo. Il teatro di Romeo Castellucci nella città di Bologna fino a maggio 2014 Drammaturgia Urbana Spettacoli, installazioni, performance, proiezioni, incontri e un concerto prendono corpo in differenti luoghi della città, dai quali ricevono, a loro volta, un’impronta. A febbraio segnaliamo Il debutto dello spettacolo USO UMANO DI ESSERI UMANI (14-15-16 febbraio) e la rassegna di video e film L’ATTO DI VEDERE CON I PROPRI OCCHI (8-25 febbraio) www.bolognadavivere. com/2014/02/il-teatro-di- Aspettando Vermeer. castellucci-a-febbraio-a- è il più importante appuntamento bologna internazionale per i professionisti Occasioni di conoscenza. -

Felsina Pittrice LIVES of the BOLOGNESE PAINTERS
CARLO CESARE MALVASIA’S Felsina pittrice LIVES OF THE BOLOGNESE PAINTERS Published for the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington Harvey Miller Publishers An Imprint of Brepols Publishers THE FELSINA PITTRICE Count Carlo Cesare Malvasia’s Felsina pittrice, or Lives of the Bolognese Painters, first published in two volumes in Bologna in 1678, is one of the most important sources for the history and criticism of painting in Italy. Conceived in part as a response to Giorgio Vasari’s Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550/1568), the Felsina pittrice combines close observation with documentary history, and careful analysis with polemical debate. It offers the fullest account of Bolognese artists from Simone dei Crocefissi to Prospero and Lavinia Fontana, from Guercino to Elisabetta Sirani. The Carracci are treated as a family of artists, and their school (including Guido Reni, Domenichino, and Francesco Albani, among others) is documented by Malvasia in far greater detail than by any other biographer. The great art historian Luigi Lanzi (1732- 1810) said that no other school in Italy had been described by a more capable pen, and he considered the two volumes of the Felsina pittrice to be “a treasure of the most beautiful knowledge gathered from the pupils of the Carracci, whom Malvasia knew, and who helped him in this work, which was, however, accused of sometimes burning with an excessively patriotic zeal.” 2. THE CRITICAL EDITION Accusations of excessive passion for his local school, combined with unjustified charges of forgery and unreliability, have for centuries clouded the reception and understanding of Malvasia’s extraordinarily important text, which was last edited and published in 1841-44. -

La Collezione Sampieri Nel Palazzo Di Strada Maggiore
La collezione Sampieri nel palazzo di Strada Maggiore 1 2 L’inventario compilato nel 1787, alla scomparsa di padre Ferdinando Sampieri, oratoriano, enumera circa 120 dipinti nell’appartamento a piano terra di Casa Sampieri celebre per gli affreschi che Ludovico, Agostino e Annibale Carracci eseguirono poco prima del 1595 sul soffitto e sui camini di tre stanze poste in sequenza, oltre che per lo spettacolare affresco con Ercole in lotta con il gigante Anteo che il Guercino realizzò nel 1631 in un’altra porzione del palazzo. Poche opere si erano aggiunte nel Settecento e la collezione mostrava l’aspetto che aveva assunto nella prima metà del Seicento. Era possibile ammirarvi celebri dipinti dei primi nomi della pittura bolognese tra Cinque e Seicento: non solo i tre Carracci e il Guercino, ma anche Guido Reni, Francesco Albani, Pietro Faccini, Lionello Spada, Simone Cantarini, Giovanni Andrea Sirani e altri. Non mancavano inoltre quadri celebri del tempo precedente, opere, tra gli altri, di Dosso Dossi, del Garofalo, di Pellegrino Tibaldi e di Lavinia Fontana, così come tele della seconda 3 metà del Seicento eseguite da Elisabetta Sirani, Carlo Cignani, Domenico Maria Canuti, Marcantonio Franceschini e altri. 4 Definito “superbissimo museo” da Carlo Cesare Malvasia nel 1686, il palazzo era meta di illustri viaggiatori italiani e stranieri: dall’imperatore Giuseppe II, in visita nel 1769, a Charles De Brosses, in Italia tra il 1739 e il 1740, a Nicholas Cochin, in viaggio tra il 1750 e il 1751; inoltre intellettuali come Francesco Algarotti e artisti quali Sir Joshua Reynolds, a Bologna nel luglio 1752, Jean-Honoré Fragonard, ospite del palazzo nei primi giorni di novembre del 1759 insieme all’Abbé de Saint- Non, Angelika Kauffmann, nel 1762 e nel 1765, infine Gavin Hamilton, l’architetto neoclassico russo Nicolaj L’vov, Guy Head ed Élisabeth Vigée 6 Le Brun. -

Antichi Maestri Italiani
ANTICHI MAESTRI ITALIANI Fondantico INCONTRO CON LA PITTURA 23 Fondantico di Tiziana Sassoli Via de’ Pepoli, 6/E - 40125 Bologna Tel. e Fax 051.265.980 [email protected] www.fondantico.it Restauro e revisione dei dipinti: Liliana e Rodolfo Giangrossi, Milano; Barbara Morettini, Bologna; Giovanni Pigoni e Davide Tirelli, Reggio Emilia; Licia Tasini, Pieve di Cento (Bologna). Segreteria e ufficio stampa: Maria Cristina Porpora Coordinamento redazionale: Pietro Di Natale © Fondantico - ottobre 2015 Fondantico arte e antiquariato ANTICHI MAESTRI ITALIANI Dipinti e disegni dal XVI al XIX secolo Catalogo a cura di Daniele Benati Testi di Michelangelo Agostini Daniele Benati Donatella Biagi Maino Alessandro Brogi Pietro Di Natale Massimo Francucci Eleonora Frattarolo Federico Giannini Milena Naldi Giulia Palloni Tommaso Pasquali Eugenio Riccòmini Marco Riccòmini Elisabetta Sambo 7 novembre - 23 DICEMBRE 2015 ono quaranta i dipinti e i disegni antichi che Fondantico presenta per il suo ventitreesimo “Incontro con la pittura”. Una scelta che quest’anno con- S templa artisti non soltanto bolognesi, ma anche di altri centri pittorici: di qui il titolo Antichi maestri italiani, che riecheggia il termine di Old Masters usato dalle gallerie inglesi. In questo modo il percorso, che si snoda dal XVI al XIX secolo, può comprendere tra gli altri anche un sorprendente dipinto di grandi dimensioni di Filippo da Verona, un pittore di grande interesse riscoperto solo dagli studi moderni. La parte del leone è giocata tuttavia dagli artisti emiliani, secondo la tradizione ormai più che ventennale della galleria. Ecco allora le presenze cinquecentesche del Garofalo, di Denjs Calvaert (con un prezioso Giove e Semele) e di Francesco Cavazzoni, da qualche anno una costante delle mostre di Fondantico. -

Alessandro Tiarini
Alessandro Tiarini Alessandro Tiarini menti che avrebbero impedito al pittore di accedere alla vera Parma,Mantova Cremona e Faenza: i suoi caratteri si arric- perfezione (elementi ricavati dal confronto con Guido Reni). chiscono di influssi svariati, da Correggio a Bonone, Reni, Bologna, 1577 - 1668 I suoi spostamenti tra Bologna e Firenze lo costringono a con- Domenichino e, pur continuando a ricevere numerose com- Un pittore dai colti interessi letterari, tanto che il suo primo frontarsi anche con la scuola romana e a declinare la sua pit- missioni fino a tarda età, la sua fase finale appare meno po- biografo, Carlo Cesare Malvasia, lo definisce “più lodato dà tura diverse volte nel corso della sua vita sottoponendosi alle tente e originale. dotti che dal volgo”. Il linguaggio di Tiarini non si connota per critiche dei colleghi e dei committenti. Tiarini viene apprezzato anche dai viaggiatori (Charles De fonti di riferimento univoche. Tiarini giunge ad assumere le propensioni per un racconto co- Brosses, Cochin, D’Azzelier D’Argenville prima metà del lorito ma come rallentato dal moltiplicarsi dei gesti eloquenti ‘700), per i quali le quadrerie di Bologna erano tappa im- Dopo un apprendista- con cui i sacri protagonisti mimano l’azione loro affidata. portante prima di giungere a Roma. to nello studio del Fon- Verso la fine del secondo decennio del secolo cominciò a tana fino alla morte di lavorare anche fuori patria, in particolare a Reggio Emilia, D.Benati, 1986. quest’ultimo (1597), il giovane Tiarini ten- tò poi inutilmente di entrare nell’Accademia carraccesca, finendo per un breve periodo presso il Cesi . -

A Collector's Eye Cranach to Pissarro
A Collector’s Eye Cranach to Pissarro 1 A Collector’s Eye 2 1 A Collector’s Eye Cranach to Pissarro First published 2010 by National Museums Liverpool 127 Dale Street Liverpool L2 2JH All images © 2010 David Lewis and family interests Introductory text and catalogue entries © 2010 Christopher Wright The authors’ rights have been asserted by them in accordance with the Copyright, Design and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, without the prior written permission of the publisher. A British Library CIP record is available. ISBN 978-1-902700-44-1 Designed by Pointing Design Printed and bound by Everbest 2 3 Contents A Collector’s Eye 7 David Lewis Introduction 13 Christopher Wright Catalogue editor Foreword 19 Reyahn King Director of Art Galleries, National Museums Liverpool Catalogue Impressionists 23 15th and 16th Centuries 33 17th Century 77 18th Century 137 19th Century 147 Index 158 4 5 A Collector’s Eye The creation of a private collection is an intensely personal exercise. The objects so gathered would exist whether or not brought together in one ownership. Such a collection may reflect the vanity of the collector, or it may, hopefully, reflect an intellectual curiosity which can to some extent be satiated by the juxtaposition of period, style, subject, medium, artist or creator. This fulfils a subjective desire to learn and appreciate in the comfort and accessibility of one’s own possessions, rather than within the public domain. -

Rivista Di Studi Italiani 248 Rassegna Bibliografica
RIVISTA DI STUDI ITALIANI RASSEGNA BIBLIOGRAFICA JUDITH AND HOLOFERNES: A CHRONOLOGICAL LIST OF WORKS FRANK CAPOZZI Milwaukee, Wisconsin NTRODUCTION IThrough many transformations and interpretations of the dramatic elements of the apocryphal story of Judith and Holofernes, the biblical tale has become part of our cultural heritage and has exerted a profound influence on the creative spirit of writers and artists throughout the centuries. The Book of Judith is divided into four major sections: Nebuchadnezzar’s wars of aggression, with the description of the splendor and the cruelty of the Orient; the siege of Bethulia by the proud Holofernes and the sufferings of the people; Judith’s deceitful beguiling of Holofernes and the decapitation of the general; the triumphal return of Judith to Bethulia and the defeat of the Assyrian army. The story of Judith contains all the elements of a mythical event: the heroine is called to perform a dangerous deed; she is swallowed by the dangerous unknown, Holofernes’ tent; she is granted the supernatural assistance of God; she accomplishes her mission and safely returns to Bethulia. Writers have capitalized on one or more of these dramatic moments in order to express religious, patriotic, or social ideas, while artists have usually limited their works to the most dramatic event, the beheading of Holofernes, or to the return of Judith to Bethulia. Before the middle of the sixteenth century, Judith is usually portrayed as a moral and religious heroine, a prefiguration of Mary and of the Church, and as a political heroine (Sacra rappresentazione di Judith). During the years of the Council of Trent and soon afterwards the heroine becomes a vehicle for religious propaganda – the defender of the Catholic Church against Protestantism (Stefano Tuccio’s Juditha), or for social comments – an attack against some of the problems of sixteenth-century society (Cesare Sacchetti’s Rappresentazione di Giudith). -

Reconsidering Center-Periphery Pedagogy
Art and Design Review, 2019, 7, 150-173 http://www.scirp.org/journal/adr ISSN Online: 2332-2004 ISSN Print: 2332-1997 Le Accademie Bolognese e Romana: Reconsidering Center-Periphery Pedagogy James Hutson Art History Department, Lindenwood University, St. Charles, MO, USA How to cite this paper: Hutson, J. (2019). Abstract Le Accademie Bolognese e Romana: Recon- sidering Center-Periphery Pedagogy. Art and This article seeks a reevaluation of the relationship between the Carracci Ac- Design Review, 7, 150-173. cademia degli’Incamminati and the Accademia di San Luca in Rome with re- https://doi.org/10.4236/adr.2019.73014 gards to structure, goals and pedagogy. For although the perceived pedagogi- Received: July 13, 2019 cal goals of the Carracci, especially the prosaic Annibale, and the most Accepted: August 9, 2019 well-known Scholastic academician associated with the Roman Accademia, Published: August 12, 2019 Federico Zuccaro, have traditionally been viewed as conflicting, the early his- tory of the academy in Rome can be seen to parallel the Bolognese. Each was Copyright © 2019 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. established to address the uncertain and evolving nature of the profession This work is licensed under the Creative seen in each city, leading to a demand for a new type of educational institu- Commons Attribution International tion for the studiosi giovani; the curricula developed were designed to meet License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ the new andragogical challenges of these new “open” art academies; and, fi- Open Access nally, their foundations were designed with reformatory goals in mind due to their association with the same educatori riformanda. -
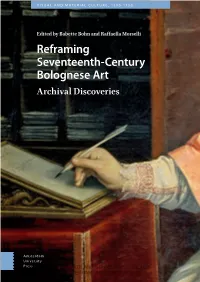
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Bohn & Morselli (eds.) Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Reframing Seventeenth-CenturySeventeenth-century Bolognese Art Archival Discoveries Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Bolognese Seventeenth-Century Reframing FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late medieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Archival Discoveries Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Guido Reni, Portrait of Cardinal Bernardino Spada, Rome, Galleria Spada, c.