Alessandro Tiarini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Imagines N. 3 (2020, Marzo)
Imagines è pubblicata a Firenze dalle Gallerie degli Uffizi Direttore responsabile Eike D. Schmidt Redazione Dipartimento Informatica e Strategie Digitali Coordinatore Gianluca Ciccardi Coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie degli Uffizi Fabrizio Paolucci Hanno lavorato a questo numero Andrea Biotti, Antonella Madalese, Gianluca Matarrelli, Patrizia Naldini, Marianna Petricelli ISSN n. 2533-2015 3 marzo 2020 indice n. 3 (2020, Marzo) 6 EIKE D. SCHMIDT FLORENTIA QUANTA FUIT 8 ANNAMARIA PETRIOLI TOFANI LA COLLEZIONE DI APOLLONIO BASSETTI AL GABINETTO DISEGNI DEGLI UFFIZI 100 NOVELLA LAPINI UN NUOVO ADDETTO ALL’OFFICIUM ADMISSIONIS: TITUS AELIUS PROCULUS, LIBERTO ADRIANEO 116 AURORA TAIUTI SULLA STORIA COLLEZIONISTICA DELLE C.D. IULIAE TITII IN GALLERIA 136 JENNIFER CANTU VERONESE’S ANNUNCIATIONS 144 FABIANA CAZZOLA-SENKPIEL L’ATTO DEL DIVENIRE DELL’IMMAGINE. MEDIALITÀ E TEMPORALITÀ NELL’AUTORITRATTO POIETICO DI ALESSANDRO ALLORI (1555) 156 VALESKA VON ROSEN THE GALLERIA DEGLI AUTORITRATTI IN THE UFFIZI Notes on a research project on the conditions of artistic production, modes of reception and systems of organisation in the context of an early modern ‘special collection’ 170 MARIA VITTORIA THAU ALESSANDRO MAZZANTI, RESTAURATORE DI “SOMMA DILIGENZA E RARA PERIZIA” Eike D. Schmidt FLORENTIA QUANTA FUIT Con l’acquisto, nel dicembre 2018, dell’inedita urna cineraria di Titus Aelius Proculus, adiutor ab admissione alla corte dell’imperatore Adriano, gli Uffizi hanno ripreso in mano un campo del collezionismo – quello dell’epigrafia antica – che si era interrotto nel pri- mo Ottocento. Eppure fu proprio alla Galleria delle statue e delle pitture del complesso vasariano che all’inizio del Settecento l’architetto di corte, Giovanni Battista Foggini, al- lestì per Cosimo III de’ Medici un “ricetto”, ossia un ambiente a lato del corridoio di Po- nente, decorato con un tripudio di iscrizioni. -

Felsina Pittrice LIVES of the BOLOGNESE PAINTERS
CARLO CESARE MALVASIA’S Felsina pittrice LIVES OF THE BOLOGNESE PAINTERS Published for the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington Harvey Miller Publishers An Imprint of Brepols Publishers THE FELSINA PITTRICE Count Carlo Cesare Malvasia’s Felsina pittrice, or Lives of the Bolognese Painters, first published in two volumes in Bologna in 1678, is one of the most important sources for the history and criticism of painting in Italy. Conceived in part as a response to Giorgio Vasari’s Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550/1568), the Felsina pittrice combines close observation with documentary history, and careful analysis with polemical debate. It offers the fullest account of Bolognese artists from Simone dei Crocefissi to Prospero and Lavinia Fontana, from Guercino to Elisabetta Sirani. The Carracci are treated as a family of artists, and their school (including Guido Reni, Domenichino, and Francesco Albani, among others) is documented by Malvasia in far greater detail than by any other biographer. The great art historian Luigi Lanzi (1732- 1810) said that no other school in Italy had been described by a more capable pen, and he considered the two volumes of the Felsina pittrice to be “a treasure of the most beautiful knowledge gathered from the pupils of the Carracci, whom Malvasia knew, and who helped him in this work, which was, however, accused of sometimes burning with an excessively patriotic zeal.” 2. THE CRITICAL EDITION Accusations of excessive passion for his local school, combined with unjustified charges of forgery and unreliability, have for centuries clouded the reception and understanding of Malvasia’s extraordinarily important text, which was last edited and published in 1841-44. -
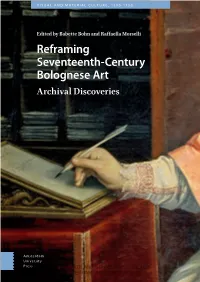
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Bohn & Morselli (eds.) Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Reframing Seventeenth-CenturySeventeenth-century Bolognese Art Archival Discoveries Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Bolognese Seventeenth-Century Reframing FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late medieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Archival Discoveries Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Guido Reni, Portrait of Cardinal Bernardino Spada, Rome, Galleria Spada, c. -

Tommaso Laureti E Hartolomeo Cesi: Precisazioni Sulla Decorazione Delt“Altra Cappella Magnani in San Giacomo Maggiore
Tommaso Laureti e Hartolomeo Cesi: precisazioni sulla decorazione delT “altra cappella Magnani in San Giacomo Maggiore Samuel Vitali Magnani possedeva nella chiesa agostiniana, no- Tra le opere più significative del tardo manierismo nostante anch’essa conservi quasi integralmente la bolognese va annoverata senza dubbio la cappella di sua originaria decorazione cinquecentesca 2 (fig. 1). Lorenzo Magnani in San Giacomo Maggiore, che il Si tratta della terza cappella a sinistra nella navata nobile bolognese, dopo averne acquisito il giuspatro- della chiesa, abbellita pure da affreschi e stucchi, nato nel 1572, si fece sontuosamente decorare entro nonché da una pala d’altare di Tommaso Laureti raf- il 1575 da Orazio Sammacchini con affreschi, stucchi figurante la Madonna col Bambino e i santi Cecilia, e una pala raffigurante la Purifìcazione della Vergine, Agata e Guglielmo d ’Aquitania 3 (fig. 2), che è rac- opera che finì poi di essere una delle ultime fatiche chiusa in una ricchissima ancona di legno dorato, dell’artista morto nel 1577'. Molto meno nota e poco studiata è invece l’altra cappella che la famiglia coronata in alto dalle figure scolpite di due angiolet- 1. Cappella Magnani, Bologna, San Giacomo Maggiore 2. Tommaso Laureti, Madonna col Bambino e i santi Cecilia, Agata e Guglielmo d’Aquitania, Bologna, San Giacomo Maggiore, cappella Magnani 24 3. Bartolomeo Cesi, San Procolo, Bologna, San Giacomo Maggiore, cappella Magnani 4. Bartolomeo Cesi, San Floriano, Bologna, San Giacomo Maggiore, cappella Magnani ti e di Dio Padre. Gli affreschi laterali rappresentano La storia della concessione di questa seconda cappel- San Procolo a sinistra (fig. 3) e San Floriano a destra la Magnani - o “cappella comune dei Magnani ” come (fig. -

Studies in Seventeenth-Century Caricature
A Company of Artists Watching a Mountebank Show: studies in seventeenth-century caricature Katarzyna Murawska-Muthesius Figure 1 Formerly attributed to Francesco Albani, A Company of Artists Watching a Mountebank Show. Red chalk drawing, 20.8 x 30.3 cm. Private collection.* Introduction: a complex historiography When the self-taught collector and bibliophile Charles Rogers, member of a coterie of connoisseurs which included Charles Townley, Arthur Pond, and of course Horace Walpole, was selecting master drawings from British private collections to be reproduced in his Collection of Prints in Imitation of Drawings, he included two striking Italian caricatures.1 Both of them belonged to him by the time his book was published in 1778. One was a self-portrait by the preeminent eighteenth-century caricaturist Pier Leone Ghezzi, which concluded the section of Roman Old Master drawings in the first volume. The second, a red chalk caricature of a group of artists * The illustrations to this text may be found by clicking this link: Illustrations. 1 Charles Rogers, A Collection of Prints in Imitation of Drawings to which are Annexed Lives of their Authors with Explanatory and Critical Notes, London: J. Nichols, 1778. Roger’s collection of drawings has been decimated by sale after his death, but his enormous collection of prints and books has been preserved in the Cottonian Collection in Plymouth largely intact. See, Antony Griffiths, ‘The Rogers Collection in the Cottonian Library, Plymouth’, Print Quarterly 10:1, 1993, 19-36; Nicholas Turner, ‘The Gabburi/ Rogers Series of Drawn Self-Portraits and Portraits of Artists’, Journal of the History of Collections, 5: 2, 1993, 179-216. -

I U' H.) 11 2 Abstract
LAVINIA FONTANA; AN ARTIST AND HER SOCIETY IN LATE SIXTEENTH-CENTURY BOLOGNA by Caroline Patricia Murphy Submitted for a Phi) in the History of Art, University College, London, March, 1996 I u' H.) 11 2 Abstract This thesis is a study of the career of one of Europe's first truly successful female painters with the largest attributable oeuvre of any woman artist before the 18th century. It incorporates an analysis of the tastes and consumption patterns, lifestyles and mentalities of the patriciat clergy and scholars of Counter Reformation Bologna who were her patrons. The intent is to identify and categorise her patrons and to explore her artistic appeal to them and to explain the work opportunities created by Counter Reformation initiatives including church refurbishment and charity institutions. It breaks down into six chapters: the first concerns family background, how and why Fontana's painter father Prospero trained her as a painter, the circumstances surrounding her marriage and how it contributed to her career: The second is about her initial clientele of scholars and intellectuals connected with the University at Bologna whose portraits she painted and the Europe-wide cult of collections of images of uomini famosi which helped to give her an international reputation. The three middle chapters deal with the group of Bolognese noblewomen who were undoubtedly Fontana's most significant and high spending patrons, for whom she painted altarpieces, portraits and private devotional works and to whom she became personally connected through godparentage (she had eleven children). One of these chapters looks at these patrons in general terms, the next concerns Laudomia Gozzadini, for whom Fontana painted an enormous family portrait that had very special significance and resonance in the lives of both patron and painter. -

Female Self-Portraiture in Early Modern Bologna Author(S): Babette Bohn Source: Renaissance Studies, Vol
Female self-portraiture in early modern Bologna Author(s): Babette Bohn Source: Renaissance Studies, Vol. 18, No. 2 (JUNE 2004), pp. 239-286 Published by: Wiley Stable URL: http://www.jstor.org/stable/24413408 Accessed: 23-03-2018 15:29 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms Wiley is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Renaissance Studies This content downloaded from 100.15.134.190 on Fri, 23 Mar 2018 15:29:03 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms Renaissance Studies Vol. 18 No. 2 Female self-portraiture in early modern Bologna Babette Bohn This essay examines female self-portraiture in Bologna during the sixteenth and seventeenth centuries, focusing in particular on the seventeenth century, and considering these works in relation to self-portraits by male contempor aries. Bologna became a centre for women artists, culminating during the seventeenth century, when at least twenty-two female artists were active in the city. It is also the only Italian city with extant self-portraits by five different women artists during 1577-1678, although a forty-year gap, between 1614 and the 1650s, interrupts an otherwise continuous tradition. -
ARTE E STORIA 5 La Chiesa Di S.Girolamo
ARTE E STORIA 5 La chiesa di S.Girolamo La Chiesa di S. Girolamo I cimiteri monumentali italiani rappresentarono, fin dalla loro fondazione, una significativa testimonianza artistica e storica delle città. Il sepolcreto bolognese, a differenza di molti altri che solitamente furono costruiti ex-novo a partire dal XIX secolo, fu istituito riutilizzando le strutture del pre- esistente monastero di San Girolamo di Casara, la cui fondazione risale al 1334. Sebbene oggi ci appaia completamente integrato nel tessuto urbano, nel 1801 fu scelto proprio per la sua distanza dall’abitato e per la possibilità di adeguarlo con interventi minimi. Dal 1797, anno della sua soppressione, il complesso monastico ha subito numerose trasformazioni, demolizioni e aggiunte tali da rendere solo in parte visibile l’impianto originario. Fulcro fisico e ideologico è da sempre la chiesa di San Girolamo, intorno a cui ruotava la vita dei frati, sia negli spazi dedicati alle attività comuni, sia nelle celle monacali. Orti, vigneti e peschiere circondavano il complesso e garantivano rendite e autonomia alimentare. La fase edilizia più intensa è frutto dei privilegi accordati alla Certosa da Papa Niccolò V in riconoscenza di Nicolò Albergati, priore del monastero e figura di spicco della diplomazia internazionale dell’epoca, che fu suo maestro e sostenitore alla salita del soglio pontificio, avvenuta nel 1447. Due secoli dopo la fondazione, il complesso, che inizialmente aveva una struttura 4 piuttosto semplice, risultava ampliato da nuovi interventi che lo rendevano uno dei più importanti dell’ordine: le celle monacali dal canonico numero di undici erano passate a diciannove, la chiesa era stata ampliata nel transetto con l’aggiunta di due cappelle laterali e nuovi chiostri e spazi comunitari arricchivano il convento. -

A New Document for the Carracci and Ruggero Bascape at the Palazzo Magnani in Bologna*
Originalveröffentlichung in: The Burlington Magazine, 143 (2001), S. 604-613 SAMUEL VITALI A new document for the Carracci and Ruggero Bascape at the Palazzo Magnani in Bologna* A LARGE number ofdocuments concerningthe construction whose famous frieze of the Founding of Rome in the sala grande and decoration of the Palazzo Magnani, Bologna, have - (Fig. 1) no documentary evidence has emerged until now. 4 unlike those contained in the private Archivio Magnani Because of this lack of documents, the exact dating of Guidotti and published by Giancarlo Roversi in 1984' - gone the Magnani frieze, aptly labelled by Sir Denis Mahon ‘the almost completely unnoticed up to now in the Archivio di Adam and Eve of Baroque decoration ’5 and undoubtedly the Stato in Bologna. ’ Most of this huge bulk of unbound papers most important collaborative work of the three painters, has is of secondary interest for the art historian, consisting of lists been up to now a matter for discussion. 6 The dates proposed of payments made to carpenters, blacksmiths and the like. by modern scholars oscillate between 1587/88 and 1592; the However, the series of ‘bilanzi del libro della fabrica ’ from 1576 inscription on the chimney-piece bearing the name of the to 1599, mentioned only briefly in a recent article on the patron ‘laurentius magn [anius ] senator ’ and the year architecture of the palace, deserves more attention. 3 ‘m-d -xcii ’ is commonly taken to refer to the completion of the These ‘bilanzi ’ are annual summary balance sheets of decoration of the whole room and therefore considered as a the expenses incurred by the Bolognese nobleman Lorenzo mere terminus ante quem for the frescoes. -

"Un'artefice Cristiano". Studien Zu Lavinia Fontana Als Historienmalerin
„Un’artefice cristiano“. Studien zu Lavinia Fontana als Historienmalerin Von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Abhandlung Vorgelegt von Sandra Schmidt aus Augsburg Hauptberichter: Prof. Dr. Sabine Poeschel Mitberichter : Prof. Dr. Reinhard Steiner Tag der mündlichen Prüfung: 28. Februar 2011 Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart 2015 Inhalt Vorwort .................................................................................................................................................. III I Einleitung .............................................................................................................................................. 1 III Begriffsbestimmung Storia/Historia ................................................................................................ 10 IV Biographie ........................................................................................................................................ 12 V Bologna zwischen Spätmanierismus und Gegenreformation ......................................................... 17 1. Der historische Hintergrund in Bologna zur Zeit des Cinquecento ................................................... 17 1.1 Das Bilderdekret des Konzils von Trient .......................................................................................... 17 1.2 Der Discorso intorno alle imagini sacre e profane von Gabriele Paleotti ...................................... -

Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Unger in Early Modern Bolognese Painting Bolognese Modern Early in Eclecticism Redefining Daniel M. Unger Redefining Eclecticism in Early Modern Bolognese Painting Ideology, Practice, and Criticism Redefining Eclecticism in Early Modern Bolognese Painting Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late me- dieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. Redefining Eclecticism in Early Modern Bolognese Painting Ideology, Practice, and Criticism Daniel M. Unger Amsterdam University Press This book is published with the support of the Israel Science Foundation. Cover illustration: Guido Reni, Alliance between Disegno and Colore, 1620/5, Louvre, Paris (Photo: © Author). Cover design: Coördesign, Leiden Lay-out: Newgen/Konvertus isbn 978 94 6298 601 5 e-isbn 978 90 4853 725 9 doi 10.5117/9789462986015 nur 685 © D.M. -

11 Daniele Benati LA PALA DA ALTARE
Daniele Benati LA pala DA ALTARE: DEVOZIONE E ARTE NELLA montagna BOLOGNESE La montagna bolognese conserva un ingente patrimonio artistico, solo in parte noto e studiato. In questo senso molto è stato fatto dalle campagne di ricognizione e documentazione fotografica avviate fin dagli anni settanta dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e più di recente, in seguito al protocollo d’intesa tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (1996), dall’Ufficio Nazionale per il Beni Culturali Ecclesiastici. Tuttavia, pur nella difficoltà di accedere ai singoli edifici di culto, spesso chiusi per mancanza di personale di custodia, solo la visita diretta può evidenziare la straordinaria stratificazione culturale che vi si esplica, in ordine a esigenze devozionali e di culto che ne hanno consentito la conservazione fino a noi. Ne emerge in primo luogo con suggestiva limpidezza un tessuto ancora in gran parte integro, che rimanda alla razionalità e alla semplicità dell’organiz- zazione ecclesiastica voluta in epoca di Controriforma. Secondo quanto nel 1573 riferisce il visitatore apostolico Ascanio Marchesini, il cardinale Gabriele Paleotti teneva appese sulle pareti della sala delle udienze del palazzo arci- vescovile, oltre a una serie di ritratti dei vescovi che lo avevano preceduto a capo della diocesi di Bologna, tre grandi carte topografiche eseguite dall’ago- stiniano Cherubino Ghirardacci: della città, della pianura e della montagna1. Anticipando lo stesso pontefice Gregorio XIII Boncompagni, che nel 1580 si farà allestire in Vaticano la Galleria delle Carte geografiche, ciò gli permetteva di possedere razionalmente e “a colpo d’occhio” la diocesi che gli era stata affidata, di percepirne l’estensione e di memorizzarne l’articolazione.