Responsabilità Sportiva E Profili Civilistici Del Doping
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Italia / Italy
XIII IAAF World Championships Daegu (KOR) - 27 agosto-4 settembre Italia / Italy I componenti della staffetta 4x100 azzurra medaglia d’argento agli Europei 2010 di Barcellona The Italian 4x100 team, silver medallist at the 2010 European Championships of Brarelona La Delegazione The Delegation FIDAL La Delegazione / The Delegation Federazione Italiana Alberto Morini Capo Delegazione / Head of the Delegation di Atletica Leggera Franco Angelotti Consigliere Addetto / Council Member Italian Athletics Federation Francesco Uguagliati Direttore Tecnico / Technical Director Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma, Italia Vittorio Visini Assistente D.T. / Assistant to TD www.fidal.it Rita Bottiglieri Team Manager Francesco Cuccotti Team Manager Presidente /President Marco Sicari Addetto Stampa / Press Officer Franco Arese Pierluigi Fiorella Medico / Doctor Giuseppe Fischetto Medico / Doctor Consiglieri Antonio Abbruzzese Fisioterapista / Physio Council Members Maria M. Marello Fisioterapista / Physio Alberto Morini (Vice Presidente Vicario / Senior Vice President ) Filippo Di Mulo Tecnico / Coach Adriano Rossi (Vice Presidente / Giuseppe Mannella Tecnico / Coach Vice President ) Roberto Pericoli Tecnico / Coach Stefano Andreatta Fabio Pilori Tecnico / Coach Franco Angelotti Roberto Piscitelli Tecnico / Coach Marcello Bindi Nicola Silvaggi Tecnico / Coach Giovanni Caruso Angelo Zamperin Tecnico / Coach Alessandro Castelli Augusto D’agostino Michele Basile Tecnico Personale / Personal Coach Francesco De Feo Riccardo Ceccarini Tecnico Personale / Personal -

Chapter 1 COMMITMENT 第1
The Cyclist’s Training Bible (3rd edition) 自行车训练圣经(第三版) Chapter 1 COMMITMENT 第 1 章 承诺 Chapter 1 COMMITMENT 第 1 章 承诺 At the base of the climb, which was 12 kilometers 这是一段 12 公里长的上坡,在山脚下,我开始 long, I started to look around and saw Ullrich, 环顾四周并看到乌尔里希,潘塔尼,维廉切,里 Pantani, Virenque, Riis, Escartin, and Jimenez – all 斯,斯卡丁及希门尼斯 ―― 全都是总排名前 10 in the top 10 of the general classification – and then 位的高手 ―― 还有我。我没掉队!我是第一次 me. I was hanging, I was there with these guys for 跟这一帮人骑在一起。 the first time. -- BOBBY JULICH, commenting on the moment ――BOBBY JULICH,在 1997 年的环法赛中,当 in the 1997 Tour de France when he realized he 他意识到自己有机会争夺名次时的评论 was a contender Talk is cheap. It’s easy to have big dreams and 嘴巴说说是毫不费力的。在比赛前拥有一个 set high goals before the racing starts. But the 大梦及设定很高的目标也很简单。但是真正 true test of a commitment to better racing 对所承诺的更好比赛成绩的考验,不是靠 results is not in the talking, but in the doing. It 说,而是靠做。它并不是从这个赛季的第一 doesn’t start with the first race of the season – 场比赛开始 ―― 它是你现在所做的所有使 it’s all the things you do today to get stronger, faster, and more enduring. Real commitment 你变得更强壮,更快,耐力更好的所有事 means 365 days a year and 24 hours a day. 情。真正的承诺体现在一年 365 天和一天 24 小时。 Talk to the best riders you know, Ask 和你知道的最好的车手交谈,听听他们 them about commitment. Once you probe past 关于承诺的看法。 过滤掉那些“噢,什 all of the “aw, shucks” stuff, you’ll discover 么!”之类的废话后,你会发现骑自行车在 how big a role cycling plays in their lives. The 他们的生活中是扮演着多大的一个角色。他 better they are, the more you’ll hear about life 们越出色,你就会听到越多围绕运动的生活 revolving around the sport. -

Daum Law Office
. RECEIVED APR 11 Z005 DAUM LAW OFFICE LCWTED5773TES Sponsorship Agreement 102590-96-Z-0739 U.S. POSTAL SERVICE CYCLING TEAM Services Purchasing Room 4541 475 L'Enfant Plaza SW Washington DC 20260-6237 RESPONDENTS 4 the Company that the Contract Term will not be further extended, which notice shall be provided to the Company on or before such July 1. 5. Indemnification. The Company agrees to indemnify, defend and hold the Sponsor, its subsidiaries and the affiliates of each such entity, as well as each officer, agent, distributor, employee; attorney, dealer, consultant, representative, contractor, successor and assign of any of the above, harmless from and against any and all expenses, damages, ; claims, suits, losses, actions, judgments, liabilities and costs whatsoever .(including, without limitation, attorneys' fees) arising out of: (i) the Company's breach, misrepresentation or non-performance under this Agreement; and (ii) any claim or action for personal injury, death, bodily injury, property damage or otherwise, suffered by participants, patrons or others at the Company; other than as a result of the; Sponsor's actions or negligence. 6. Insurance. The Company agrees to carry full insurance coverage (including comprehensive general liability) for all activities reasonably connected with this Agreement naming the Sponsor as an additional insured. 7. Trademark. (a) The Sponsor hereby grants to the Company the right to use such . trademarks, trade names, service marks or logos.owned by the Sponsor in connection with the implementation of this Agreement, as may be agreed to •- in writing from time to time by Sponsor and the Company. The Company shall have no interest in or right to the use of such names, marks or logos, except for .any limited right of usage which the Sponsor may grant in writing pursuant to this Agreement. -

I Vincitori I Campionati Europei Indoor
0685-0862_CAP08a_Manifestazioni Internazionali_1 - 2009 11/07/16 11:41 Pagina 824 ANNUARIO 2016 I campionati Europei indoor Le sedi GIOCHI EUROPEI 6. 1975 Katowice (pol) 16. 1985 Atene (gre) 26. 2000 Gand (bel) 1. 1966 Dortmund (frg) 8/9 marzo, Rondo, 160m 2/3 marzo, 25/27 febbraio, 27 marzo, Westfallenhalle, 160m 7. 1976 Monaco B. (frg) Peace and Friendship Stadium, 200m Flanders Indoor Hall, 200m 2. 1967 Praga (tch) 21/22 febbraio, Olympiahalle, 179m 17. 1986 Madrid (spa) 27. 2002 Vienna (aut) 11/12 marzo, Sportovní Hala Pkojf, 160m 8. 1977 San Sebastian (spa) 22/23 febbraio, Palacio de los Deportes, 164m 1/3 marzo, Ferry-Dusika-Halle, 200m 3. 1968 Madrid (spa) 12/13 marzo, Anoeta, 200m 18. 1987 Liévin (fra) 28. 2005 Madrid (spa) 9/10 marzo, 9. 1978 Milano (ita) 21/22 febbraio, Palais des Sports, 200m 4/6 marzo, Palacio de los Deportes, 200m 19. 1988 (ung) Palacio de los Deportes, 182m 11/12 marzo, Palazzo dello Sport, 200m Budapest 29. 2007 Birmingham (gbr) 5/6 marzo, Sportscárnok, 200m 4. 1969 Belgrado (jug) 10. 1979 Vienna (aut) 2/4 marzo, National Indoor Arena, 200m 20. 1989 (ola) 8/9 marzo, Veletrzna hala, 195m 24/25 febbraio, Den Haag 30. 2009 (ita) 17/18 febbraio, Houtrust, 200m Torino Ferry-Dusika-Halle, 200m 6/8 marzo, Oval, 200 m 21. 1990 Glasgow (gbr) CAMPIONATI EUROPEI 11. 1980 Sindelfingen (frg) 3/4 marzo, Kelvin Hall, 200m 31. 2011 Parigi-Bercy (fra) 1. 1970 (aut) 1/2 marzo, Glaspalast, 200m Vienna 22. 1992 Genova (ita) 4/6 marzo, 12. -

Allarme Sul 17° Parallelo Estesi Gli Attacchi Aerei
Quotidiano / Anno XLIV / N. 41 ( S^'^SSiu) Lunedi 16 ottobre 1967 / L. 60 * Domani pomeriggio a Roma una Sardegna: sei arresti per il del lunedi grande manifestazione per Guevara sequestro di un industriale promossa dall'Associazione Italia-Cuba A pagina 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA 1TALIANO II movimento operaio e antimperialista ha perso un valoroso combattente CASTRO ANNUNCIA: IL CHE E M0RT0 La dolorosa conferma Un compagno data dal premier in un Appassionato manifestazione intorno II cdlciatore Meroni al PCI delle donne delle campagne U N PARTIGIANO italiano che ha conosciuto « Che » discorso ascoltato in Guevara fra i parligiani di Cuba diventati i soldati di muore a Torino quelVejercito rebelde che era gia stato capace di dare scacco al tcntativo di invasione, alia notizia di una tutta I'America latina morte lontana alia quale ha cercato di non credere fino investito da un'auto aH'ultimo, scrive oggi col sentimento col quale si ac- Per una vita civile compagna per l'liltima volta un amico che gli 6 caduto vicino. A noi, in questo doloroso momento, il compito di ricordarlo come un eroico compagno di lotta, un comu- nista caduto combattendo contro l'imperialismo, della cui figura si impadronira la leggenda. nel Sud impegno di lotta « Che » veniva da lontano. Era un giovane intellet- tuale argentino che visse una prima grande espe- rienza nei giorni della repressione del regime demo- cratico guatemalteco. Poi fu l'incontro nel Messico con Fidel che si addestrava per lo sbarco a Cuba a delle donne contadine fargli comprendere che a -
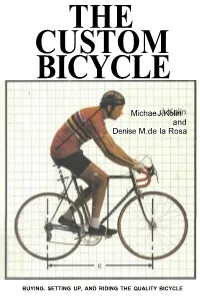
The Custom Bicycle
THE CUSTOM BICYCLE Michae J. Kolin and Denise M.de la Rosa BUYING. SETTING UP, AND RIDING THE QUALITY BICYCLE Copyright© 1979 by Michael J. Kolin and Denise M. de la Rosa All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher. Book Design by T. A. Lepley Printed in the United States of America on recycled paper, containing a high percentage of de-inked fiber. 468 10 9753 hardcover 8 10 9 7 paperback Library of Congress Cataloging in Publication Data Kolin, Michael J The custom bicycle. Bibliography: p. Includes index. 1. Bicycles and tricycles—Design and construction. 2. Cycling. I. De la Rosa, Denise M., joint author. II. Title. TL410.K64 629.22'72 79-1451 ISBN 0-87857-254-6 hardcover ISBN 0-87857-255-4 paperback THE CUSTOM BICYCLE BUYING, SETTING UP, AND RIDING i THE QUALITY BICYCLE by Michael J. Kolin and Denise M. de la Rosa Rodale Press Emmaus, Pa. ARD K 14 Contents Acknowledgments Introduction Part I Understanding the Bicycle Frame CHAPTER 1: The Bicycle Frame 1 CHAPTER 2: Bicycle Tubing 22 CHAPTER 3: Tools for Frame Building 3 5 Part II British Frame Builders CHAPTER 4: Condor Cycles 47 CHAPTER 5: JRJ Cycles, Limited 53 CHAPTER 6: Mercian Cycles, Limited BO CHAPTER 7: Harry Quinn Cycles, Limited 67 CHAPTER 8: Jack Taylor Cycles 75 CHAPTER 9: TI Raleigh, Limited 84 CHAPTER 10: Woodrup Cycles 95 Part III French Frame Builders CHAPTER 11: CNC Cycles 103 CHAPTER 12: Cycles Gitane 106 CHAPTER 13: Cycles Peugeot 109 THE CUSTOM BICYCLE Part IV Italian Frame Builders CHAPTER 14: Cinelli Cino & C. -

The International Sports Law Journal 2005, No
2005/3-4 The Pyramid and EC law Status of Players’ Agents Simutenkov Case IAAF Arbitration Panel CAS Ad Hoc Division in Athens An Irish CAS? Professional Sport in Poland Sports Image Rights Homegrown Players TV rights in Bulgarian Football Code of Ethics in Romania CMS Derks Star Busmann It’s pretty clear. As the keeper you have only one goal: to stop the balls whizzing past your ears. A flawless performance, that’s what it’s all about. On the ball, right through the match. With your eye on the defence. You have to focus on that one goal. And pounce on that one ball. Because keeping the score at nil is all that matters. ...on the ball. Being on the ball is just as important in business as in hockey. CMS Derks Star Busmann supports your business with full legal and fiscal services. A goal-focused and practical approach with you at the centre. Cases and faces is what CMS Derks Star Busmann is all about. Contact our sports law specialists Eric Vilé ([email protected]), Dolph Segaar ([email protected]) or Robert Jan Dil ([email protected]). www.cmsderks.nl CONTENTS Editorial 2 ARTICLES Is the Pyramid Compatible with EC Law? 3 The IAAF Arbitration Panel. The Heritage of Two Stephen Weatherill Decades of Arbitration in Doping-Related Disputes Christoph Vedder 16 The Laurent Piau Case of the ECJ on the Status of Players( Agents 8 The Ad Hoc Division of the Court of Arbitration Roberto Branco Martins for Sport at the Athens 2004 Olympic Games - An Overview 23 The Simutenkov case: Russian Players are Domenico Di Pietro Equal to European Union Players 13 Frank Hendrickx An ‘Irish Court of Arbitration for Sport’? 28 Michelle de Bruin PAPERS Professional Sport in Poland. -

Respondents 25 Sca 001378
Questions about a Champion "If a misdeed arises in the search for truth, it is better to exhume it rather than conceal the truth." Saint Jerome. "When I wake up in the morning, I can look in the mirror and say: yes, I'm clean. It's up to you to prove that I am guilty." Lance Armstrong, Liberation, July 24,2001. "To deal with it, the teams must be clear on ethics. Someone crosses the line? He doesn't have the right to a second chance!" Lance Armstrong, L'Equipe, April 28, 2004. Between the World Road Champion encountered in a Norwegian night club, who sipped a beer, talked candidly, laughed easily and never let the conversation falter, and the cyclist with a stem, closed face, who fended off the July crowd, protected by a bodyguard or behind the smoked glass of the team bus, ten years had passed. July 1993. In the garden of an old-fashioned hotel near Grenoble, I interviewed Armstrong for three hours. It was the first professional season for this easygoing, slightly cowboyish, and very ambitious Texan. I left with a twenty-five-page interview, the chapter of a future book11 was writing about the Tour de France. I also took with me a real admiration for this young man, whom I thought had a promising future in cycling. Eight years later, in the spring of 2001, another interview. But the Tour of 1998 had changed things. Scandals and revelations were running rampant in cycling. Would my admiration stand the test? In August 1993, it was a happy, carefree, eloquent Armstrong, whom Pierre Ballester, met the evening after he won the World Championship in Oslo. -

World Rankings — Women's High Jump
World Rankings — Women’s High Jump 1956 1 .......................... Mildred McDaniel (US) Blanka Vlašić had 4 2 ........... Thelma Hopkins (Great Britain) straight No. 1s, 2007–10 3 ...................... Iolanda Balaş (Romania) 4 ........... Valentina Ballod (Soviet Union) 5 ..............Maria Pisareva (Soviet Union) 6 .................... Michele Brown (Australia) 7 .... Aleksandra Chudina (Soviet Union) 8 ....................Gunhild Larking (Sweden) 9 ....Olga Modrachová (Czechoslovakia) 10 .......... Hermina Geyser (South Africa) 1957 1 ......................Fengyung Cheng (China) 2 .................................Iolanda (Romania) 3 ............Taisia Chenchik (Soviet Union) 4 ........... Valentina Ballod (Soviet Union) 5 .............. Mary Donaghy (New Zealand) 6 ........... Thelma Hopkins (Great Britain) 7 ..............Maria Pisareva (Soviet Union) 8 ............ Hermina Geyser (South Africa) 9 .....................Mary Rand (Great Britain) 10 ................. Kathy Atkinson (Australia) 1958 1 ...................... Iolanda Balaş (Romania) 2 ............Taisia Chenchik (Soviet Union) 3 ......................Fengyung Cheng (China) 4 .................... Michele Brown (Australia) 5 .............. Mary Donaghy (New Zealand) 6 ............ Dorothy Shirley (Great Britain) 7 .......................... Helen Frith (Australia) 8 ..................Inge Kilian (West Germany) 9 .....................Mary Rand (Great Britain) 10 ............... Galina Dolya (Soviet Union) 1959 1 ...................... Iolanda Balaş (Romania) 2 ............Taisia -

Team Guide Con Tutte Le Schede Degli Azzurri
A Londra con una nuova generazione London: the new generation is coming Il Saluto di Alfio Giomi Message of Alfio Giomi Presidente della Federazione Italiana President of Italian di Atletica Leggera Athletics Federation Il Mondiale di Londra profuma di Olimpiade. A cin - The World Championships in London have an Olympic que anni dai Giochi della capitale britannica, la ras - taste. Five years after the Olympic Games in the segna iridata apre il quadriennio che porterà ai British capital, the World Championships open the Giochi di Tokyo 2020. Quattro anni nei quali l’atle - four-year period which will lead to the 2020 Olympic tica italiana sarà chiamata a completare il processo Games inTokyo. In the next four years Italian athletics di ricambio generazionale avviato già da qualche will be called to complete the generational change, stagione, e che sta proponendo sempre nuovi pro - which has already started for a few seasons and is tagonisti, tutti provenienti launching new rising stars. dalle squadre giovanili az - Every of them are coming zurre. L’estate del 2017 è già from the Italian youth and stata ricca di soddisfazioni per junior teams.The 2017 season le nostre formazioni Under: i has already provided very good Campionati europei Under results for our under 23 and 23 di Bydgoszcz e quelli under 20 teams.The European Under 20 di Grosseto hanno Under 23 Championships in confermato che scorre linfa Bydgoszcz and the European nuova, decisamente vitale, Under 20 Championships in nella grande pianta del nostro Grosseto have confirmed that movimento. Ed è bello ve - a new generation of athletes is dere che a Londra, al Mon - breathing new life into Italian diale assoluto, molti di quei athletics. -

Week 15 Cagliari Calcio V AS Roma 1-1 (0-1
Week 15 Week 16 Cagliari Calcio v AS Roma 1-1 (0-1) Hellas Verona v AC Fiorentina 1-1 (1-0) Saturday, 26 January 1974, RF: Trinchieri (Reggio Emilia), Stadio Sant’Elia, sent-off: Cordova Sunday, 3 February 1974, RF: Panzino (Catanzaro), Stadio Marcantonio Bentegodi Cagliari: Albertosi; Valeri, Poletti, C.Poli, Dessì, R.Roffi, D.Marchesi, Nené, S.Gori, C.Butti, L.Riva (46. Brugnera) Verona: Porrino; Nanni, Sirena, Busatta, Bet, G.Cozzi, Maddé, Mazzanti (74. Franzot), Fagni, Zaccarelli, Zigoni Inter: Conti; Peccenini, F.Rocca, G.Morini, Santarini, Batistoni, Orazi, Negrisolo, Domenghini, Cordova, Spadoni (73. G.Bertini) ACF: Superchi; Della Martira (31. Parlanti), Roggi, Beatrice, Brizi, Guerini, Caso, Antognoni, Saltutti, De Sisti, W.Speggiorin Scorers: 0-1 Orazi (22.),1-1 S.Gori (60., pen.) Scorers: 1-0 Maddé (42., pen.), 1-1 Caso (51.) SSC Napoli v Genoa FC 1-0 (1-0) Bologna FC v AS Roma 0-0 Sunday, 27 January 1974, RF: Casarin (Milano), Stadio San Paolo Sunday, 3 February 1974, RF: Gussoni (Tradate), Stadio Comunale Napoli: Carmignani; Bruscolotti, Pogliana, Zurlini, Vavassori, Orlandini, Cané, Juliano, Troja, S.Esposito, G.Braglia Bologna: Buso; Roversi (17. Caporale), Rimbano, Battisodo, Cresci, Gregori, Vieri, Massimelli, Savoldi, Bulgarelli, F.Landini Genoa: Spalazzi; Della Bianchina, A.Maggioni, Maselli, Rosato, Garbarini, S.Corradi, Bittolo, Pruzzo, Simoni, Corso (67. Mendoza) Roma: Conti; Peccenini, L.Liguori, G.Morini, Santarini (37. G.Bertini), Batistoni, Orazi, Negrisolo, Domenghini, F.Rocca, Spadoni Scorer: 1-0 Cané (41.) SSC Napoli v Cagliari Calcio 1-0 (0-0) AC Milan v US Foggia 1-0 (0-0) Sunday, 3 February 1974, RF: Picasso (Chiavari), Stadio San Paolo Sunday, 27 January 1974, RF: Angonese (Mestre), Stadio San Siro Napoli: Carmignani; Bruscolotti, Pogliana, Zurlini, Vavassori, Orlandini, Cané (72. -

Il Nostro Lavoro Su Roberto Rosato Ha Lo Scopo Di Celebrare Un Grandissimo Calciatore, Indimenticabile Per Gli Addetti Ai Lavori E Per I Tifosi in Genere
Giovanni Tarello – Davide Enrico Faccia d’Angelo Il nostro lavoro su Roberto Rosato ha lo scopo di celebrare un grandissimo calciatore, indimenticabile per gli addetti ai lavori e per i tifosi in genere. Non vuole essere una biografia nell’accezione del termine, bensì una storia del calcio di quel tempo raccontata attraverso la viva voce di un eccellente protagonista, il quale ci ricorda gli incontri, le sensazioni, i campioni e i comprimari che hanno condiviso con lui mille avventure di gioco e non solo. Gli autori a Oberdan Stefano Ussello e Nereo Rocco con eterna e infinita riconoscenza Roberto Rosato 1 Giovanni Tarello – Davide Enrico Faccia d’Angelo Prefazioni L’omaggio di un grande giornalista: Bruno Bernardi Messico e nuvole. Sopra quelle nuvole, nell’estate del 1970, brillò la stella di Roberto Rosato. Lo stopper azzurro venne inserito nella «top 11» del Mundial vinto dal Brasile di Pelè nella finalissima con l’Italia di Gigi Riva e della staffetta Mazzola-Rivera. Il «killer con la faccia d’angelo», come l’avevano soprannominato quando giocava nel Toro, toccò la vetta più alta della sua carriera di stopper ruvido e al tempo stesso classico. E pensare che era partito come riserva del cagliaritano Niccolai che fece esclamare a Scopigno: «Mai avrei immaginato di vedere Comunardo in mondovisione». Durante la prima gara con la Svezia, un infortunio bloccò Niccolai e le porte della Nazionale si riaprirono per Rosato. All’epoca Rosato giocava nel Milan, la squadra nella quale, nell’arco di sei stagioni, ha vinto tutto o quasi. Dal titolo europeo con l’Italia allo scudetto, da tre Coppe Italia a due Coppe delle Coppe, dalla Coppa dei Campioni alla Coppa Intercontinentale.