Ripartizione E Impegno Sul Capitolo R47903 Missione 09, Programma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
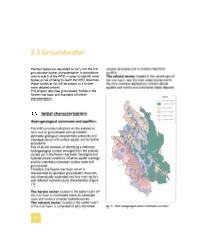
2.3. Initial Characterisation
Member Statesare requested to carry out the first volcanic structures and it contains important groundwater bodies characterisation in accordance aquifers; with Artide 5 of the WFD in arder to identify water The alluvial secter, located in the centrai part of bodies at risk of failingto reach the WFD objectives. the river basin,near the main watercourses and in Water bodies at risk will be subject to a further; the intra-montane depressions,contains alluvial more detailed analysis. aquifers and marine and continental clastic deposits; This chapter describesgroundwater bodies in the Tevere river basin and examples offurther characterisation. 2.3. Initial characterisation Hydrogeological structures and aquifers The WFD provides indications on the analyses to carry out on groundwater; such as: location, perimeter; geological characteristics, pressures, and interdependence with surface aquatic and terrestrial ecosystems. First of all, the necessity of identifying a reference hydrogeological context emerged from the analyses carried out in the Tevere river basinoGeological and hydrostructural conditions influence aquifertypology and the interrelation between surface water and groundwater: Therefore, theTevere river basin..which is characterized by abundant groundwater resources, was schematically subdivided into four main sectors with different hydrostructural characteristics (Figure 17): The karstic sector, locatedin the easternpart of the river basin,is constitutedmainly by carbonate rocksand contains complex hydrostructures; The volcanic sector, locatedin the westernpart of the river basin,is composedof pery-thyrrenian Fig. 17 - MQin hydroge%gica/ sectorsin the Tevereriver basin The flysch sector, located in the upper part ofthe basin,is characterized by turbidites sequences consistingof marls, shales,clays and sandstoneswith evaporites.Only in the more permeable arenaceous sediments,water circulation sustainsan appreciable perennial base flow. -

Piccoli Comuni Comunità Montane
La montagna del Lazio: situazione e prospettive A cura di Patrizia Di Fazio MANIFESTO DELLA MONTANITA’ L’Uncem Lazio, il soggetto sindacale, culturale e politico delle Comunità Montane del Lazio, ha svolto una profonda riflessione sul ruolo e sul futuro delle istituzioni locali per fornire, in occasione delle elezioni regionali del 4 marzo p.v., un opportuno apporto alla necessaria riforma del governo delle aree montane ed interne, già in atto a livello nazionale e regionale, ed oggi: 1. Sottolinea la specialità e l’importanza dell’amministrazione delle zone montane del Lazio da cui dipende il welfare di 1.047.116 di cittadini, il 18% dell’intera popolazione e la tenuta territoriale della maggioranza della superficie regionale, 8.928,52 Kmq, il 52% di essa, che 245 Comuni Montani su 378, cioè il 65%, associati in Comunità Montane, difendono, manutengono e promuovono. 2. Indica come compito prioritario quello di depurare la concezione degli enti di gestione territoriale dalle scorie populistiche innescate dai media e da diffusi pregiudizi, in assenza di qualsiasi cognizione ed esperienza sul loro effettivo ruolo istituzionale. 23/02/2018 1 2 3. Afferma che le Comunità Montane del Lazio sono un patrimonio di pluridecennale esperienza amministrativa; di personale politico e funzionale di consolidata professionalità e pronto ad adeguarsi alle nuove sfide; di politiche di crescita create e sviluppate a contatto e prossimità delle popolazioni montane. Tale patrimonio può e deve essere pienamente valorizzato 4. Indica come fondativa, in ossequio all’art.44 della Costituzione, la specialità e peculiarità della Montanità, caratterizzata dai condizionamenti, spesso negativi e talvolta drammatici, che interessano i cittadini che abitano luoghi montani, derivanti dagli agenti atmosferici, dai dissesti idrogeologici, dalle particolari cure e manutenzioni straordinarie, di cui necessitano le infrastrutture viarie, boschive, idriche, commerciali, scolastiche, sanitarie, postali, energetiche, informatiche, sociali, e culturali. -

Profile of a Plant: the Olive in Early Medieval Italy, 400-900 CE By
Profile of a Plant: The Olive in Early Medieval Italy, 400-900 CE by Benjamin Jon Graham A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in the University of Michigan 2014 Doctoral Committee: Professor Paolo Squatriti, Chair Associate Professor Diane Owen Hughes Professor Richard P. Tucker Professor Raymond H. Van Dam © Benjamin J. Graham, 2014 Acknowledgements Planting an olive tree is an act of faith. A cultivator must patiently protect, water, and till the soil around the plant for fifteen years before it begins to bear fruit. Though this dissertation is not nearly as useful or palatable as the olive’s pressed fruits, its slow growth to completion resembles the tree in as much as it was the patient and diligent kindness of my friends, mentors, and family that enabled me to finish the project. Mercifully it took fewer than fifteen years. My deepest thanks go to Paolo Squatriti, who provoked and inspired me to write an unconventional dissertation. I am unable to articulate the ways he has influenced my scholarship, teaching, and life. Ray Van Dam’s clarity of thought helped to shape and rein in my run-away ideas. Diane Hughes unfailingly saw the big picture—how the story of the olive connected to different strands of history. These three people in particular made graduate school a humane and deeply edifying experience. Joining them for the dissertation defense was Richard Tucker, whose capacious understanding of the history of the environment improved this work immensely. In addition to these, I would like to thank David Akin, Hussein Fancy, Tom Green, Alison Cornish, Kathleen King, Lorna Alstetter, Diana Denney, Terre Fisher, Liz Kamali, Jon Farr, Yanay Israeli, and Noah Blan, all at the University of Michigan, for their benevolence. -

Sistema Geografico Della Montagna Del Lazio
Enti Locali e Politiche per la Sicurezza EIM Ente Italiano della Montagna SISTEMA GEOGRAFICO DELLA MONTAGNA DEL LAZIO POLITICHE, ECONOMIA E TERRITORIO I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Coordinatore della ricerca: Stefano Pignotti Gruppo di ricerca: Chiara Finocchietti Clelia Losavio Vincenzo Bonanno Alessandro Cinnirella Luigi Falco Pier Paolo Poncia REGIONE LAZIO Direzione Regionale Enti locali Software sviluppato in collaborazione con e Politiche per la Sicurezza SI2G S.r.l., spin-off company Via Rosa R. Garibaldi, 7 Università Politecnica delle Marche, Ancona 00145 ROMA Grafica: UNCEM Cliccaquì sas Delegazione regionale del Lazio Viale Castro Pretorio, 116 Elaborazione cartografica e stampa: 00185 ROMA SystemCart srl EIM Ente Italiano della Montagna Si ringraziano Rosanna Farina per l’attività di rendicontazione Piazza dei Caprettari, 70 finanziaria del progetto e Alessandra Cupelli per la revisione del 00186 ROMA testo. SISTEMA GEOGRAFICO DELLA MONTAGNA DEL LAZIO ono molto felice di poter scrivere la prefazione alla pub- blicazione “Sistema Geografico della Montagna del S Lazio. Politiche, economia e territorio”, che raccoglie i frutti di un lavoro pluriennale condotto da un’équipe di ricerca- tori dell’Ente Italiano della Montagna. Questo volume, oltre a fornire scenari interessanti e in parte inediti relativi alla composizione fisica, socio-economica, e di accessibilità delle aree montane del Lazio, offre anche una ricognizione delle possibilità offerte dalla programmazione comunitaria, opportunità in gran parte ancora da scoprire e da utilizzare per rispondere ai tanti bisogni di questa splendida parte del territorio della Regione Lazio. -

IPOGEA 4 5 Cappa.Indd
Ipogea n. 4 (2005): pp. 53 - 64 GIULIO CAPPA, ALBERTA FELICI, EMANUELE CAPPA SOME PECULIAR FEATURES OF KARST DEVELOPMENT IN LATIUM DURING THE QUATERNARY Abstract CAPPA G., FELICI A. & CAPPA E. - Some peculiar features of karst development in latium during the qua ter nary - Alcuni aspetti particolari dello sviluppo dei fenomeni carsici nel lazio durante il quaternario – Ipogea, 4: 53-64. The development of karstic phenomena in Latium is fairly recent: the traces of any appreciable evolution older than the begin- ning of Quaternary are scanty. Yet, there is evidence of peculiar features which mark this region, depending on other three factors that have infl uenced the karst evolution, they have been identifi ed during these last years and are the subject of this note. The most remarkable and widely spaced phenomenon is a consequence of the superimposition of volcanic ash deposits onto calcareous massifs, at a time when their karst was already well developed; the pyroclastites went up to a thickness of a few metres, concentrated in the hollows and stopped many hypogean water fl ows. After several ten thousands years the surface ablation and the percolation reactivate such karstic networks, some times by sudden and catastrophic collapses. A second feature is related to karst hypogean very fast development in pleistocenic conglomerates, owing to the sudden uplift of one of such units. The third one is a consequence of the formation during Pleistocene and even Holocene of large and thin units of travertines in several parts of the region, laying both upon calcareous and volcanic rocks; the authors have particularly investigated them along the river Aniene valley. -

Classe Quinta GEOGRAFIA
Classe quinta GEOGRAFIA Iniziamo una nuova regione….il Lazio! Imposta la pagina come sai già (abbiamo fatto nello stesso modo tutte le regioni dell’Italia!) - Scrivi il titolo: LAZIO - Incolla la cartina dell’Italia e colora la regione - A fianco scrivi: Regione dell’Italia centrale, poi sotto MONTI: Monti della Laga Monti Reatini Monte Terminillo Monti Sabini Monti Cimini Monti Simbruini Monti della Meta Monti Aurunci Monti Ausoni Monti Volsini LAGHI: Lago di Bolsena Lago Bracciano L. di Vico L. di Sabaudia FIUMI: Tevere Sacco Aniene Liri Turano Garigliano Salto Tronto PIANURE: Agro Pontino (un tempo paludoso, ora bonificato) Agro Romano Maremma Laziale ISOLE: Isole Ponziane CONFINI: nord ovest: Toscana nord: Umbria nord est: Marche est: Abruzzo e Molise sud est: Campania Ovest: Mar Tirreno SETTORI Primario: coltivazione di ortaggi, olive, viti, nocciole, allevamento di bufale da cui si ricava la mozzarella di bufala, pecorino romano, addestramento di cavalli Secondario: industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, elettroniche, attività artigianali, ceramica, industria automobilistica Terziario: turismo balneare (aeroporto internazionale e porto a Civitavecchia), agriturismi, terme, sport invernali. PROVINCE: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo CLIMA: continentale con inverni rigide e secche ed estati calde. Verso l’interno e sui rilievi gli inverni sono freddi. - Disegna l’areogramma del territorio (vedi libro pag. 181). - Piatto tipico: pasta cacio e pepe - Curiosità: Ciao mi chiamo Artemisia Gentileschi e sono nata a Roma nel 1591. Da bambina mi piaceva andare nella bottega del mio papà, che era un pittore, e così ho imparato a dipingere sono diventata un’artista anche io! - Ora scrivi il titolo ROMA e sotto riscrivi ciò che ti riporto: ROMA è la capitale della Repubblica italiana ed è il capoluogo di regione del Lazio. -

Comuni Piano Neve 1/4 F.Castellaccio
1 Affile 1 Comunità Montana dell'Aniene 2 Agosta 4 Comunità Montana dell'Aniene 3 Albano Laziale 8 4 Allumiere 9 Comunità Montana Monti della Tolfa Anguillaria Sabazia 5 Anticoli Corrado 4 Comunità Montana dell'Aniene Anzio 6 Arcinazzo 1 Comunità Montana dell'Aniene Ardea 7 Ariccia 8 8 Arsoli 4 Comunità Montana dell'Aniene Artena Comunità Montana Monti Lepini 9 Bellegra 5 Comunità Montana dell'Aniene Bracciano 10 Camerata Nuova 4 Comunità Montana dell'Aniene Campagnano di Roma 11 Canale Monterano 9 12 Canterano 3 Comunità Montana dell'Aniene Capena 13 Capranica Prenestina 6 Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini 14 Carpineto Romano 7 Comunità Montana Monti Lepini 15 Casape 11 Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini 16 Castel Gandolfo 8 17 Castel Madama 11 Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini 18 Castel San Pietro Romano 6 Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini Castelnuovo di Porto Cave Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini 19 Cerreto Laziale 3 Comunità Montana dell'Aniene 20 Cervara di Roma 1 Comunità Montana dell'Aniene Cerveteri Ciampino 21 Ciciliano 3 Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini 22 Cineto Romano 2 Comunità Montana dell'Aniene Civitavecchia Civitella San Paolo 23 Colleferro 7 24 Colonna 8 Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini Fiano Romano Filacciano comuni piano neve 1/4 f.castellaccio Fiumicino Fontenuova Formello 25 Frascati 8 Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini Gallicano nel Lazio Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini 26 Gavignano 7 27 Genazzano 5 Comunità Montana Castelli -

Corpi Idrici Sotterranei - Regione Lazio
Corpi idrici sotterranei - Regione Lazio Dati idrostruttura Dati Mouton Ubicazione Sigla SIGLA Regioni Nome struttura Ente di provenienza del dato Altre denominazioni Note Sub-Unit Distretto ABT MOUTON interessate A6 Acquifero della bassa valle del Tevere (ABT) Regione Lazio - Autorità di Bacino del F. Tevere Acquifero minore dei Fiumi Tevere e Aniene (Regione Lazio) Condivisa tra i due enti AV Umbria-Lazio Tevere Appennino Centrale Utilizzataladelimitazionedell'AutoritàdiBacino perchélastrutturanelPTAdellaRegioneLazio A8 Acquifero della piana di Leonessa (ABT) Regione Lazio - Autorità di Bacino del F. Tevere AV Umbria-Lazio Tevere Appennino Centrale risulta compresa nel "Sistema del Monte Terminillo" Utilizzataladelimitazionedell'AutoritàdiBacino Sistema del Monte Terminillo (Regione Lazio) perchélastrutturaidentificatadallaRegione C5a Unità del M.te Terminillo (ABT) Autorità di Bacino del F. Tevere AV Lazio Tevere Appennino Centrale Laziocomprendeanchel'acquiferodellaPianadi Leonessa e parte dell'idrostruttura C5b Utilizzataladelimitazionedell'AutoritàdiBacino Marche-Umbria- Tevere - ABR Marche - C5b Unità della Valnerina Autorità di Bacino del F. Tevere perchénelPTARegioneLazioècompresanella CA Appennino Centrale Lazio Tronto struttura C5a A9 Acquifero della piana reatina (ABT) Regione Lazio - Autorità di Bacino del F. Tevere Acquifero minore della Piana Reatina (Regione Lazio) Condivisa tra i due enti AV Lazio Tevere Appennino Centrale C7 Sistema Stifone-Montoro Regione Lazio - Autorità di Bacino del F. Tevere Sistema di Stifone-Montoro (Regione Lazio) Condivisa tra i due enti CA Umbria-Lazio Tevere Appennino Centrale Utilizzataladelimitazionedell'AutoritàdiBacino perchélastrutturaidentificatadallaRegione C8 Sistema delle Capore (ABT) Autorità di Bacino del F. Tevere CA Lazio Tevere Appennino Centrale LaziocomprendeanchepartedellastrutturaC12 e i depositi clastici Appennino Centrale- C9 Sistema di M.te Nuria e M.te Velino (ABT) Regione Lazio - Autorità di Bacino del F. -

Il Programma Ottobre 2008 – Gennaio 2009 Di Trekking Italia, Sede Di Roma
Roma Associazione Amici del Trekking e della Natura Programma n. 10 IIll PPrrooggrraammmmaa Ottobre 2008 – Gennaio 2009 Questo è il programma ottobre 2008 – gennaio 2009 di Trekking Italia, sede di Roma. Noi “trekkaroli” siamo attivi dalla fine del 2005 e la voglia di camminare e crescere non ci è passata! Venerdì 3 Ottobre ore 19.30 Domenica 5 Ottobre Trekking Italia... Special Serata Fotografica Abruzzo- Monti della Laga ...è nata nel 1985, è Trekking in Nuova Zelanda Trek: Monte Civitella un’associazione senza un affascinante viaggio agli antipodi (Traversata Mopolino – Poggio Cancelli) scopo di lucro, iscritta nella terra dei Maori nell’Albo Nazionale delle Foto di Leonardo Pucci, Daniela De Da Mopolino, attraverso il bosco, colorato dai primi Associazioni di caldi colori autunnali, si arriva alla forchetta di Sanctis e Mauro Coletta Promozione Sociale, che Mopolino, poi per creste fino al Monte Civitella (m. 1603) e discesa a Poggio Cancelli. Scorci vive e si sviluppa grazie Una presentazione del trek che si svolgerà da domenica 28 dicembre 2008 indimenticabili sul Gran Sasso, il Lago di Campotosto, alla partecipaz ione dei soci. E’ presente con a lunedì 19 gennaio 2009. i Monti della Laga, i Sibillini, la conca di Amatrice. Per approfondimenti vai su www.trekkingitaliaroma.it Potremo avere la fortuna di vedere l’aquila reale ed il proprie sedi a Milano, Ingresso libero falco pellegrino volteggiare in cerca di prede. Genova, Torino, Firenze, Alla proiezione sono invitati tutti gli interessati, Bologna, Venezia e soci e non soci. Dislivello m. 650 – Escursione E – Durata h. 5.00-6.00 Ritrovo dei partecipanti ore 7.30 - P.zza S. -

D07 Copertina R OK C August 20-28,2004 Florence -Italy
Volume n° 3 -from D01 to P13 32nd INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS THE RIETI INTERMOUNTAIN BASIN AND S. FRANCESCO D’ASSISI Leader: C. Carrara Associate Leaders: L. Ferreli, L. Guerrieri, L. Serva Field Trip Guide Book - D07 Field Trip Florence - Italy August 20-28, 2004 During-Congress D07 D07_copertina_R_OK C 24-05-2004, 14:02:32 The scientific content of this guide is under the total responsibility of the Authors Published by: APAT – Italian Agency for the Environmental Protection and Technical Services - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - Italy Series Editors: Luca Guerrieri, Irene Rischia and Leonello Serva (APAT, Roma) English Desk-copy Editors: Paul Mazza (Università di Firenze), Jessica Ann Thonn (Università di Firenze), Nathalie Marléne Adams (Università di Firenze), Miriam Friedman (Università di Firenze), Kate Eadie (Freelance indipendent professional) Field Trip Committee: Leonello Serva (APAT, Roma), Alessandro Michetti (Università dell’Insubria, Como), Giulio Pavia (Università di Torino), Raffaele Pignone (Servizio Geologico Regione Emilia-Romagna, Bologna) and Riccardo Polino (CNR, Torino) Acknowledgments: The 32nd IGC Organizing Committee is grateful to Roberto Pompili and Elisa Brustia (APAT, Roma) for their collaboration in editing. Graphic project: Full snc - Firenze Layout and press: Lito Terrazzi srl - Firenze D07_copertina_R_OK D 24-05-2004, 14:04:14 Volume n° 3 - from D01 to P13 32nd INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS THE RIETI INTERMOUNTAIN BASIN AND S. FRANCESCO D’ASSISI AUTHORS: C. Carrara1, L. Ferreli2, L. Guerrieri2, L. Serva2 1 c/o IGAG - CNR, Roma - Italy 2 APAT - Italian Agency for Environmental Protection and Technical Services, Roma - Italy Florence - Italy August 20-28, 2004 During-Congress D07 D07_R_OK A 24-05-2004, 13:46:12 Front Cover: Geological landscapes and Franciscan sanctuaries in the Rieti basin D07_R_OK B 24-05-2004, 13:46:14 THE RIETI INTERMOUNTAIN BASIN AND S. -

Geologia Archeologia Ambiente Paesaggio
Geologia La storia dei luoghi Archeologia La storia degli uomini Il Lazio è stato modellato dai vulcani, si potrebbe dire Il rinvenimento di tracce di dinosauri in più siti La storia più recente, quella del Quaternario, nel Lazio Il percorso della storia dell’uomo nel Lazio, l’evolversi Lo sviluppo di comunità protostoriche intorno alla Il territorio appare fortemente condizionato dalla presenza con una battuta. L’Africa spinge verso nord e si incunea sotto dell’area orientale e meridionale della regione (Monti appare di estremo interesse per le implicazioni determinate delle strategie d’uso delle risorse e del suolo, i modelli di fine dell’Età del Bronzo e gli inizi Età del Ferro, indicano il romana, dalle infrastrutture urbane a vocazione portuale dei la zolla continentale euroasiatica. La risultanza delle immani Prenestini, Lepini e Ausoni), tra cui le spettacolari piste e dal rinvenimento delle tracce della presenza umana sin frequentazione, dapprima insediativi e successivamente di mutare del modello insediativo costituito da piccoli centri complessi di Ostia e Portus, alle spettacolari testimonianze forze che governano la deriva dei continenti produce zone impronte di Sezze ed Esperia, hanno acceso solo da poco dalla più remota preistoria. tipo stanziale, coprono un lasso di tempo assolutamente diffusi, verso la formazione di nuclei protourbani sempre più di Tivoli con Villa Adriana e l’intero contesto archeologico di compressione e distensione, lungo le quali si sono formati una nuova luce sulla biogeografia di questo settore della eccezionale e pongono la nostra regione in una posizione complessi e articolati, che daranno origine a quel mondo di Tibur, fino ai centri diTusculum e ancora all’imponente gli apparati vulcanici, dal Vulcano Vulsino alle isole ponziane. -

Analisi Dello Status E Della Distribuzione Dei Rapaci Diurni Nidificanti Nel Lazio
ANALISI DELLO STATUS E DELLA DISTRIBUZIONE DEI RAPACI DIURNI NIDIFICANTI NEL LAZIO foto di Vincenzofoto di Penteriani Quaderni - Natura e Biodiversità 2/2012 1 Informazioni legali L’istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo Quaderno. La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha isti- tuito l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT), dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e del- l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM). Informazioni legali ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.it ISPRA, Quaderni – Natura e Biodiversità n. 2/2012 ISBN 978–88–448–0529–6 Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica: ISPRA Editing e grafica: Paolo Di Orazio Grafica di copertina: Franco Iozzoli Foto di copertina: Albanella minore (Roberto Ragno) – Astore, Grifone (Vincenzo Pen- teriani) – Grillaio (Stefano Laurenti), Falco pecchiaiolo, Aquila reale (Michele Cento) Coordinamento tipografico: Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria Citazione del volume: Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M. 2012. Analisi dello status e della distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nel Lazio. Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA, ARP Lazio.