I Giorni Delle Aquile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Battle of Britain Blood Red Skies
Battle of Britain Blood Red Skies (BRS) Campaign The German “Blitzkrieg”, a new way of waging “lightning war” had raged through first Poland, then in the early summer of 1940 struck at Holland, Belgium and France. The Luftwaffe (German air force) crushed all opponents in the air, and then fast moving armour with ever present air support sliced through ground forces leaving their opponents scrabbling to hold defensive positions that were already untenable. The British Expeditionary Force fell back to Dunkirk and was evacuated against the odds. During this period the RAF (Royal Air Force) had desperately tried to defend the Dunkirk beaches and the constant stream of ships large and small ferrying the remains of the BEF back home. When the last ships left over 338000 men had been evacuated, British and French, but they were exhausted and had abandoned all their weapons and heavy equipment on French roads and beaches. As Churchill said “What General Weygand has called the Battle of France is over ... the Battle of Britain is about to begin” The Battle of Britain was fought in the skies above England in the summer of 1940. The Luftwaffe were seeking to destroy the RAF to clear the way for a cross Chanel assault by the German Army. If they could succeed, Britain would be threatened with defeat and the war would be over. If the RAF could survive, then there may be time to prepare the defences, and possibly take the fight back to the enemy in due course. This campaign is designed to allow players to recreate some of the desperate battles fought in the summer of 1940 using the Blood Red Skies (BRS) rules from Warlord Games. -

FIAT BR.20 Cicogna "Battle of Britain"
Via Pradazzo, 6/b 40012 Calderara di Reno Bologna - Italy Conservare il presente indirizzo per Retain this address www.italeri.com futuro riferimento for future reference Made in Italy 1:72 scale No 1447 FIAT BR.20 Cicogna "Battle of Britain" EN FR The BR 20 “Cicogna” low wing medium bomber was developed by the Italian Le bombardier à ailes basses moyennes BR 20 « Cicogna » a été développé aircraft manufacturer Fiat during the 1930’s. It entered service in 1936 and par la société italienne Fiat dans les années trente. Il entre en service en was characterized by its metal frame and retractable landing gear. Modern 1936 et se caractérise par une structure métallique et un train d’atterrissage and fast for the period, it was deployed by the “Aviazione Legionaria” and rétractable. Moderne et rapide pour l’époque, il fut employé par l’aviation légionnaire et eut son baptême du feu en 1937 pendant la guerre civile 1940, the “Corpo Aereo Italiano”, consisting of the 13th and 43rd “Stormo espagnole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il équipa plusieurs dépar- da Bombardamento” were similarly equipped with the BR-20. The “Stormi” tements de bombardement de la Regia Aeronautica. En septembre 1940, were stationed in Belgium and supported the Luftwaffe during the Battle of l’Air Corps italien est formé, composé des 13e et 43e escadres de bombar- dement équipées du bimoteur Fiat. Les services de vol étaient situés en exposed the BR-20’s limits, it was used for the duration of WW2 on various Belgique et ont participé, en soutien à la Luftwaffe allemande, à la bataille fronts by several Regia Aeronautica bomber squadrons. -

Bataille-D-Angleterre.Pdf
Bataille d'Angleterre 1 Bataille d'Angleterre Bataille d'Angleterre Photographie de propagande allemande représentant un chasseur britannique Supermarine Spitfire (capturé) aux prises avec un bombardier allemand Dornier Do 17. Informations générales Date Juillet 1940 ( Blitz: Jusqu'à Mai 1941 Lieu Sud de l'Angleterre Issue Victoire britannique Belligérants Royaume-Uni Reich allemand Royaume d'Italie Commandants Hugh Dowding Hermann Göring Forces en présence Royal Air Force Luftwaffe 1 963 avions Regia Aeronautica 4 074 avions Pertes 1 547 avions abattus, 1 887 avions abattus avec tous les équipages tués ou prisonniers 417 pilotes et 27 450 civils tués Seconde Guerre mondiale Batailles Bataille d'Angleterre 2 Front d'Europe de l'Ouest Campagnes du Danemark et de Norvège · Bataille de France · Bataille de Belgique · Bataille des Pays-Bas · Bataille d'Angleterre · Blitz · Opération Ambassador · Débarquement de Dieppe · Sabordage de la flotte française à Toulon · Campagne d'Italie · Libération de la Corse · Bataille de Normandie · Débarquement de Provence · 2e campagne de France · Opération Market Garden · Bataille du Benelux · Bataille de la forêt de Hürtgen · Bataille de l’Escaut · Poche de Breskens · Bataille d'Aix-la-Chapelle · Bataille de Bruyères · Bataille des Ardennes · Siège de Bastogne · Opération Bodenplatte · Opération Nordwind · Poche de Colmar · Campagne d'Allemagne (Traversée du Rhin · Opération Veritable · Opération Varsity · Poche de la Ruhr) · Bataille de Groningue · Insurrection de Texel Front d’Europe de l’Est Campagnes d'Afrique, du Moyen-Orient et de Méditerranée Bataille de l’Atlantique Guerre en Asie et dans le Pacifique Guerre sino-japonaise La bataille d'Angleterre (Battle of Britain) est un épisode essentiel de la Seconde Guerre mondiale, opposant de juillet 1940 à mai 1941 les armées de l'Air du Royaume-Uni et de l'Allemagne, soutenue par l'Italie, dans une campagne aérienne marquée par les bombardements de Coventry et de Londres, souvent désignée par l'expression « le Blitz ». -

Italy-Ww2.Pdf
Italy Air Aces 1936-1945 Regia Aeronautica, Aeronautica Militare Italiana, Aeronautica Nazionale Repubblicana, Super Aereo Regia Aeronautica, Italian Co-Belligerent AF, Stato Maggiore Regia Aeronautica Jan J. Šafařík http://aces.safarikovi.org/ http://aces.safarikovi.eu/ © 2005 – 2018 Jan Josef Šafařík Fri Dec 21 13:27:15 CET 2018 Regia Aeronautica Copyright © Jan J. Šafařík By total number of victories Capitano Franco Lucchini Medaglia d'Oro al Valor Militare 24 December 1917 – 5 July 1943 Copyright © Jan J. Šafařík Victories Name Confirmed Probable Damaged Other Victories Units Comments Lucchini, Franco 74 [22+52] 4 [2+2] 9 [6+3] 0+5 gr, 0+3 gr.dam. 19a, 90a, c 84a, c 10° Gr 1 SpCW Reiner, Giulio 67 [10+57] 30 [7+23] 11 [2+9] 3+3 gr c 73a Martinoli, Teresio 36 [22+14] 3 [2+1] 5 [1+4] 384a, 78a, 84a, 73a, 9° Gr C-B AF 22 [1] Fanali, Duilio Sergio 34 [2+32] 2 [0+2] 160a, 155° Gr Botto, Ernesto ‘Gamba di Ferro’ 28 [8+20] 5 [1+4] 32a, 9° Gr 5+5 SpCW, 7 [1] Minguzzi, Vittorio 26 [15+11] 13 [12+1] 22 [7+15] 10 gr 35a, 19a, 359a, c 22° Gr 3+4 SpCW, 5 [1] Monti, Luigi 26 [8+18] 2 [0+2] 1 c 90a, 24a, c 84a, c 10° Gr, c 4° St 5 SpCW Solaro, Claudio 26 [12+14] 1 20 gr XVI° Gr, c 70a 1 SpCW, 11 [1] Ferrulli, Leonardo 25 [22+3] 3 [1+2] 1 91a, 90a 1 SpCW, 21 [1] Romagnoli, Carlo 24 [11+13] 6 [0+6] 26a, 10° Gr 9 SpCW Torresi, Giulio 20 [10+10] 7 [5+2] 11 [0+11] 77a, 362a, c 3a ANR Drago, Ugo 20 [17+3] 363a, c 4a ANR Piccolomini Clementini, Ranieri 19 [7+12] 7 [4+3] 4 97a, c 90a, c 10° Gr Bordoni-Bisleri, Franco 'Robur' 19 4 possibly 18 shared 95a, -

RAF Variant Rules #1.45 Mar 2014
RAF Variant Rules #1.45 Mar 2014 By Simon D Blackwell Introduction These rules are the final updated and expanded version of my earlier submissions #1.0-#1.4. They now incorporate the Miles Master M.24 Emergency fighter, as well as a tweak to the stats of the Fw.200. Also included are all the previous new aircraft types and the hypothetical ones of which all either were or could have been seen over the skies of Sussex, Kent and the Thames estuary in 1940. I was prompted to write these rules after playing the original game a few times and dimly remembering a turret armed British fighter that had no forward firing machine guns. The fighter in question was the Boulton Paul Defiant of which 2 Sqns served in the Battle of Britain. Left out of the game I suspect owing to its combat record which can only be described as disastrous I decided for historical accuracy more than attempting to change the balance of the game to introduce these much maligned aircraft to the game. After a few plays my appetite was whetted sufficiently to research introducing other aircraft not featured in the original game. As the reader will note from the sheer number of new aircraft types listed below, this became a much larger project than originally envisaged but proved far more interesting and enjoyable. I also decided to keep from the original variant rules just 1 elite RAF Sqn as there is an alternative unit to choose from that has the same stats as the withdrawn unit (263 Sqn Whirlwind). -

Britain Begins Pdf, Epub, Ebook
BRITAIN BEGINS PDF, EPUB, EBOOK Sir Barry Cunliffe | 568 pages | 01 Jan 2014 | Oxford University Press | 9780199679454 | English | Oxford, United Kingdom Britain Begins PDF Book The campaign was planned to begin with attacks on airfields near the coast, gradually moving inland to attack the ring of sector airfields defending London. Such has been the conduct of Sir Robert Walpole, with regard to foreign affairs: he has deserted our allies, aggrandized our enemies, betrayed our commerce, and endangered our colonies; and yet this is the least criminal part of his ministry. You can tell it's written by an archaeologist by the way that everything in it is evidence-based rather than a straightforward narrative. There are also three "interlude" chapters where Cunliffe examines issues outside of the chronological framework the chapters otherwise follow. By the final pages, a tilt or bias toward the classical era is evident. Retrieved 5 November Speck says that Walpole's uninterrupted run of 20 years as Prime Minister. Stripped of its fighters, Luftflotte 3 would concentrate on the night bombing campaign. The Westminster parliament's Declaratory Act also called the Dependency of Ireland on Great Britain Act noted that the Irish House of Lords had recently "assumed to themselves a Power and Jurisdiction to examine, correct and amend" judgements of the Irish courts and declared that as the Kingdom of Ireland was subordinate to and dependent upon the crown of Great Britain, the King , through the Parliament of Great Britain, had "full power and authority to make laws and statutes of sufficient validity to bind the Kingdom and people of Ireland". -

A Myth and Reality in the Fascist War: the Ministry of Popular
Myth and Reality in the Fascist War: The Ministry of Popular Culture and Italian Propaganda on the Bombing of Civilians, 1938-1943 Luigi Petrella Doctor of Philosophy School of History, Classics and Archaeology 26 October 2015 a Abstract New studies that focus on the air bombardment of civilians in Italy during the Second World War regard the Italian home front as a privileged ‘observation post’ from which to study the relationship between Fascism and society during the years of the collapse of Mussolini’s regime. Yet the role of propaganda, on the specific aspect of people vulnerability to total war, in influencing that relationship, has received little attention. The main aim of this work is to reconstruct the narrative of bombing and of civilians’ life in Italy during the first phase of the war (1940-1943) as it emerges from reports, stories and works of invention in the Italian media. These have been compared with both the public reaction and the regime propaganda that had constructed some of the most powerful ideological tenets of the Italian Fascism during the 1930s, first of all the myth of air power and the creation of a ‘new man’. Investigating specific sections of the home front and situating the breakup of the Italian morale at the time of the first serious setbacks of Mussolini’s armies at the end of 1940, this research focuses in particular on the effectiveness - or otherwise - of government policies in steering the media and cultural activities that reflected life in wartime Italy. Drawing mostly on primary sources such as government papers, personal memoirs, censored letters and confidential reports, the study argues that propaganda’s failure to continue to bolster Fascist myths was due both to the catastrophic impact of war on civilians’ life and to institutional and political flaws. -

FALL 2016 - Volume 63, Number 3 the Air Force Historical Foundation Founded on May 27, 1953 by Gen Carl A
FALL 2016 - Volume 63, Number 3 WWW.AFHISTORY.ORG The Air Force Historical Foundation Founded on May 27, 1953 by Gen Carl A. “Tooey” Spaatz MEMBERSHIP BENEFITS and other air power pioneers, the Air Force Historical All members receive our exciting and informative Foundation (AFHF) is a nonprofi t tax exempt organization. Air Power History Journal, either electronically or It is dedicated to the preservation, perpetuation and on paper, covering: all aspects of aerospace history appropriate publication of the history and traditions of American aviation, with emphasis on the U.S. Air Force, its • Chronicles the great campaigns and predecessor organizations, and the men and women whose the great leaders lives and dreams were devoted to fl ight. The Foundation • Eyewitness accounts and historical articles serves all components of the United States Air Force— Active, Reserve and Air National Guard. • In depth resources to museums and activities, to keep members connected to the latest and AFHF strives to make available to the public and greatest events. today’s government planners and decision makers information that is relevant and informative about Preserve the legacy, stay connected: all aspects of air and space power. By doing so, the • Membership helps preserve the legacy of current Foundation hopes to assure the nation profi ts from past and future US air force personnel. experiences as it helps keep the U.S. Air Force the most modern and effective military force in the world. • Provides reliable and accurate accounts of historical events. The Foundation’s four primary activities include a quarterly journal Air Power History, a book program, a • Establish connections between generations. -

NUNAWADING MILITARY HISTORY GROUP MINI NEWSLETTER No. 16
NUNAWADING MILITARY HISTORY GROUP MINI NEWSLETTER No. 16 19Il Duce’s Blitz — Italy’s Forgotten Role in the Battle of Britain The Fiat Falco was just one of the more than 170 Italian warplanes to take part in the Battle of Britain. “Although not a major contributor to the 1940 air campaign against Britain, Italy did volunteer as many as 170 planes to the effort. In fact, more than five per cent of the 2,500 Axis aircraft committed to the battle were Italian.” Oct. 29, 1940, 4:40 p.m. – the Battle of Britain was nearing the end of its 112th day when 16 enemy bombers ap- peared in the skies over the English town of Ramsgate, Kent. Air raid sirens wailed as the twin-engine aircraft skimmed the rooftops of the small seaside city. After passing though a cordon of anti-aircraft fire, the bombers released their payloads onto the local port facility. At almost the same time, a lone plane from the group struck a Royal Marines barracks a few miles down the coast at Deal. Overall, the raid was largely ineffective — six Allied soldiers died in the attack. For their part, British anti-aircraft batteries damaged five of the enemy bombers. Despite the deaths on the ground, the late-afternoon strike was considered a minor raid, particularly when compared to larger, more deadly attacks carried out that same day against London, Coventry and Portsmouth. Yet, the Rams- gate bombing is still noteworthy, mostly because the aircraft involved weren’t German at all — they were from the Regia Aeronautica or the Italian Royal Air Force. -

Cliffs of Dover Br20
FIAT BR.20M CICOGNA GUIDE BY 1CHUCK (Unit) SPITFIRE HURRICANE BLENHEIM TIGER MOTH BF.109 BF.110 JU-87B-2 JU-88 HE-111 G.50 BR.20M Mk Ia 100 oct Mk IA Rotol 100oct Mk IV DH.82 E-4 C-7 STUKA A-1 H-2 SERIE II TEMPERATURES Water Rad Min Deg C 60 60 - - 40 60 38 40 38 - - Max 115 115 100 90 95 90 95 Oil Rad (OUTBOUND) Min Deg C 40 40 40 - 40 40 30 40 35 50 50 Max 95 95 85 105 85 95 80 95 90 90 Cylinder Head Temp Min Deg C - - 100 - - - - - - 140 140 Max 235 240 240 ENGINE SETTINGS Takeoff RPM RPM 3000 3000 2600 FINE 2350 2400 2400 2300 2400 2400 2520 2200 Takeoff Manifold Pressure UK: PSI +6 +6 +9 BCO ON See 1.3 1.3 1.35 1.35 1.35 890 820 BCO ON GER: ATA ITA: mm HG RPM Gauge • BLABLALBLABClimb RPM RPM 2700 2700 2400 COARSE 2100 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2100 30 min MAX 30 min MAX 30 min MAX 30 min MAX 30 min MAX 30 min MAX 30 min MAX Climb Manifold Pressure UK: PSI +6 +6 +5 See 1.23 1.2 1.15 1.15 1.15 700 740 GER: ATA ITA: mm HG RPM Gauge Normal Operation/Cruise RPM 2700 2600 2400 COARSE 2000 2200 2200 2200 2100 2200 2100 2100 RPM Normal Operation/Cruise UK: PSI +3 +4 +3.5 See 1.15 1.15 1.1 1.1 1.10 590 670 GER: ATA Manifold Pressure ITA: mm HG RPM Gauge Combat RPM RPM 2800 2800 2400 COARSE 2100 2400 2400 2300 2300 2300 2400 2100 Combat Manifold Pressure UK: PSI +6 +6 +5 See 1.3 1.3 1.15 1.15 1.15 700 740 GER: ATA ITA: mm HG RPM Gauge 5 min MAX 5 min MAX Emergency Power/ Boost RPM 2850 2850 2600 COARSE 2350 2500 2400 2300 2400 2400 2520 2200 RPM @ km 5 min MAX 5 min MAX 5 min MAX 1 min MAX 5 min MAX 1 min MAX 1 min MAX 1 min MAX 3 min MAX -
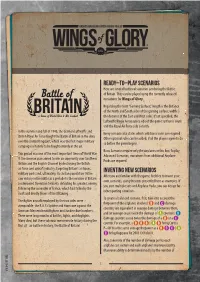
Ready–To–Play Scenarios Inventing New Scenarios
READY–TO–PLAY SCENARIOS Here are several historical scenarios set during the Battle of Britain. They can be played using the currently released miniatures for Wings of Glory. Regarding the term “Gaming Surface,” length is the distance of the North and South sides of the gaming surface; width is the distance of the East and West sides. If not speci ed, the Luftwa e/Regia Aeronautica side of the game surface is south and the Royal Air Force side is north. In the summer and fall of 1940, the German Luftwa e and Every scenario also states which additional rules are required. British Royal Air Force fought the Battle of Britain in the skies Other optional rules can be added, if all the players agree to do over the United Kingdom, which was the rst major military so before the game begins. campaign in history to be fought entirely in the air. Basic Scenarios require only the airplanes in this box. To play This period was one of the most important times of World War Advanced Scenarios, miniatures from additional Airplane II: the German plan aimed to win air superiority over Southern Packs are required. Britain and the English Channel by destroying the British air force and aircraft industry, targeting Britain’s air bases, INVENTING NEW SCENARIOS military posts and, ultimately, its civilian population. Hitler After you are familiar with the game, feel free to invent your saw victory in the battle as a prelude to the invasion of Britain own scenarios, using the ones presented here as examples. If (codenamed Operation Sealion), defeating his greatest enemy, you own multiple sets and Airplane Packs, you can design far following the surrender of France, which had fallen by the richer gaming situations. -

The Falkland Islands
Bravery Sacrifice Freedom th ANNIVERSARY The Falkland Islands In 1940 the Falkland Islands seized their chance to contribute in a material 70 years later the Government and people of the Falkland Islands continue way to the war effort, by donating over £70,000 to the British Government. to cherish our close ties with the United Kingdom, and to support the work of The money was used for the purchase of ten Spitfire aircraft, which bore the the British Armed Forces. We will always be grateful for the sacrifices made name ‘Falkland Islands’ on each side of the fuselage beneath the cockpit. in 1982, and cherish ‘the sound of freedom’ as Royal Air Force jets traverse our skies. The Falkland Islands contribute to A message of thanks and a formal citation their defence by building quarters for married was received by the Falkland Islands personnel and constructing a large swimming Government from Lord Beaverbrook, Minister pool for the garrison. of Aircraft Production: ‘In the hour of peril the Legislative Council for the Falkland Islands Today the Falklands economy is prospering: earned the gratitude of the British Nations, it is based on fishing, tourism and agriculture, sustaining the valour of the Royal Air Force but diversification is strongly encouraged, for and fortifying the cause of freedom by the gift example into aquaculture and web-based of ten fighter aircraft.’ business. Potential off-shore oil reserves may provide an additional source of income and Islanders also played their part by welcoming employment in the future. and working with the naval squadrons and army garrisons based in the Falkland Islands during both world wars, and by enlisting (then and since) Falkland Islanders are united in our desire to continue to exercise our right to fight alongside their British peers.