Intersezioni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Mio Pinocchio Segreto
PREMI Matteo Garrone ha vinto il Grand Prix della Giuria GreatBeauty al Festival di Cannes nel 2008 e nel 2012 rispettivamente per i film Gomorra e Reality. Con lui, sul set di Pinocchio, Roberto Benigni, premio Oscar come Migliore Attore Protagonista per La Vita è Bella. Matteo Garrone won the Grand Prix of the Jury at the Cannes Festival for Gomorra (2008) and for Reality (2012). Garrone alongside Roberto Benigni on the set of Pinocchio. Benigni won the Academy Award for Best Actor for Life is Beautiful. TESTO Matteo Garrone Filippo Nassetti Il coraggio di certo non manca a Matteo Garrone. Sotto Na- IL MIO tale è uscito il suo attesissimo Pinocchio, scelta temeraria quella di portare sul grande schermo la storia del burattino più famoso della letteratura mondiale. Qualcuno magari, conoscendo il cinema forse si aspettava un Pinocchio dark. PINOCCHIO In questi quattro anni il regista ha invece realizzato un film divertente, leggero, adatto per tutti, grandi e piccoli, senza distinzioni di classi sociali, con un cast ricco di talento co- SEGRETO mico, da Roberto Benigni a Gigi Proietti, da Massimo Cec- cherini a Rocco Papaleo. Nel ruolo di protagonista un sor- prendente Federico Ielapi perfetto Pinocchio grazie anche al magistrale lavoro di make up del premio Oscar, Mark Coulier. Incontriamo Garrone a Roma negli studios della sua Archimede Film, dove è appeso un quadro realizzato da bambino che spiega come questo film parta da molto lontano. «Lo disegnai a 6 anni, un racconto per immagini di Pinocchio, un vero e proprio storyboard». Ne ha altre nel cassetto di sue sceneggiature di bambino? «Sì, ma questa è quella a cui sono più affezionato». -

International Sales Autumn 2017 Tv Shows
INTERNATIONAL SALES AUTUMN 2017 TV SHOWS DOCS FEATURE FILMS THINK GLOBAL, LIVE ITALIAN KIDS&TEEN David Bogi Head of International Distribution Alessandra Sottile Margherita Zocaro Cristina Cavaliere Lucetta Lanfranchi Federica Pazzano FORMATS Marketing and Business Development [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Mob. +39 3351332189 Mob. +39 3357557907 Mob. +39 3334481036 Mob. +39 3386910519 Mob. +39 3356049456 INDEX INDEX ... And It’s Snowing Outside! 108 As My Father 178 Of Marina Abramovic 157 100 Metres From Paradise 114 As White As Milk, As Red As Blood 94 Border 86 Adriano Olivetti And The Letter 22 46 Assault (The) 66 Borsellino, The 57 Days 68 A Case of Conscience 25 At War for Love 75 Boss In The Kitchen (A) 112 A Good Season 23 Away From Me 111 Boundary (The) 50 Alex&Co 195 Back Home 12 Boyfriend For My Wife (A) 107 Alive Or Preferably Dead 129 Balancing Act (The) 95 Bright Flight 101 All The Girls Want Him 86 Balia 126 Broken Years: The Chief Inspector (The) 47 All The Music Of The Heart 31 Bandit’s Master (The) 53 Broken Years: The Engineer (The) 48 Allonsanfan 134 Bar Sport 118 Broken Years: The Magistrate (The) 48 American Girl 42 Bastards Of Pizzofalcone (The) 15 Bruno And Gina 168 Andrea Camilleri: The Wild Maestro 157 Bawdy Houses 175 Bulletproof Heart (A) 1, 2 18 Angel of Sarajevo (The) 44 Beachcombers 30 Bullying Lesson 176 Anija 173 Beauty And The Beast (The) 54 Call For A Clue 187 Anna 82 Big Racket (The) -

Download Download
FOREWORD PATRIZIA BETTELLA PINOCCHIO AND CHILDREN LITERATURE With the world-wide celebrations for the one hundred and twentieth anniversary of Carlo Collodi's Le avventure di Pinocchio just behind us and with the new or revived attention in recent years to minority literature and cultural studies, it is very appropriate to devote a special issue of Quaderni d'italianistica to Pinocchio. ' The articles presented here testify not only to the ever-growing interest in and to the generativity of Collodi's master- piece, but also to the scholarly commitment of bringing Pinocchio and chil- dren's literature from the traditional sphere of literary analysis into the domain of cultural studies. Expressions of 'low culture' such as television, film, Reality TV shows and Hollywood cinema are traditionally viewed with suspicion by intellectuals and excluded from academic scholarship, while children's literature is often confined to the specialized area of minor- ity literature. In recent years however, even among Italian scholars, more emphasis has been placed on the significance of a broad-ranging concept of culture, on the need to transcend rigid distinction between 'high' and 'low culture' and give serious consideration to various aspects of cultural practice such as children's literature, film, television and Reality TV. By viewing such instances of popular culture as an expression of social, polit- ical and power relations, the articles in this issue contribute to the cultur- In 2003 the anniversary of Le avventure di Pinocchio was honoured in North America with scholarly sessions at conferences in both Canada and the United States. In fact, some of the articles in this issue (Bettella's, Anselmi's, and Hogan's) were first presented during a special session on Pinocchio and children's literature at the congress of the Canadian Society for Italian Studies held, that year, in Halifax. -

Pinocchio Secondo Noi
Pinocchio burattino ... Pinocchio bambino Pinocchio secondo noi Alunni classe 5^ scuola primaria Clelia Pizzigoni INDICE Presentazione del lavoro L'autore e il suo paese Il libro riassunto da noi I personaggi come li abbiamo visti noi Alcune riflessioni Divertiamoci un po'... Biografia CARLO LORENZINI / COLLODI Carlo Lorenzini nacque a Firenze il 24 novembre 1826. E’ più noto con lo pseudonimo di “Collodi” dal nome del paese natale della madre. Carlo era un giornalista e anche uno scrittore, figlio di Domenico Lorenzini, cuoco dei conti Ginori, e di Angiolina (Maria Angela) Orzali, figlia maggiore del fattore dei Conti Garzoni, maestra elementare. Egli frequentò grazie all’aiuto della famiglia Ginori, scuole religiose: a Colle Val d’Elsa dove fu in Seminario dai 12 ai 16 anni, e poi a Firenze presso gli Scolopi. La sua carriera come scrittore iniziò a circa 20 anni d’età, quando redigeva i cataloghi commentati di una prestigiosa libreria fiorentina, per poi iniziare a pubblicare su "L'Italia Musicale”. Carlo Lorenzini fondò e diresse numerosi giornali, tra cui “Il Lampione”, che fu chiuso dalla censura dopo i moti del 1848, e riaprì nel 1859. Collodi era un vero intellettuale risorgimentale, si impegnò direttamente per l’unità d’Italia anche come militare volontario. Nel 1859 partecipò alla Seconda Guerra d’Indipendenza. “Le avventure di Pinocchio”, è un’opera della sua maturità (1881- 1883), quando era ormai famoso come giornalista e scrittore. Il suo primo libro per bambini fu pubblicato nel 1876: “I racconti delle fate”, traduzioni di alcune fiabe letterarie francesi. Nel 1881 pubblicò la prima puntata della “Storia di un burattino” sul “Giornale per i bambini”, e sullo stesso giornalino pubblicò altre storie brevi. -

RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Numero 11 - Anno 84 16 Marzo 2015 Reg
RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA numero 11 - anno 84 16 marzo 2015 www.ufficiostampa.rai.it Reg. Trib. n. 673 del 16 dicembre 1997 Abbiamo trovato il nuovo sindaco di Roma: SOMMARIO James Bond, agente 007. Ha fatto più miracoli lui in pochi giorni che trent'anni di amministrazioni 6 Speciale Ilaria Alpi biancorossenereverdigialle. 12 Pietro Mennea. La freccia del sud In due settimane di riprese, la città è visibilmente migliorata nelle zone dove sono 18 La Dama Velata state girate le scene del film. Non ci sono più buche nelle strade e gli argini 20 Velvet 2 di quello che una volta era il biondo Tevere sono tornati agli antichi splendori. Per non RADIOCORRIERE TV 22 Expo2015 SETTIMANALE DELLA RAI parlare dell'arredo urbano "tirato a lucido". RADIOTELEVISIONE ITALIANA Reg. Trib. n. 673 Purtroppo ci voleva un film per cambiare il del 16 dicembre 1997 22 Numero 11 - Anno 84 volto della capitale. Peccato che non tutte le 24 Fai 16 marzo 2015 Direttore responsabile circoscrizioni della Città eterna abbiano FABRIZIO CASINELLI 26 Tgr: l'Italia della legalità Redazione - Rai, potuto beneficiare di tali "grazie". Viale Mazzini, 14 00195 Roma Diciamo la verità, disagi per i cittadini non Tel 0636864313 - fax 063242420 28 Cristoforo Gorno sono mancati e a risentirne è stato soprattutto www.ufficiostampa.rai.it www.radiocorrieretv.it il traffico. Ma se questo è il prezzo da pagare Wonderland radiocorrieretv.blog.rai.it 30 [email protected] per vedere Roma più pulita, allora ben vengano A cura dell'Ufficio Stampa Rai Anna Fraschetti (c.r.) le grandi produzioni cinematografiche, anche Dante Fabiani (vc.r.) 32 Giorgio Lauro Carlo Casoli (c.s.) più volte l'anno. -

Le Avventure Di Pinocchio
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (Carlo Lorenzini) Letteratura italiana Einaudi Edizione di riferimento: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, illustrata da Enrico Mazzanti, Rizzoli, Milano 1949 Letteratura italiana Einaudi Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un bambino. C’era una volta... – Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr’Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e pao- nazza, come una ciliegia matura. Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: – Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per comin- ciare a levargli la scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile, che disse raccomandandosi: – Non mi picchiar tanto forte! Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia! Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno; guardò nel corbello dei trucioli e della segatura, e nes- Letteratura italiana Einaudi 1 Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio suno; apri l’uscio di bottega per dare un’occhiata anche sulla strada, e nessuno! O dunque?.. -

Narratives of Contamination and Mutation in Literatures of the Anthropocene Dissertation Presented in Partial
Radiant Beings: Narratives of Contamination and Mutation in Literatures of the Anthropocene Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Kristin Michelle Ferebee Graduate Program in English The Ohio State University 2019 Dissertation Committee Dr. Thomas S. Davis, Advisor Dr. Jared Gardner Dr. Brian McHale Dr. Rebekah Sheldon 1 Copyrighted by Kristin Michelle Ferebee 2019 2 Abstract The Anthropocene era— a term put forward to differentiate the timespan in which human activity has left a geological mark on the Earth, and which is most often now applied to what J.R. McNeill labels the post-1945 “Great Acceleration”— has seen a proliferation of narratives that center around questions of radioactive, toxic, and other bodily contamination and this contamination’s potential effects. Across literature, memoir, comics, television, and film, these narratives play out the cultural anxieties of a world that is itself increasingly figured as contaminated. In this dissertation, I read examples of these narratives as suggesting that behind these anxieties lies a more central anxiety concerning the sustainability of Western liberal humanism and its foundational human figure. Without celebrating contamination, I argue that the very concept of what it means to be “contaminated” must be rethought, as representations of the contaminated body shape and shaped by a nervous policing of what counts as “human.” To this end, I offer a strategy of posthuman/ist reading that draws on new materialist approaches from the Environmental Humanities, and mobilize this strategy to highlight the ways in which narratives of contamination from Marvel Comics to memoir are already rejecting the problematic ideology of the human and envisioning what might come next. -
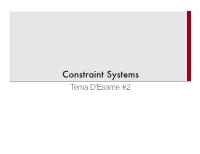
Laboratorio Di Informatica T
Tema D'Esame #2 C'era una volta in un paese lontano lontano la “Mastro Geppetto” Srl, una piccola impresa familiare condotta dall'esperto carpentiere Geppetto e dal suo figlio Pinocchio. Dopo un avvio piuttosto turbolento gli affari della società andavano a gonfie vele, anche perché il piccolo Pinocchio, essendo un burattino, non solo era instancabile, ma poteva industriarsi in barba alla legislazione sul lavoro minorile. Un giorno Pinocchio comunica al papà di avere ricevuto un’ottima proposta per diventare un bambino vero: il buon Geppetto, lieto per la notizia, decide di cogliere l'occasione per andare in pensione, logicamente dopo aver messo da parte un gruzzoletto per potersi mantenere. Al momento della comunicazione della novità da parte di Pinocchio, i due hanno in magazzino 40 quintali di legna. Pinocchio diventerà un bambino in carne ed ossa di lì a 60 giorni: per quella data Geppetto dovrà aver guadagnato almeno 20 zecchini. La lista delle commesse in sospeso della società conta le seguenti voci: Commessa Legna Dur. $ Ufficio giudice Acchiappa-Citrulli 30 qt 20 10 Carrozza turbo 4 cavalli per carabinieri 7 qt 25 4 Bacchetta magica Fata Turchina 1 qt 10 5 Nuovo teatro Mangiafuoco 20 qt 30 8 Ristrutturazione “Osteria Gambero Rosso” 10 qt 30 6 Nuova sede “Gatto&Volpe” (Soc. a Delinquere) 20 qt 40 2 Barchetta anti-pescecane 12 qt 25 5 Occorre decidere quali commesse accettare ed indicare in che giorni iniziare a lavorarvi. Si noti che la “Mastro Geppetto” riesce a portare avanti al massimo due commesse contemporaneamente. Si modelli il problema come un CSP e si mostri una possibile soluzione. -

Geppetto, Who Complains That Pinocchio, the Puppet She Brought to Life As His Son, Is Defective
Presents APRIL, 2014 Study Guide SETTING THE STAGE: SYNOPSIS A group of Fairies in Training gather to celebrate yet another “perfectly granted” wish of the Blue Fairy (When You Wish Upon a Star). Their celebration is interrupted by the toy maker Geppetto, who complains that Pinocchio, the puppet she brought to life as his son, is defective. To uncover the truth, the Blue Fairy takes us back in time to the day of Geppetto’s wish. Geppetto’s toy shop is filled with parents and their eager children (Toys). Having no children of his own, Geppetto envies them and wishes for his heart to be full (Empty Heart). The Blue Fairy grants his wish and brings Pinocchio to life. The next day, the overjoyed Geppetto teaches Pinocchio a song he learned from his father (Geppetto and Son) and introduces him to the Town Fathers, but Pinocchio wanders away. We then travel forward in time (Rise and Shine) to see Geppetto attempt to teach Pinocchio about toy making. When the disinterested Pinocchio lies, his nose grows. Still not convinced of Pinocchio’s imperfection, the Blue Fairy takes us forward again to Pinocchio’s first day of school. Heeding Geppetto’s instructions to “act like everyone else,” Pinocchio begins mimicking other students and gets into trouble. In the town square, the puppeteer Stromboli notices that Pinocchio is a string less puppet and tries to recruit him for his marionette show, but the Blue Fairy sends Stromboli away. Now back in the present, Geppetto repeats his request for the Blue Fairy to take Pinocchio back. -

Download Download
PATRIZIA BETTELLA COLLODI'S PUPPET IN FILM: DISNEY, COMENCINI, BENIGNI Geppetto's initial wish in Collodi's Le avventure di Pinocchio was to build a wonderful puppet who could perform acrobatics and help him earn a liv- ing touring the world. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno; ma un burat- tino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mor- tali. Con questo burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un tozzo 1 di pane e un bicchier di vino . Since Geppetto created Pinocchio with performance and entertain- ment in mind, it is not surprising to note how much interest the boy-pup- pet has attracted in cinema, theatre, and television. Cinema and television have given Pinocchio undivided attention for almost a century. Data shows that the story of the puppet generated approximately twenty feature film adaptations, 2 to which one should add the European co-production direct- ed by Steve Barron ( 1 996) and, of course, Roberto Benigni's Pinocchio, released in October 2002. Pinocchio the character attracts the media and continues to inspire cinema. It is worth noting, for example, Federico Fellini's predilection for Pinocchio—although he may have viewed the story of the puppet as a nightmare—and the presence of motifs from Collodi's story in many of his films. 3 Pinocchio has had a large impact in Collodi, Le avventure di Pinocchio, p. 8. Data from Laura, "Pinocchio nel cinema mondiale." ^One could mention the presence of a Collodian big fish/whale in Casanova, the attraction for the circus and automata in numerous of Fellini's films, or the direct association of actor Roberto Benigni to Pinocchio in his last film La voce della luna. -

Comunita' Educativa Per Minori Adolescenti
Struttura, governo e amministrazione della Presentazionecooperativa del servizio COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI ADOLESCENTI “La Casa di Pinocchio” INDICE AIBC Società Cooperati va Sociale - Casa PInocchio LA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “LA CASA DI PINOCCHIO” pag. 4 SEDE E FUNZIONAMENTO 3 ANALISI DEL PROBLEMA PIANO D’ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORI pag 8 Obietti vi Strumenti Finalità del progett o pag. 9 PARTE 2 - LA GESTIONE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA pag. 10 NORME PER L’AMMISSIONE L’INSERIMENTO DIMISSIONI CONVENZIONAMENTO CON L’ENTE INVIANTE E METODOLOGIA DELLA pag. 11 PRESA IN CARICO DEL MINORE CRITERI E MODALITA’ DI STESURA DEL PROGETTO EDUCATIVO pag. 13 INDIVIDUALE PARTE 3 - LA RETE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA pag. 15 RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI LA RETE DI FAMIGLIE E VOLONTARI DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MODALITA’ DI ACCESSO DEI FAMILIARI ALLA COMUNITA’ EDUCATIVA E CRITERI PER LE VISITE MODALITA’ DI ACCESSO DEI VOLONTARI E ESTERNI ALLA COMUNITA’ pag. 16 EDUCATIVA PARTE 4 - LA GESTIONE ECONOMICA E LA VALUTAZIONE DELLO pag. 17 STANDARD DI QUALITA’ VALUTAZIONE DELLO STANDARD DI QUALITA’ E RILEVAZIONE DEL pag. 18 GRADO DI SODDISFAZIONE AIBC Società Cooperati va Sociale - Casa PInocchio PARTE 1- LA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “LA CASA DI PINOCCHIO” SEDE E FUNZIONAMENTO La struttura, situata in un piccolo paese in zona Crema (CR), è situata all’interno del complesso parrocchiale, in zona centrale adiacente al Comune, alla parrocchia e ai principali servizi locali. La Comunità educativa, fatta eccezione per l’atrio, si sviluppa al primo piano della struttura ed è composta dai seguenti spazi: cucina e soggiorno ad uso comune, 4 camere da letto, una stanza studio, 4 un ufficio, due bagni per i minori e un bagno per gli operatori. -

LINO GUANCIALE Formazione
LINO GUANCIALE Formazione “Prima del teatro” a San Miniato, seminario sul metodo biomeccanico tenuto dal maestro Nikolaj Karpov Diplomato c/o l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma Iscrizione alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma Diploma Liceo Scientifico Lingue Inglese Teatro 2020: “La mia infinita fine del mondo” drammaturgia di Gabriel Calderòn, regia di Lino Guanciale 2020: “Non svegliate lo spettatore” – omaggio a Ennio Flaiano. Regia e musiche di Davide Cavuti – Tsa, Teatro Stabile d’Abruzzo 2018/2019/2020: “After Miss Julie” di Patrick Marber – Regia di Giampiero Solari – Prod. Teatro Franco Parenti 2018: "Come se fosse lei" - Regia di Pino Quartullo 2018/2019: “La classe operaia va in Paradiso” – Regia di Claudio Longhi - Tournèe 2017/2019: “Ragazzi di vita” di Pierpaolo Pasolini – Regia di Massimo Popolizio 2017: “Istruzioni per non morire in pace” – Regia di Claudio Longhi – Teatro della Pergola 2017: “Un bel dì saremo” – progetto di Claudio Longhi – Progetto ERT fondazione 2016: “Ragazzi di vita” di Pierpaolo Pasolini – Regia di Massimo Popolizion – Teatro Argentina - Roma 2015/2016: “Carissimi padri” progetto di Claudio Longhi 2012/2013: “La resistibile ascesa di Arturo Ui” di Bertolt Brecht, regia di Claudio Longhi 2012/2013: “Il ratto d’Europa – Per un’archeologia dei saperi comunitari”, ideato e diretto da Claudio Longhi 2012: “Il dolce mondo vuoto” di Francesca Staasch, regia di Francesca Staasch 2012: “Una sola è la bandiera” – Lettura 2010: “La notte dei musei” – Gli Orazi e Curiazi” di L. Micheletti 2010: “Io parlo ai perduti” di R. Barbolini, regia di Claudio Longhi 2010: “La solitudine dei campi di cotone” di B.M.