COMUNE DI CAVALLASCA Componente Geologica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Programma D'azione Cdf Seveso Aggiornamento 2020 - Settembre 2020 Premessa
Programma d'Azione CdF Seveso aggiornamento 2020 - settembre 2020 Premessa Il presente documento costituisce aggiornamento del Programma d'Azione Seveso 2019 approvato a novembre 2019 integrato, con riferimento alla sezione delle AZIONI METODOLOGICHE E DI GOVERNANCE, dei dati relativi alla scheda C. Aggiornamento del censimento degli scarichi lungo l’asta del Torrente Seveso e, con riferimento all'AMBITO 6 Nord Milano e Milano, dall'inserimento della nuova scheda 6.6. Master Plan paesaggistico ambientale della Valle del Seveso - Progetto Pilota Paderno Dugnano Seveso River Park. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Programma d’Azione 2019 costituisce aggiornamento del Programma d'azione 2014 del Contratto di Fiume Seveso e ne è documento integrante; è costruito a partire dalle misure del progetto Strategico di Sottobacino Seveso – approvato nel dicembre 2017 – e dal lavoro di selezione, affinamento e implementazione delle misure condotto nel corso del 2018 – 2019 con i 6 tavoli territoriali e con i principali referenti. Così come le misure locali del progetto di sottobacino anche le nuove azioni del CdF sono da un lato connesse ai macroobiettivi del Progetto di Sottobacino: ▪ miglioramento della qualità delle acque e dell’ambiente fluviale ▪ riduzione del rischio idraulico ▪ miglioramento degli aspetti ecologico ambientali e dei servizi ecosistemici ▪ governance ▪ e dall'altro seguono gli indirizzi che hanno guidato la progettualità nel territorio -
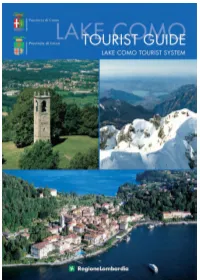
Tourist Guide.Pdf
COMACINA ISLAND PRESENTATION LAKE COMO TOURIST SYSTEM This tourist guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will find, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known places. Subdivided into geographical areas of lake, mountain and plain, the Guide describes the entire territory of Como and Lecco provinces; its history, architecture, art and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. The section that describes the plains moves down towards the gentle Brianza hills, travelling through villas and castles and working valleys crossed by the River Adda, as well as parks full of treasures and wonderful views. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No
TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. -

First Report of the Invasive Mosquito Species Aedes Koreicus in The
Suter et al. Parasites & Vectors (2015) 8:402 DOI 10.1186/s13071-015-1010-3 SHORT REPORT Open Access First report of the invasive mosquito species Aedes koreicus in the Swiss-Italian border region Tobias Suter1,2*, Eleonora Flacio3, Begoña Feijoó Fariña3, Lukas Engeler3, Mauro Tonolla3,4 and Pie Müller1,2 Abstract Background: In 2012 and 2013, an entomological survey of Aedes albopictus, the Asian tiger mosquito, was carried out in the border region of southern Switzerland and northern Italy, using ovitraps. In July 2013, besides A. albopictus already known to the region several unusual eggs were recovered. Findings: A total of 548 seemingly different eggs were found within three communities: Chiasso (Switzerland), and Como and Brunate (Italy). Proteomic diagnostics based on matrix-assisted laser desorption/ionization mass-spectrometry (MALDI-TOF MS) and morphological identification of one reared adult revealed the presence of at least 18 A. (Finlaya) koreicus (Edwards, 1917) specimens. A. koreicus is a species native to Southeast Asia and is competent to transmit Japanese encephalitis and potentially other arboviruses, as well as the dog heartworm Dirofilaria immitis.Whilenewto Switzerland, this invasive species has previously been reported from Belgium, north-eastern Italy and European Russia. Conclusions: This is the first report of the introduction of this exotic mosquito species into Switzerland and Lombardy, Italy, suggesting the range of A. koreicus is expanding in Central Europe. As A. koreicus is competent to vector pathogens its establishment imposes a risk to public and veterinary health. From a technical point of view, the presence of A. koreicus alongside A. albopictus requires careful analysis and reliable diagnostics. -

Global Map of Irrigation Areas ITALY
Global Map of Irrigation Areas ITALY Province Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water ABRUZZO 59 358 8 077 51 281 BASILICATA 80 640 17 529 63 111 CALABRIA 117 247 64 148 53 099 CAMPANIA 125 305 72 499 52 806 EMILIA-ROMAGNA 565 573 159 981 405 592 FRIULI-VENEZIA GIULIA 91 876 30 886 60 991 LAZIO 150 088 92 602 57 486 LIGURIA 11 391 2 707 8 684 LOMBARDIA 704 517 105 037 599 480 MARCHE 49 559 23 967 25 591 MOLISE 20 881 687 20 194 PIEMONTE 449 047 101 878 347 169 PUGLIA 389 617 308 116 81 501 SARDEGNA 165 707 49 937 115 770 SICILIA 209 035 101 725 107 310 TOSCANA 111 603 41 133 70 469 TRENTINO-ALTO ADIGE 61 774 15 610 46 164 UMBRIA 66 927 17 825 49 103 VALLE D'AOSTA 26 212 506 25 707 VENETO 435 845 70 931 364 914 Italy total 3 892 202 1 285 783 2 606 419 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/ita/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas ITALY Area equipped for irrigation Area actually irrigated District Province (ha) (ha) CHIETI ABRUZZO 11 167 5 142 L'AQUILA ABRUZZO 21 693 12 330 PESCARA ABRUZZO 12 232 5 225 TERAMO ABRUZZO 14 267 7 299 MATERA BASILICATA 52 579 32 990 POTENZA BASILICATA 28 061 9 335 CATANZARO CALABRIA 18 435 10 849 COSENZA CALABRIA 49 814 27 306 CROTONE CALABRIA 22 206 10 370 REGGIO CALABRIA CALABRIA 21 300 15 083 VIBO VALENTIA CALABRIA 5 492 3 374 AVELLINO CAMPANIA 6 671 3 480 BENEVENTO CAMPANIA 10 625 6 115 CASERTA CAMPANIA 48 714 33 352 NAPOLI CAMPANIA 16 078 13 821 SALERNO CAMPANIA 43 217 29 647 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA 76 680 23 610 FERRARA EMILIA-ROMAGNA -

1.4. Elementi D'interesse Nel Piano Territoriale Di Coordinamento Del
27 1.4. Elementi d’interesse nel Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Spina Verde. Il Parco regionale Spina Verde è stato istituito con la Lr. 4 marzo 1993, n. 10 e classificato come “Parco di cintura metropolitana” e successivamente come “Parco forestale” 1. Ptc – Individuazione del Parco Il Parco si caratterizza per l’ambiente naturale, per il patrimonio archeologico dal XI al I secolo a.c., per la presenza di importanti strutture religiose (chiese e conventi) e difensive d’origine medioevale, di significativi 1 La superficie del Parco è di 1.179 ettari e comprende parti dei territori comunali di Como, San Fermo della Battaglia, Cavallasca, Parè e Drezzo e confina con la Confederazione Elvetica, favorendo la promozione e l’incentivazione di forme di collaborazione con quest’ultima per la gestione coordinata del territorio e la promozione turistica culturale. 28 insediamenti ottocenteschi (ville) e di più recenti strutture ricettive; è inoltre rilevante la forte panoramicità verso la città, il lago, la pianura, la corona alpina. Le aree del parco sono circondate da un edificato continuo comprendente gli spazi antropizzati della città di Como e dei comuni contermini; inoltre, considerata la sua estensione (il perimetro è pari a 40 km) il parco riveste un ruolo importante nell’organizzazione territoriale di tali comuni e costituisce così una “occasione unica per riqualificare le frange più marginali delle periferie antiche e recenti della città e dei comuni ri- compresi ”2. Il territorio del Parco presenta un’altimetria -
Proposte Di Educazione Ambientale Nel Parco
Parco Regionale Spina Verde Proposte di Educazione Ambientale nel Parco in collaborazione con Società Archeologica Comense Gruppo Archeologico Comasco U. Buzzi WWF Biosfera Società Ortofloricola Comense U.C.C. di Albate Agorà . Incontri culturali Albatesi Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Coordinamento: Renato Manzoni, Consigliere Parco Regionale Spina Verde Vittorio Terza, Collaboratore Parco Spina Verde Gruppo di Lavoro: Beatrice Molteni, WWF Biosfera Chiara Niccoli, Società Archeologica Comense Stefano Alivernini, Gruppo Archeologico Comasco Ulisse Buzzi Roberto Colombo, Gruppo Archeologico Comasco Ulisse Buzzi Carlo Pedraglio, Gruppo Archeologico Comasco Ulisse Buzzi Orsola De Stefano, Ufficio Parco Spina Verde Vittorio Terza, Collaboratore Parco Spina Verde Grafica e impaginazione: Vittorio Terza Stampa: Impronta Grafica - Cantù 1 Come si viveva nella Spina Verde nella Preistoria Esperti del Gruppo Archeologico Comasco e della Società Archeologica Comense, attraverso l’utilizzo di diapositive, proporranno alla classe un inquadramento storico della civiltà di Golasecca, sviluppatasi a Como e dintorni nell’età del Ferro (I millennio a.C.) e i suoi rapporti con le altre culture dell’Europa Preistorica. A chi è destinato scuole primarie; scuole secondarie di primo e secondo grado Durata circa 2 ore Costo 75,00 € 2 Come lavora l’archeologo Esperti del Gruppo Archeologico Comasco e della Società Archeologica Comense proporranno una lezione in classe nella quale, tramite l’utilizzo di diapositive, verranno spiegate le basi della ricerca -

The Cycle Lanes of the Lakes of LECCO, COMO and VARESE the Cycle Lanes of the Lakes of CYCLE GUIDE LECCO, COMO and VARESE
The Cycle lanes of the lakes of LECCO, COMO and VARESE The Cycle lanes of the lakes of CYCLE GUIDE LECCO, COMO and VARESE www.cicloviadeilaghi.it INDEX 5 Introduction The Province of Lecco 6 The cycle lane round the lakes 96 Itinerary 7: Art and Literature 8 The area of the lakes among the lakes of Brianza 10 Itineraries for the cycle tourists 110 Itinerary 8: The lakeside Riviera 12 Type of Itineraries from Lecco to Colico 128 Itinerary 9: The circular track of the lakes of Garlate and Olginate The Province of Varese 14 Itinerary 1: From Lake Ceresio to 138 Useful advice for the cycle tourist Lake Maggiore, crossing Valcuvia 141 Tourist information 28 Itinerary 2: By bicycle along the banks of the Lake Varese 46 Itinerary 3: Nature and culture while crossing Valle dell’Olona The Province of Como 56 Itinerary 4: From the pine tree park to the city of Como 72 Itinerary 5: The morainal lakes of Como 86 Itinerary 6: The Ghisallo The Cycle lanes of the lakes of CYCLE GUIDE LECCO, COMO and VARESE INTRODUCTION The project “Interreg III A”, to create a ridge that is possible to cycle along, linking the provinces of Lecco, Como, Varese and Canton Ticino, was started in 2002. It refl ects the desire by the Province of Lecco, Como and Varese to sustain and provide incentives, for the development of cycle tourism, which is already widely practiced and sustained at a national level, by the Governments of many European countries. Currently even Italy seems to be setting off in this direction. -
Como COMO Assessorato Alla Mobilità
Comune di Como COMO Assessorato alla Mobilità Mappa della rete delCimitero di Maslianicotrasporto pubblico di area urbana Public transportation map Liniennetzplan + + + + C10 C20 Elenco delle linee List of the lines Linienübersicht MASLIANICO Maslianico C28 Dogana MASLIANICO C29 S. Fermo d. Battaglia Sagnino 7 Lora Battisti Chiasso 1 Roma Segantini Don Bosco Vacallo Dogana S. Fermo d. Battaglia 6 Nuovo Ospedale S. Anna Como 8 Casnate MASLIANICO Cernobbio + Stazione S. Giovanni S. Quirico Moja MASLIANICO Verdi Cimitero di MASLIANICO Cernobbio Grandate 3 Lora Sagnino 11 Bassone Municipio Stazione Cimitero Segantini Carcere Como Dogana Stazione S. Giovanni Tavernola 12 Camerlata Brogeda MASLIANICO MASLIANICO Roma Camnago Volta 4 Friuli Piazza Caronti Campora Como Cimitero Monumentale Como C50 Trecallo Cantù Fumagalli Quasimodo MASLIANICO Cosio CERNOBBIO Mazzini Portici Plinio Parini Villa Erba Como 5 Civiglio Brunate T3 Brunate Papini CERNOBBIO Stazione S. Giovanni V Alpini CERNOBBIO Funicolare C.A.O. Quarcino Montello CERNOBBIO CERNOBBIO Ponte Nuovo Bernasconi Breccia Sauro Venturino Fulda CERNOBBIO CERNOBBIO Visconti Maslianico 6 Funicolare Brogeda 44 Filzi Municipio S. Fermo d. Battaglia CERNOBBIO Como F1 Brunate Deledda 41 Manzoni Centro Congressi Nuovo Ospedale S. Anna Fattori ASF CERNOBBIO Campanini Legenda Key Zeichenerklärung C30 Chiasso Sagnino Pellico Deledda 21 Segantini 12 C31 Tibaldi 69 Linea automobilistica urbana Capolinea C32 Urban bus line End of the line Friuli Stadtbuslinie Endhaltestelle 7 11 Tibaldi 51 Linea automobilistica extraurbana Linea ferroviaria regionale e internazionale / Funicolare Sagnino Suburban bus line Regional and international railway / Funicular railway Zanella Pola Mognano Salesiani Überlandbus Regional- und Fernbahn / Standseilbahn Tibaldi 6 Spalato Collegamento a bassa frequenza Linea suburbana S11 Chiasso Milano P.ta Garibaldi 1 Brogeda 15 Nievo Low frequency bus service CHIASSO Campari Suburban rail line S11 Stazione CHIASSO Dogana Nur einzelne Busse S-Bahn-Linie S11 Fermata in entrambi i sensi di marcia Dogana P. -

I PESCI NEL SEVESO: Un Segno Di Ripresa Della Qualità?
Seveso, 21 aprile 2016 I PESCI NEL SEVESO: un segno di ripresa della qualità? Panoramica sullo stato ambientale del torrente Seveso e sulle relative pressioni Vertemate con Minoprio San Fermo della Battaglia Lentate sul Seveso Seveso 1 Anna Maria Brambilla, Alessandro Dal Mas, Filippo Galimberti Il fiume Seveso Nasce sulle colline comasche tra i comuni di Cavallasca e San Fermo della Battaglia (490 m s.l.m.) Lungo 52 chilometri il cui corso si sviluppa interamente nelle provincie di Como, Monza e Brianza e Milano 2 Il fiume Seveso Scorre coperto dal confine comunale fra Bresso e Milano. Nel tratto interrato confluisce con il Naviglio Martesana all’altezza di viale Melchiorre Gioia (tratto interrato lungo circa 9 Km) naviglio Martesana a Trezzo d’Adda 3 naviglio Martesana a Milano Il fiume Seveso Scorre coperto sotto Milano e ne esce come Cavo Redefossi (San Donato Milanese) 4 Il fiume Seveso Il Cavo Redefossi si immette nel fiume Lambro (Melegnano) 5 Il fiume Seveso Canale Scolmatore Nord Ovest (Palazzolo Milanese) 6 Analisi delle pressioni Il torrente Seveso e il suo bacino idrografico a nord di Milano - principali pressioni 7 Analisi delle pressioni Impianto di depurazione di Fino Mornasco (via Laghetto): serve un agglomerato da 75300 abitanti equivalenti Anni '90: gravi carenze strutturali; l'impianto non riusciva a trattare l'intera portata in arrivo, all'epoca prevalentemente industriale (aziende tessili) Anni 1996 - 1997: importante adeguamento strutturale 2006 – 2008: ulteriore adeguamento strutturale (pretrattamenti ed incremento -

Multivariate Machine Learning Analysis Techniques for Flood Risk Prevention
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey USE OF MULTIVARIATE MACHINE LEARNING ANALYSIS TECHNIQUES FOR FLOOD RISK PREVENTION 1 D. Vito , 1 Politecmico di Milano, Department of Electronic Information and Bioengineering, Milan – [email protected] Commission VI, WG VI/4 KEY WORDS: flood, risk, data, Machine Learning, Prediction ABSTRACT: Natural disasters such as flood are regarded to be caused by extreme weather conditions as well as changes in global and regional climate The prediction of flood incoming is a key factor to ensure civil protection in case of emergency and to provide effective early warning system. The risk of flood is affected by several factors such as land use, meteorological events, hydrology and the topology of the land. Predict such a risk implies the use of data coming from different sources such satellite images, water basin levels, meteorological and GIS data, that nowadays are easily produced by the availability new satellite portals as SENTINEL and distributed sensor networks on the field. In order to have a comprehensive and accurate prediction of flood risk is essential to perform a selective and multivariate analyses among the different types of inputs. Multivariate Analysis refers to all statistical techniques that simultaneously analyse multiple variables. Among multivariate analyses, Machine learning to provide increasing levels of accuracy precision and efficiency by discovering patterns in large and heterogeneous input datasets. Basically, machine learning algorithms automatically acquire experience information from data. This is done by the process of learning, by which the algorithm can generalize beyond the examples given by training data in input. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome RICCIARDI PIO Indirizzo 80, VIA SAN FERMO, 22020, CAVALLASCA Telefono 0315440029 Fax 031212309 E-mail [email protected] [email protected] [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 29/05/1955 ESPERIENZA LAVORATIVA Dal 1993 al 1997 \ Istruttore amministrativo presso il Comune di Bulgarograsso (CO) . Dal 1998 al 1999 Istruttore Direttivo e responsabile dei servizi amministrativi presso il Comune di Bulgarograsso (CO). Dal 2000 al 2001 Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di San Fermo della Battaglia (CO) . Dal 2001 al 2003 Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Area Amministrativa / Demografica / Vigilanza presso Comune di San Fermo della Battaglia (CO) Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Dal 2004 al 2008 Area Amministrativa / Vigilanza / Servizi sociali presso Comune di San Fermo della Battaglia Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Area Dal 2009 Affari generali / Vigilanza presso Comune di San Fermo della Battaglia Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Da aprile 2010 Area Socio Assistenziale presso Comune di San Fermo della Battaglia Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Da gennaio 2014 Funzione Associata Servizi Sociali dei Comuni di Cavallasca, Montano Lucino e San Fermo della Battaglia. ] ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1974 Diploma maturità scientifica Liceo scientifico Leonardo da Vinci – Salerno CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. MADRELINGUA ITALIANA ALTRE LINGUA • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es.