L'esperienza Formativa Di Anton Domenico Gabbiani a Venezia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stampe Che Imitano I Disegni. Incisori, Artisti, Collezionisti Ed Editori
Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Storia delle Arti Ciclo 29° Anno di discussione 2017 Stampe che imitano i disegni. Incisori, artisti, collezionisti ed editori. Settore scientifico disciplinare di afferenza: L-ART/02 Tesi di Dottorato di Benedetta Spadaccini, matricola 956129 Coordinatore del Dottorato Supervisore del Dottorando Prof. Martina Frank Prof. Bernard Aikema !2 Sommario Introduzione……………………………………………………………………….p. 7 Capitolo I. A Venezia: «con gran prontezza, e con molto spirito, a colpi maestri».………………………………………………p. 33 Capitolo II. A Parma e Bologna: il colore………………..…………………………p. 75 Capitolo III. A Milano: Leonardo…………………………………………………p. 113 Conclusione………………………………………………………………………..p. 147 Apparati……………………………………………………………………………p. 159 -Collezioni visitate………………………………………………………………….p. 160 -A.Z. Anton Maria Zanetti, Raccolta di varie stampe a chiaroscuro, tratte dai disegni originali di Francesco Mazzuola detto il Parmigianino, e di altri insigni autori da Anton Maria Zanetti q.am Gir. che gli stessi disegni possiede, Venezia, 1749…….p. 161 -And.Z. Andrea Zucchi in Raccolta di varie stampe a chiaroscuro, tratte dai disegni originali di Francesco Mazzuola detto il Parmigianino, e di altri insigni autori da Anton Maria Zanetti q.am Gir. che gli stessi disegni possiede, Venezia, 1749…….p. 179 -A.F. Antonio Faldoni in Raccolta di varie stampe a chiaroscuro, tratte dai disegni originali di Francesco Mazzuola detto il Parmigianino, e di altri insigni autori da Anton Maria Zanetti q.am Gir. che gli stessi disegni possiede, Venezia, 1749…….p. 181 -C.O. Carlo Orsolini in Raccolta di varie stampe a chiaroscuro, tratte dai disegni originali di Francesco Mazzuola detto il Parmigianino, e di altri insigni autori da Anton Maria Zanetti q.am Gir. -

Katalog No 26
26 NO. 26 www.leclaire-kunst.de MASTER DRAWINGS LE CLAIRE KUNST 2010 MASTER DRAWINGS NO. 26 MASTER DRAWINGS ELBCHAUSSEE 386 · 22609 HAMBURG · GERMANY · PHONE: +49 (0)40 881 0646 · FAX: +49 (0)40 880 4612 [email protected] · WWW.LECLAIRE-KUNST.DE Karoline von Kügelgen Thomas and Gianna le Claire Gerhard Kehlenbeck Since 2005 we have regularly published catalogues devoted to single artists such as Rudolf von Alt, Christoffer Wilhelm Eckersberg, Gustav Klimt, Johan Christian Dahl and Max Liebermann. It now gives us particular pleasure to be able to present a selection of works on paper from our stock. This Catalogue 26 has a special focus on French, German, Italian and Netherlandish artists. When we look at the price explosion in the market for modern and contemporary art, we have the impression that we are the tortoise to modern art’s hare. But we’re quite comfortable with this. We feel more far more secure with the solid values and historically robust performance of Old Masters. As collectors in this field, we buy only what we like. We are less concerned about the financial impact on our collections of, say, fluctuations in the oil and commodity markets, or in the Dow Jones Index and the FTSE 100. This is the strength of the Old Master market, coupled with dwindling supply and increasing demand – and the sheer beauty, immediacy and appeal of the works we collect. We are pleased to say that Karoline von Kügelgen has joined the company. She is a distinguished expert in 19th and 20th-century works on paper. -

Allestimenti Di Ritratti E Narrative Storico Genealogiche Nei Palazzi Fiorentini, Ca
COLLANA ALTI STUDI SULL’ETÀ E LA CULTURA DEL BAROCCO PASQUALE FOCARILE Allestimenti di ritratti e narrative storico genealogiche nei palazzi fiorentini, ca. 1650-1750 COLLANA ALTI STUDI SULL’ETÀ E LA CULTURA DEL BAROCCO V - IL RITRATTO Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 75 – 10128 Torino Sede operativa: Piazza Bernini, 5 – 10138 Torino Tel. 011 4401401 – Fax 011 4401450 – [email protected] Codice fiscale: 97520600012 Consiglio di Amministrazione 2018-2020: Piero Gastaldo (Presidente), Walter Barberis (Vicepresidente) Consiglieri: Allegra Alacevich, Laura Barile, Blythe Alice Raviola Direttore scientifico del Programma Barocco: Michela di Macco Direttore: Anna Cantaluppi Vicedirettore: Elisabetta Ballaira Consiglio di Amministrazione 2015-2017: Rosaria Cigliano (Presidente), Michela di Macco (Vicepresidente) Consiglieri: Allegra Alacevich, Walter Barberis, Stefano Pannier Suffait Direttore: Anna Cantaluppi Responsabile culturale: Elisabetta Ballaira Programma di Studi sull’Età e la Cultura del Barocco Borse di Alti Studi 2017 Tema del Bando 2017: Il Ritratto (1680-1750) Assegnatari: Chiara Carpentieri, Pasquale Focarile, Ludovic Jouvet, Fleur Marcais, Pietro Riga, Augusto Russo Tutor dei progetti di ricerca: Cristiano Giometti, Cinzia M. Sicca, Lucia Simonato, Alain Schnapp, Beatrice Alfonzetti, Francesco Caglioti Cura editoriale: Alice Agrillo È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata. L’Editore si scusa per -

Ann-Kathrin Deininger and Jasmin Leuchtenberg
STRATEGIC IMAGINATIONS Women and the Gender of Sovereignty in European Culture STRATEGIC IMAGINATIONS WOMEN AND THE GENDER OF SOVEREIGNTY IN EUROPEAN CULTURE EDITED BY ANKE GILLEIR AND AUDE DEFURNE Leuven University Press This book was published with the support of KU Leuven Fund for Fair Open Access Published in 2020 by Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium). Selection and editorial matter © Anke Gilleir and Aude Defurne, 2020 Individual chapters © The respective authors, 2020 This book is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivative 4.0 Licence. Attribution should include the following information: Anke Gilleir and Aude Defurne (eds.), Strategic Imaginations: Women and the Gender of Sovereignty in European Culture. Leuven, Leuven University Press. (CC BY-NC-ND 4.0) ISBN 978 94 6270 247 9 (Paperback) ISBN 978 94 6166 350 4 (ePDF) ISBN 978 94 6166 351 1 (ePUB) https://doi.org/10.11116/9789461663504 D/2020/1869/55 NUR: 694 Layout: Coco Bookmedia, Amersfoort Cover design: Daniel Benneworth-Gray Cover illustration: Marcel Dzama The queen [La reina], 2011 Polyester resin, fiberglass, plaster, steel, and motor 104 1/2 x 38 inches 265.4 x 96.5 cm © Marcel Dzama. Courtesy the artist and David Zwirner TABLE OF CONTENTS ON GENDER, SOVEREIGNTY AND IMAGINATION 7 An Introduction Anke Gilleir PART 1: REPRESENTATIONS OF FEMALE SOVEREIGNTY 27 CAMILLA AND CANDACIS 29 Literary Imaginations of Female Sovereignty in German Romances -

The Corsini Collection: a Window on Renaissance Florence Exhibition Labels
The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence Exhibition labels © Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, 2017 Reproduction in part or in whole of this document is prohibited without express written permission. The Corsini Family Members of the Corsini family settled in Florence in the middle of the 13th century, attaining leading roles in government, the law, trade and banking. During that time, the Republic of Florence became one of the mercantile and financial centres in the Western world. Along with other leading families, the Corsini name was interwoven with that of the powerful Medici until 1737, when the Medici line came to an end. The Corsini family can also claim illustrious members within the Catholic Church, including their family saint, Andrea Corsini, three cardinals and Pope Clement XII. Filippo Corsini was created Count Palatine in 1371 by the Emperor Charles IV, and in 1348 Tommaso Corsini encouraged the foundation of the Studio Fiorentino, the University of Florence. The family’s history is interwoven with that of the city and its citizens‚ politically, culturally and intellectually. Between 1650 and 1728, the family constructed what is the principal baroque edifice in the city, and their remarkable collection of Renaissance and Baroque art remains on display in Palazzo Corsini today. The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence paints a rare glimpse of family life and loyalties, their devotion to the city, and their place within Florence’s magnificent cultural heritage. Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki is delighted that the Corsini family have generously allowed some of their treasures to travel so far from home. -

Fabia Borroni Salvadori: L'esposizione DI OPERE D'arte DEL 1674 ALLA SS. ANNUN ZIATA DI FIRENZE Alla Morte Di Ferdinande»
Fabia Borroni Salvadori: L’ESPOSIZIONE DI OPERE D’ARTE DEL 1674 ALLA SS. ANNUN ZIATA DI FIRENZE Alla morte di Ferdinande» II de’ Medici al granducato di Toscana assurge Cosimo III: collezionista rafhnato cerca anche egli nuovi talenti fra gli artisti. Nel 1673 invia a Roma con una dotazione spe- ciale alcuni giovani promettenti perche si formino alla scuola di disegno di Ciro Ferri e a quella di scul- tura tenuta da Ercole Ferrata. Contemporaneamente a Firenze, nel chiostro dei Pittori della SS. An nunziata, il 18 ottobre, festa di S. Luca, l’Accademia del Disegno allestisce una mostra nella quäle furono messi Quaranta quadri di pittori grandi e de ’ piü rinomati maestri antichi e moderniI E dunque una espo- sizione riservata ad artisti affermati, dai valori ormai consolidati anche sotto il profilo commerciale e di mercato. La notizia di una mostra nel 1673 e la testimonianza che l’allestimento di esposizioni era giä ben ra- dicato nella Firenze del secondo Seicento agganciandosi e continuando la consuetudinaria esposizione dei quadri di miracoli. 2 E poiche nel 1974 avevo scritto che La prima esposizione dell’Accademia del Di segno finora documentata e quella del ibyq e su di essa mi ero brevemente soffermata 3 ritorno ora sull’ar- gomento sia per anticipare di un anno la consuetudine documentata delle mostre sia per fornire ulte- riori contributi sull’esposizione del 1674. Mi avvalgo di un elenco informe, di mano coeva, particolarmente interessante per la storia del gusto di quegli anni, contenuto nel Ms . II . I . 432 della Biblioteca Nazionale di Firenze, manoscritto miscel- laneo con notizie sull’Accademia del Disegno messo insieme nell’Ottocento da G. -
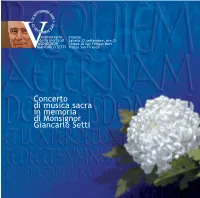
Programma Di Sala2
Anniversario Firenze della morte di Sabato 22 settembre, ore 21 MONSIGNOR Chiesa di San Filippo Neri GIANCARLO SETTI Piazza San Firenze Concerto di musica sacra in memoria di Monsignor Giancarlo Setti PROGRAMMA «Ho scritto il mio Requiem senza motivo… per il piacere di farlo, se così posso dire. César Franck È stato eseguito alla Madeleine PANIS ANGELICUS dalla Messe Solennelle Op.12 per le esequie di un Antonio Vivaldi parrocchiano qualunque». DOMINE DEUS dal Gloria RV 589 Wolfgang Amadeus Mozart «Si è detto che quest’opera non LAUDATE DOMINUM esprime il terrore della morte; da Vesperae solennes de Confessore KV 339 qualcuno l’ha chiamata una berceuse funebre. Gabriel Fauré Eppure è così che io sento la REQUIEM in re min. Op. 48 morte: come una lieta per soli, coro e orchestra da camera (versione 1893) liberazione, un’aspirazione alla felicità dell’aldilà e non un GAMS Ensemble doloroso trapasso». Gruppo Polifonico Quodlibet Vocalia Consort «Può darsi che io abbia tentato Soprano Elena Mariani di uscire dalle convenzioni, Baritono Filippo Becattini dopo tutti gli anni in cui ho Organista Francesco Giannoni accompagnato all’organo le funzioni funebri. Ho voluto fare Direttore Massimo Annibali un’altra cosa». Maestro del coro Gianni Franceschi Gabriel Fauré REQUIEM REQUIEM Pie Jesu Pie Jesu Pie Jesu, Domine, dona eis requiem; Pietoso Signore Gesù, dona loro il riposo; Introït Introito Dona eis requiem, sempiternam requiem. dona loro il riposo, il riposo eterno. Requiem aeternam, dona eis Domine: L’eterno riposo dona loro, Signore, et lux perpetua luceat eis. e splenda ad essi la luce perpetua. Agnus Dei Agnus Dei Te decet hymnus Deus, in Sion, Si innalzi un inno a te, o Dio, in Sion, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnello di dio, che togli i peccati del mondo, et tibi reddetur votum in Ierusalem. -

Palazzo Querini Stampalia Portego
Palazzo Querini Stampalia Museum Portego entrance Giovanni Mythology Bellini room room The earliest documents concerning the construction of the palace are from 1513-14 and point to Nicolò Querini as commissioner of the works. Grandson Francesco continued the works of enlargement and restoration in various stages throughout the first half of the century. From this period archival documents note nothing of importance until the acquisitions of the following century: in 1614 the building which is now the east wing of the palace and in 1653 part of the house between the canal and the church in Campo Santa Maria Formosa. The last radical transformation of Ca’ Querini was between 1789 and 1797 for the occasion of the marriage in 1790 between Alvise, son of Zuanne, and Maria Teresa Lippomano. In addition to the elevation of the third floor, completed after 1795, there was a large scale restructuring of the interiors with the reduction of the length of the portego and the evolution of the decorative scheme on which worked Jacopo Guarana, Davide Rossi, ornamentalist Giuseppe Bernardino Bison, gilder Domenico Sartori and brothers and stucco workers Giuseppe and Pietro Castelli. The museum is presented in such a way as to recall a patrician residence of the eighteenth century with the display of all of the collections of the family: furnishings, porcelain, sculpture, fabrics, chandeliers, globes, as well as paintings, in order to bring to life the spaces once truly inhabited by the Querini. A rich theatre where every detail plays an important role, from the fabrics in some rooms woven according to original patterns, to the curtains and the pelmets which adorn the windows to the original chandeliers. -

A Palace and the City
A PALACE AND THE CITY 150 years since Florence was named An exhibition created and curated by the Capital of Italy Stefania Ricci and Riccardo Spinelli Palazzo Spini Feroni opens its doors Design to the city in a fascinating exhibition Maurizio Balò on its centuries of history in collaboration with Davide Amadei Museo Salvatore Ferragamo Exhibition organised by Florence, Palazzo Spini Feroni Museo Salvatore Ferragamo 8 May 2015- 3 April 2016 in collaboration with inauguration 7 May Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze Fondazione Ferragamo With the sponsorship of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Regione Toscana Comune di Firenze 1 A PALACE AND THE CITY “Long before I ever moved into the Palazzo Spini Feroni it was one of the buildings of Florence that I most admired and loved.” Salvatore Ferragamo From 8 May 2015 to 3 April 2016, at Palazzo Spini Feroni, via Tornabuoni, Florence, Museo Salvatore Ferragamo will hold an exhibition on the building’s centuries of history, commemorating the 150 years since Florence was named capital of the Kingdom of Italy (1865-1870), and Palazzo Spini Feroni became the city hall in 1865. Curated by Stefania Ricci and Riccardo Spinelli, the exhibition will include prestigious works of art and documents from museums and private collections and will tell the intricate stories behind the palace and its residents, in captivating displays created by stage designer Maurizio Balò, thus sharing one of the most important buildings in the city’s urban landscape with Florence, Florentines and travellers. -

Bilancio Sociale Degli Enti Non Profit Esperienze Toscane
QUADERNI DI STUDI E RICERCHE 12 QUADERNI DI STUDI E RICERCHE 1. Luciano Zannotti, /LEHUWjGLLQVHJQDPHQWRHLQVHJQDPHQWRGHOODOLEHUWj, 2001 2. Vincenzo Cavaliere, Dario Rosini, 'DDPPLQLVWUDWRUHDPDQDJHULOGLULJHQWHSXEEOLFRQHOOD JHVWLRQHGHOSHUVRQDOHHVSHULHQ]HDFRQIURQWR, 2002 3. Maria Antonietta Rovida, /DFDVDFRPH³EHQHGLFRQVXPR´QHOOHRSHUD]LRQLLPPRELOLDULGL )UDQFHVFR6DVVHWWL, 2003 4. Maria Antonietta Rovida, 3DOD]]LVHQHVLWUD H 0RGHOOLDELWDWLYLHDUFKLWHWWXUDWUD WUDGL]LRQHHLQQRYD]LRQH, 2003 5. /LQHDJXLGDSHUODSURJHWWD]LRQHGLXQVLVWHPDGLJHVWLRQHSHUODTXDOLWjGLXQFRUVRGLVWXGL XQLYHUVLWDULR a cura di Bruno Zanoni, Erminio Monteleone, Claudio Peri, 2004 6. Fabrizio F.V. Arrigoni, 1RWHVXSURJHWWRHPHWURSROL, 2004 7. /DSURJHWWD]LRQHGHOODFLWWjSRUWXDOH6SHULPHQWD]LRQLGLGDWWLFKHSHUXQDQXRYD/LYRUQR,a cura di Manlio Marchetta, 2004 8. Leonardo Trisciuzzi, Barbara Sandrucci, Tamara Zappaterra, ,OUHFXSHURGHOVpDWWUDYHUVR O¶DXWRELRJUDILD, 2005 9. Elena Rotelli, ,OFDSLWRORGHOODFDWWHGUDOHGL)LUHQ]HGDOOHRULJLQLDO;9VHFROR, 2005 10. Stefano Cordero di Montezemolo, ,SURILOLILQDQ]LDULGHOOHVRFLHWjYLQLFROH, 2005 11. Riccardo Passeri, Leonardo Quagliotti, Christian Simoni, 3URFHGXUHFRQFRUVXDOLHJRYHUQR GHOO¶LPSUHVDDUWLJLDQDLQ7RVFDQD, 2005 Luca Bagnoli Maurizio Catalano ,OELODQFLRVRFLDOHGHJOLHQWLQRQSURILW HVSHULHQ]HWRVFDQH Firenze University Press 2005 Il bilancio sociale degli enti non profit : esperienze toscane / Luca Bagnoli, 0DXUL]LR&DWDODQR±)LUHQ]H)LUHQ]HXQLYHUVLW\SUHVV 4XDGHUQLGLVWXGLHULFHUFKH8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL)LUHQ]H http://digital.casalinLLW 6WDPSDDULFKLHVWDGLVSRQLEile -

Museo D'arte Sacra Dell'abbazia Di Vallombrosa
collana diretta da Antonio Paolucci 14 Museo d’arte sacra dell’Abbazia di Vallombrosa Guida alla visita del museo e alla scoperta del territorio a cura di Caterina Caneva Edizioni Polistampa Musei del Territorio: l’Anello d’oro Museums of the Territory: The Golden Ring Museo d’arte sacra dell’Abbazia di Vallombrosa Enti promotori / Promoted by Ente Cassa di Risparmio di Firenze Regione Toscana In collaborazione con / In collaboration with Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato Diocesi di Fiesole Comune di Reggello Progetto e coordinamento generale / Project and general coordination Marcella Antonini, Verdiana Fontana, Barbara Tosti Comitato scientifico / Scientific committee Presidente: Antonio Paolucci Cristina Acidini Luchinat, Caterina Caneva, Rosanna Caterina Proto Pisani, Carla Guiducci Bonanni, Giangiacomo Martines, Paola Refice, Claudio Rosati, Bruno Santi, Timothy Verdon Cura scientifica / Scientific supervision Caterina Caneva Itinerario nel museo a cura di / Museum tour by Caterina Caneva Testi di / Texts by Caterina Caneva, Alessandro Cecchi, Lorenzo Pesci, Pierdamiano Spotorno OSB Schede delle opere / Description of the works Caterina Caneva (n. 37) Alessandro Cecchi (nn. 1-2; 6-7; 10; 14-15; 19-36; 38-106) Lorenzo Pesci (nn. 3-5; 8-9; 11-13; 16-18) Itinerari a cura di / Itineraries by Nicoletta Baldini, Maria Pilar Lebole, Benedetta Zini Glossario e indici a cura di / Glossary and indexes by Francesca Sborgi Coordinamento redazionale / Editorial coordination Cristina Corazzi Traduzioni per l’inglese / English translation English Workshop Immagine coordinata della copertina / Cover page by Rovaiweber design Progetto grafico / Graphic project Polistampa Referenze fotografiche / Photography George Tatge Paolo Giusti (pp. -

WRITING ABOUT EARLY RENAISSANCE WORKS of ART in VENICE and FLORENCE (1550-1800) Laura-Maria
BETWEEN TASTE AND HISTORIOGRAPHY: WRITING ABOUT EARLY RENAISSANCE WORKS OF ART IN VENICE AND FLORENCE (1550-1800) Laura-Maria Popoviciu A dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Combined Historical Studies The Warburg Institute University of London 2014 1 I declare that the work presented in this thesis is my own _______________________________ Laura-Maria Popoviciu 2 ABSTRACT My dissertation is an investigation of how early Renaissance paintings from Venice and Florence were discussed and appraised by authors and collectors writing in these cities between 1550 and 1800. The variety of source material I have consulted has enabled me to assess and to compare the different paths pursued by Venetian and Florentine writers, the type of question they addressed in their analyses of early works of art and, most importantly, their approaches to the re-evaluation of the art of the past. Among the types of writing on art I explore are guidebooks, biographies of artists, didactic poems, artistic dialogues, dictionaries and letters, paying particular attention in these different genres to passages about artists from Guariento to Giorgione in Venice and from Cimabue to Raphael in Florence. By focusing, within this framework, on primary sources and documents, as well as on the influence of art historical literature on the activity of collecting illustrated by the cases of the Venetian Giovanni Maria Sasso and the Florentine Francesco Maria Niccolò Gabburri, I show that two principal approaches to writing about the past emerged during this period: the first, adopted by many Venetian authors, involved the aesthetic evaluation of early Renaissance works of art, often in comparison to later developments; the second, more frequent among Florentine writers, tended to document these works and place them in their historical context, without necessarily making artistic judgements about them.