Il Museo E Il Parco Archeologico Della Villa Di Traiano Ad Arcinazzo Romano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arcinazzo Romano Guida Ai Musei
Arcinazzo Romano - Guida ai Musei ANTIQUARIUM COMUNALE “VILLA DI TRAIANO” ARCINAZZO ROMANO GUIDA AI MUSEI Tiziano Cinti Mauro Lo Castro 1 Arcinazzo Romano - Guida ai Musei ENTE PROMOTORE: Testi e foto: Tiziano Cinti, Mauro Lo Castro (“Il Betilo” S.C. a r.l.) Traduzioni: Catia Ronzoni Progetto grafico e impaginazione: Comune di Arcinazzo Romano Latini Photo-Video Compositing www.emanuelelatini.it Stampa: Deltamedia Artigrafiche, Roma PARTNER ISTITUZIONALI www.deltamediagroup.it E COFINANZIATORI: L’Amministrazione Comunale e gli autori ringraziano per la collaborazione prestata nei primi otto anni di lavoro nel Museo e nella realizzazione della Guida: - Regione Lazio: il Dirigente Area Regione Lazio Servizi Culturali, Dr. Claudio (L.R. 42/’97, Piano 2009) Cristallini, i funzionari referenti Dr.ssa Laura De Martino, Francesca Mattei, Paola Pascucci; - Provincia di Roma: il Dirigente Beni, Servizi, Attività Culturali Dr. Valerio De Nardo; i funzionari referenti Dr.ssa Bruna Amendolea, Dr.ssa Laura Indrio, Provincia di Roma Dr.ssa Angelica Apicella; (L.R. 42/’97, Piano 2009) - tutto il personale del Comune di Arcinazzo Romano; - Simona Troja e Irene De Horatiis per il costante apporto dato allo sviluppo delle attività del Museo; - i volontari, gli addetti di Servizio Civile Nazionale e i cittadini che ci hanno sostenuto. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio © Comune di Arcinazzo Romano - 2011 2 Arcinazzo Romano - Guida ai Musei 7 Arcinazzo Romano - Guida ai Musei Prefazione Abbiamo voluto scrivere questa guida immaginando di accompagnare voi visitatori negli spazi della Villa di Traiano mediante una piacevole passeggiata, sorta di “dialogo muto” tra voi che ci gratificate del vostro interesse e noi, impegnati ogni giorno nella valorizzazione di questo patrimonio storico e culturale. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -
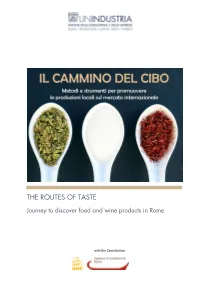
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

Allegato 1 Regione Lazio
ALLEGATO 1 REGIONE LAZIO Numero Numero Codice Enti progetti Italia Sito Internet Progetti Volontari NZ00018 COMUNE DI RIETI 3 14 www.comune.rieti.it PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI NZ00089 2 11 www.simbruini.it SIMBRUINI NZ00110 COMUNE DI ACUTO 3 12 www.comune.acuto.fr.it NZ00145 CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 23 198 www.volontariato.lazio.it NZ00156 ASL ROMA 2 4 57 www.aslroma2.it NZ00535 ASSOCIAZIONE KIM O.N.L.U.S. 1 4 www.associazionekim.it NZ00586 COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA 2 45 www.comune.cantalupoinsabina.ri.it NZ00628 COMUNE DI SORA 2 8 www.comune.sora.fr.it NZ00663 COMUNE DI CECCANO 1 10 www.comune.ceccano.fr.it NZ00823 CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE 1 28 www.consorzioservizisociali.fr.it ASSOCIAZIONE C.I.I.V.A. - CIECHI, INVALIDI CIVILI, NZ00868 1 4 www.ciiva.it IPOVEDENTI E VEDENTI ASSIEME NZ00934 COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 1 4 http://www.comunearcinazzoromano.it ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI - NZ00958 1 3 www.archiviodisarmo.it ARCHIVIO DISARMO NZ01156 COMUNE DI GAETA 1 4 www.comune.gaeta.lt.it NZ01184 ISTITUTO LEONARDA VACCARI 2 20 www.leonardavaccari.it NZ01315 CONSORZIO PARSIFAL 23 112 www.consorzioparsifal.it NZ01520 COMUNITA' MONTANA ZONA XIX DEL LAZIO 1 10 www.xixcomunitamontana.it NZ01708 UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI LAVORO 4 38 unionedicomuniatl.org/ NZ01772 Roma Capitale 34 242 www.comune.roma.it ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO NZ01937 SOCIALE - CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA 4 98 www.aipes.it PERSONA SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E NZ02016 32 161 www.volontariato.lazio.it SOLIDARIETA' NZ02209 ANTARES 2000 A.R.L. -

Parte Prima Inquadramento
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) ( Allegato 1° ) PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO PA GI NA 1 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) Parte Prima: Inquadramento Generale del Territorio 1.1 Dati di base Dati di base Comune MONTE PORZIO CATONE Codice ISTAT Comune 058064 Provincia ROMA Codice ISTAT Provincia 058 Elenco delle Frazioni del Comune (se elenco delle Frazioni appartenenti al Comune: presenti) ARMETTA, CAMALDOLI, FONTANA CANDIDA, MASSAROSA, MONTE CIUFFO, PILOZZO, PRATONE-BELVEDERE, SAN MARCO, SELVE DI MONDRAGONE, SUORE DOMENICANE DI BETANIA, VILLA VECCHIA Autorità di Bacino di appartenenza BACINO DEL TEVERE 2 Estensione Territoriale in Km Kmq 9,13 Comune di ROMA Comune di FRASCATI Comuni confinanti Comune di GROTTAFERRATA Comune di MONTECOMPATRI Comunità Montana di appartenenza elenco dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana: XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini CAVE, COLONNA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO,GROTTAFERRATA, MONTE PORZIO CATONE, MONTECOMPATRI, PALESTRINA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, SAN CESAREO, ZAGAROLO elenco dei Comuni appartenenti al COI: Appartenenza al COI secondo la ex FRASCATI, MONTE PORZIO CATONE, GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, MONTECOMPATRI DGR 29 febbraio 2000, n.569 (denominazione COI) elenco dei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni: Appartenenza a Unione di Comuni NON APPARTENENTE A NESSUNA UNIONE DI COMUNI (denominazione UdC, se presente) PAGI NA 2 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) Appartenenza ad altre aggregazioni elenco dei Comuni appartenenti all’aggregazione: comunali (denominazione AC, se --------------------------- presente) Zona di allerta meteo (in riferimento alla E – ANIENE classificazione del CFR, ex DGR Data di validazione del Livello 1 di Microzonazione Sismica (se validato) Determinazione n. -

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indirizzo COLLOCATI a RIPOSO (ART
N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indirizzo COLLOCATI A RIPOSO (ART. 7) Con decreti in data 23 gennaio 2008 Commendatore Ciocci Sig.ra Maria Rosaria Forano 24/05/1942 Pulcinelli Sig. Giulio Cristoforo Ronciglione 13/01/1941 Sabatino Dott. Francesco Borgia 15/09/1940 Ufficiale Piasenti Sig.ra Renata Fiume 03/04/1946 Cavaliere Marini Sig. Giovanni Roma 27/07/1940 Torelli Sig. Enzo Castiglione del Lago 06/03/1944 Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Di Martino Dott. Vincenzo La Spezia 16/02/1933 Fiduccia Dott. Gaetano Firenze 27/08/1932 Scandurra Dott. Giuseppe Messina 07/05/1932 Grande Ufficiale Bruni Avv. Italo Catanzaro 21/10/1940 Vitale Rag. Silvestro Silvio Carlentini 31/03/1941 STRANIERI (ART. 7) Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Matsubara S.E. Sig.ra Nobuko Tokio 09/01/1941 Taccetti S.E. Victorio Maria José Buenos Aires 22/01/1943 Commendatore Fox Dott. Richard J. New York 24/02/1947 Pagina 1di 29 Indirizzo Metzger Ing. Jean-Marie Clichy 11/07/1951 Thellier-Thompson Sig. Gilles Boulogne sur Mer 24/06/1957 Cavaliere Clerc Sig. Alain Tunisi 19/11/1942 NORMALI Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Armellini Sig. Manlio Porto San Giorgio 09/10/1937 Cabigiosu Gen. C. d' A. Carlo Brunico 22/06/1939 Courtial Dott. Hans Albert Dietkirchen 17/05/1946 Di Fonso Dott. Aldo Lorenzo Pettorano sul Gizio 10/08/1932 Manganelli Dott. -

Arcinazzo Romano Guida Ai Musei
Arcinazzo Romano - Guida ai Musei ANTIQUARIUM COMUNALE “VILLA DI TRAIANO” ARCINAZZO ROMANO GUIDA AI MUSEI Tiziano Cinti Mauro Lo Castro 1 Arcinazzo Romano - Guida ai Musei La Villa The Villa La residenza dell'imperatore The residence of the Emperor Traiano (98-117 d.C.) sorge in Trajan (98-117 AD) is located in a un'area naturale di grande fascino. natural area of great charm. We are in Ci troviamo in un territorio a mountainous area rich in waters montuoso, ricco di acque, and popular, in ancient times as well frequentato, in antico come ai giorni as today, as being a place for holiday, nostri, come luogo di residenza per away from the city and its rhythms. trascorrere vacanze lontano dalla Thinking of ancient Rome, we must città e dai suoi ritmi. Pensando not forget that it represented, for the all'antica Roma, non dobbiamo time, a real metropolis, a centre for dimenticare che essa rappresentava the political and economic power, per l'epoca una autentica metropoli, where you could see the negative centro di gravità del potere politico effects of overpopulation. ed economico, nonché luogo in cui cogliere gli effetti negativi del sovrapopolamento. Veduta della platea inferiore Per farsi una idea di quanto della Villa simili alle attuali possano essere View of the lower terrace state le problematiche relative alla of the Villa vita metropolitana, basti pensare 11 Arcinazzo Romano - Guida ai Musei che già dal I sec. a.C. i romani si dera l’imprevedibilità degli eventi, se erano dotati di una legge che vai fuori a cena senza aver fatto testa- regolasse la circolazione stradale mento: in ogni finestra aperta, dove di all’interno della città. -

Terza Categoria Gir. A
TERZA CATEGORIA GIR. A .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 20/10/19 ! ! RITORNO: 9/02/20 I I ANDATA: 24/11/19 ! ! RITORNO: 15/03/20 I I ANDATA: 5/01/20 ! ! RITORNO: 26/04/20 I I ORE...: 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30 I I ORE...: 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30 I I ORE...: 15:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30 I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I A FERRARIS VILLANOVA 1956 - CINETO ROMANO 1974 I I AFFILE - ATLETICO ROMA EST I I A FERRARIS VILLANOVA 1956 - POLISPORTIVA MANDELA I I AFFILE - GREGORIANA I I ANIENE CALCIO - PRO CALCIO CASTEL MADAMA I I ANIENE CALCIO - AFFILE I I ANTICOLI CORRADO 1966 - ARSOLI I I ARSOLI - ARCINAZZO ROMANO 2019 I I ARCINAZZO ROMANO 2019 - ANTICOLI CORRADO 1966 I I ATLETICO ROMA EST - PRO CALCIO CASTEL MADAMA I I BORGATA GORDIANI - A FERRARIS VILLANOVA 1956 I I ARSOLI - GREGORIANA I I POL.CASTEL MADAMA - BORGATA GORDIANI I I CINETO ROMANO 1974 - ANTICOLI CORRADO 1966 I I BORGATA GORDIANI - CINETO ROMANO 1974 I I POLISPORTIVA MANDELA - ANIENE CALCIO I I GREGORIANA - PRO MARCELLINA I I PRO CALCIO CASTEL MADAMA - POL.CASTEL MADAMA I I PRO MARCELLINA - ARCINAZZO ROMANO 2019 I I POL.CASTEL MADAMA - POLISPORTIVA MANDELA I I PRO MARCELLINA - ATLETICO ROMA EST I .--------------------------------------------------------------. -

L'acquedotto Consorziale Del Simbrivio
Luigi CESA L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DEL SIMBRIVIO Luigi CESA è nato ad Arcinazzo Ro- mano (RM) nel 1916 e deceduto a Roma nel 2004. Ha pubblicato: Le chiese di Arcinazzo Romano e di Affile, Ediz. Eurotip, Roma, 1984; Altipiani di Arcinazzo. La villa im- periale, Ediz. Eurotip, Roma, 1987. Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per l'in- formazione e l'editoria, 1988; Racconti e rimembranze di guerra, 1994; I casati di Arcinazzo Romano dal XVI al XX secolo, Ediz. Global Me- dia, 1998; Scuola e comunità civile ad Arci- nazzo Romano - L'opera della Chiesa e delle Sorelle della Misericordia di Vero- na (1940-2001), 2002. In copertina: Trasportatori dei tubi di m/m 500 per il sifone di Vallepietra. Luigi CESA L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DEL SIMBRIVIO INDICE PREFAZIONE INTRODUZIONE CAPITOLO I Vallepietra e le sue sorgenti CAPITOLO II Condizioni idriche dei comuni consorziati prima dell’acquedotto del Simbrivio CAPITOLO III Concessioni del Ministero dei LL. PP. e costituzione del Consorzio del Simbrivio CAPITOLO IV Statuto del Consorzio del Simbrivio costituito con decreto prefettizio n° 40783 dell’8 agosto 1923 CAPITOLO V Decreto del Ministero dei LL. PP. del 19 gennaio 1922 CAPITOLO VI L’utilizzazione delle sorgenti delle acque dell’Aniene e del suo affluente “Simbrivio” secondo un decreto di concessione del 1918 CAPITOLO VII L’acquedotto del “Simbrivio” e la relizzazione delle relative opere CAPITOLO VIII Gli artefici dell’acquedotto CAPITOLO IX Inaugurazione dell’acquedotto a Velletri CAPITOLO X Le autorità e gli enti realizzatori dell’opera CAPITOLO XI Richieste di acqua e nuove adesioni al Consorzio CAPITOLO XII Decreto di concessione del Ministero dei LL. -

Consulte Territoriali Ordine Consulenti Del Lavoro Di Roma Consulta Rappresentanti Municipi Roma Di Competenza Comuni Di Competenza
Consulte Territoriali Ordine Consulenti del Lavoro di Roma Consulta Rappresentanti Municipi Roma di competenza Comuni di competenza Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale I° Quadrante (ovest) Foschi Stefano (Presidente) I,XI,XII,XIII,XIV Monterano, Cerveteri, Fiumicino Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano Fiano Romano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Filacciano, onte Nuova, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana , Monteflavio, II° Quadrante (nord) Germani Mariarita (Presidente) II,III,IV,XV Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina Tivoli, Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colonna, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Gorga, Jenne, Labico, Licenza, Mandela, III°Quadrante (est) Magrini Enzo (Presidente) V,VI, VII Marano Equo, Marcellina, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Cesareo, San Vito Romano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Valmontone, Zagarolo Pomezia, Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Frascati, Genzano di Roma,Grottaferrata, Lanuvio, IV°Quadrante (sud) Adriani Ruggiero (Presidente) VIII,IX,X Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Velletri. -

Città Metropolitana Le
U.C Segretariato Generale Città metropolitana Serw'sgo i "Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alk Commissioni consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri de/spati le A.ttì deliberativi - Albo Pretorio - Cerimoniale"' A.O.O. Città metropolitana tìi Roma Capitel Ai Segretari Generali Ufficio n^rsr» Anno. fìsL^T.. Clnssificazione \. dei Comuni delia Città metropolitana di Roma Capitale N. CMl a mezzo PEC Oggetto: Rinnovo delie Commissioni e delle Sottocommissìoni Elettorali Circondariali della Città metropolitana dì Roma Capitale — Designazione dei componenti da parte del Consiglio metropolitano. RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO JREP. N. 30560 PUBBLICATO DAL 01/02/2017 AL 03/03/2017. Con la presente si informano le SS.LL. che il Consiglio metropolitano di Roma Capitale intende procedere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 223/1967 e ss. .mm. ed ii., alla formazione di. un elenco di cittadini in possesso dei requisiti per la designazione a componenti delle Commissioni e delle Sottocommissìoni di cui all'oggetto. Si fa presente al riguardo che la relativa documentazione è pubblicata nel portale dell'Amministrazione sul sito wvvw.cittameiropolitanaroma.aov.it. all'Albo Pretorio Web ed è altresì reperibile dal medesimo sito seguendo il percorso dalla home page: cittamelropoUtanaroma.gov.it >gìi Uffici informano>Avvisi. Entro il giorno 24 aprile 2017 -nel rispetto delle modalità di cui al citato Avviso pubblico - i cittadini in. possesso dei requisiti dì cui ai D.P.R. 223/1967 e ss. mm. ed ii. potranno presentare la propria candidatura ad assumere l'incarico di componente delle Commissioni e delle Sotto commissioni Elettorali Circondariali della Città metropolitana di Roma Capitale, utilizzando la modulistica all'uopo pubblicata sul portale di questa Amministrazione. -

Parte Prima Inquadramento Generale Del Territorio
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) ( Allegato 1° ) PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) Parte Prima: Inquadramento Generale del Territorio 1.1 Dati di base Dati di base Comune MONTE PORZIO CATONE Codice ISTAT Comune 058064 Provincia ROMA Codice ISTAT Provincia 058 Elenco delle Frazioni del Comune (se elenco delle Frazioni appartenenti al Comune: --- presenti) Autorità di Bacino di appartenenza BACINO DEL TEVERE 2 Estensione Territoriale in Km Kmq 9,13 Comune di ROMA Comuni confinanti Comune di FRASCATI Comune di GROTTAFERRATA Comune di MONTE COMPATRI Comunità Montana di appartenenza elenco dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana: XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini CAVE, COLONNA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO,GROTTAFERRATA, MONTE PORZIO CATONE, MONTE COMPATRI, PALESTRINA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, SAN CESAREO, ZAGAROLO elenco dei Comuni appartenenti al COI: Appartenenza al COI secondo la ex FRASCATI, MONTE PORZIO CATONE, GROTTAFERRATA, ROCCA DI DGR 29 febbraio 2000, n.569 PAPA, ROCCA PRIORA, MONTE COMPATRI (denominazione COI) elenco dei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni: Appartenenza a Unione di Comuni (denominazione UdC, se presente) NON APPARTENENTE A NESSUNA UNIONE DI COMUNI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) elenco dei Comuni appartenenti all’aggregazione: Appartenenza ad altre aggregazioni comunali (denominazione AC, se presente) Zona di allerta meteo (in riferimento alla E - ANIENE classificazione del CFR, ex DGR 272/2012) Data di validazione del Livello 1 di Determinazione n. A01713 del 07/03/2013 Microzonazione Sismica (se validato) Data di validazione della Condizione Limite dell’Emergenza (se validata) Zona sismica (DGR n.