Rapporto Conoscitivo Rottofreno Travo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Life in the Protected Areas
www.ermesambiente.it/parchi Life in the Protected Areas The hill The Po Delta The low mountains and hills are like a rich mosaic of environments and landscapes that contain a good share The Po Delta is the the most extensive system of wetlands in Italy, of regional biodiversity: hardwood forests, meadows, shrubs and cultivated fields; rocky cliffs, gullies and gypsum where you can still feel the atmosphere of the great lonely spaces and sa- outcrops. vour the slow pace of the relationship between man and nature that has 14 nature reserves nature 14 and and The High Apennines This is the part of the regional territory where the relationship between human activities and nature is most intense helped shape an area in constant evolution. 17 parks 17 Discover it in in it Discover and where there is an important and well-known historical patrimony, made of archaeological sites, castles, The regional park protects the southern sector of today’s deltaic area, while The Apennines represent the backbone of the region, topped by Mount churches, monasteries, medieval villages and stately homes. There are also remains that bear witness to minor the rest of it falls within the Venetian regional park of the same name. Cimone (2165 m) in Modena. These mountain environments consist of aspects of life in the past: small stone villages, chestnuts dryers, mills and majesty. Sand-banks, reed beds, coastal lagoons, pine forests, flooded forests, brack- As of today, the Protected Nature Areas established in Emilia- blueberry heaths, meadows and pastures, vast hardwood and coniferous There are several protected areas that have been established since the ‘80s in the hills in order to protect both the ish valleys and freshwater wetlands form a natural heritage of European Romagna consist of: 2 national parks, 1 interregional park, 14 trees forests, lakes and peat-bogs. -

GRANDI DIGHE EMILIA-ROMAGNA A) Elenco Dighe (Tabella N
ALLEGATO N. 2 – GRANDI DIGHE EMILIA-ROMAGNA a) Elenco Dighe (Tabella n. 2 schema DPC) b) Tabella elenco Comuni con codice ISTAT e diga cui afferiscono TABELLA N°2 DIGHE DI R ILIEVO NAZIONALE GRANDI DIGHE EMILIA-ROMAGNA Volume L. Quota max. Quota Volume Fiume - Bacino Altezza NOME DIGA COMUNE PROV. Uso Classifica 584/94 (mil. regolazione Autorizz. (m Lat. Long. Autorizz. Concessionario Ente gestore Comuni a valle della diga afferente L.584/94 (m) m3) (m s.m.) s. m.) (mil. M3) Sambuca Pistoiese (PT), Castel di Casio, Alto Reno Terme, Gaggio Limentra di Volte sostenute da ENEL GREEN ENEL GREEN PAVANA Castel di Casio BO Idroelettrico 52 0,9 470 466,7 44,11839 11,00353 montano, Grizzana Morandi, Vergato, Sambuca - Reno contrafforti POWER POWER Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologna Castelfranco Emilia, Modena, San Traversa in PANARO San Cesario sul Panaro MO Panaro - Po Laminazione piene 15,85 22,3 40,83 29,29 44,60936 11,00876 - AIPO Cesario sul Panaro, Nonantola, calcestruzzo Bomporto. Scoltenna - Calcestruzzo a ENEL GREEN ENEL GREEN Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, RIOLUNATO Riolunato MO Idroelettrico 24 0,108 656,99 656,24 44,23741 10,65217 0,072 Panaro Po gravità ordinaria POWER POWER Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese. Traversa in Campogalliano, Modena, Rubiera, SECCHIA Campogalliano RE Secchia - Po Laminazione piene 9,02 2,8 46,27 44 44,6579 10,8153 - AIPO calcestruzzo Soliera, Bastiglia. Ferriere, Ottone, Cerignale, Corte Gravità ordinaria in Brugnatella, Bobbio, Coli, Calendasco, ENEL GREEN ENEL GREEN BOSCHI Ferriere PC Aveto - Trebbia Po Idroelettrico muratura di 35,6 1,45 615,5 - 44,58626 9,41945 Gazzola, Gossolengo, Gragnano POWER POWER pietrame con malta Trebbiense, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno, Travo. -

Albo Giudici Popolari Corte D'assise 2015
GESTIONE ALBO GIUDICI POPOLARI Giudici Corte d'Assise Pag.1 __________________________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Cognome/Nome Residenza Professione Nascita: data/luogo Tit.studio __________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ALBASI FABIO ROTTOFRENO (PC) COLLABORATORE SCOLAS 17/10/1974, PIACENZA (PC) S.NICOLO'-VIA VESCOVI n.11 MATURITA' COMMERCIALE 2 ALBERONI NEREO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 27/01/1961, SAN GIORGIO PIACENTINO ( S.NICOLO'-VIA ALICATA n.52/A MATURITA' COMMERCIALE 3 ALBERTELLI FABRICE ROTTOFRENO (PC) AUTISTA 16/08/1968, PARIGI (FRANCIA) ROTTOFRENO-VIA IACOPONE DA TODI LICENZA MEDIA SUPERIORE 4 ASCIONE CIRO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 15/04/1962, TORRE DEL GRECO (NA) S.NICOLO'-VIA PASCOLI n.24 MATURITA'COMMERCIALE 5 AURIEMMA TOMMASO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 06/02/1964, VOLLA (NA) S.NICOLO'-VIA CAVOUR n.2 LICENZA MEDIA INFERIORE RMMTMS64B06M115X 6 BARBINI SILVIO ROTTOFRENO (PC) PENSIONATO 12/08/1952, ROMA (RM) S.NICOLO'-VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N.8 MATURITA'COMMERCIALE BRBSLV52M12H501P 8 BERTOZZI GIOVANNI ROTTOFRENO (PC) COMMERCIANTE 12/08/1962, MILANO (MI) S.NICOLO'-VIA Marchesi n.14/b LICENZA MEDIA INFERIORE BRTGNN62M12F205E 9 BETTINARDI ROBERTO ROTTOFRENO (PC) IDRAULICO 21/10/1961, CAGLIARI (CA) S.NICOLO'-VIA DON BOREA n.2/A MATURITA' INDUSTRIALE 10 CALLEGARI DANILO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 19/06/1960, PIACENZA (PC) S.NICOLO'-VIA PAPA GIOVANNI PAOL MATURITA' -

Festività Religiose
NEWSletter www.piacenzacase.it>> 1 Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – LUGLIO 2017 Cinema e Video Mercatini e Mostre Mercato Pontenure (PC) Cortemaggiore (PC) CONCORTO FILM FESTIVAL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO Film Festival del Cortometraggio Ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre dal 20/01/2017 al 26/08/2017 dal 05/02/2017 al 31/12/2017 Grazzano Visconti (PC) Circo e Spettacoli di strada MERCATINO GRAZZANESE 2017 Mostra-Mercato dell'Antiquariato, Modernariato & Vintage, Artigianato Vernasca (PC) Artistico BASCHERDEIS 2017 18/02/2017, 18/03/2017, 15/04/2017, 20/05/2017, 17/06/2017, dal 28/07/2017 al 30/07/2017 15/07/2017, 19/08/2017, 16/09/2017, 21/10/2017 e 18/11/2017 Caorso (PC) Escursioni e Visite guidate RICORDI DEL PASSATO Ogni quarta domenica del mese Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 26/02/2017, 26/03/2017, 23/04/2017, 28/05/2017, 25/06/2017, VELEIA ROMANA 23/07/2017, 27/08/2017, 24/09/2017, 22/10/2017, 26/11/2017 e Zona archeologica dal 01/01/2017 al 31/03/2018 24/12/2017 Vigoleno (PC) Eventi Multipli I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE Opere dell'ingegno creativo Castello di Gropparello (PC) dal 19/03/2017 al 24/09/2017 GIORNATE FANTASTICHE AL CASTELLO DI GROPPARELLO 2017 Piccoli grandi eroi nel castello incantato dal 02/07/2017 al 27/08/2017 Musica Gropparello (PC) Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piacenza, Pecorara, NOTTURNI STELLATI Calendasco, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Agazzano, Castel San 15/07/2017, 22/07/2017, 29/07/2017, 05/08/2017, 12/08/2017, Giovanni, Ziano Piacentino, Rottofreno, -

Hannibal As Spy Chief
Hannibal as spy chief Rose Mary Sheldon Hannibal’s abilities as a general are legendary.1 In fact, the Carthaginian’s activities in the Second Punic War made such a lasting impression on history that the conflict was branded ‘Hannibal’s War’. 2 Yet, in all the narratives of the war and in biographies of Hannibal, his role as spymaster has been generally ignored. 3 The Second Punic War offers numerous examples of the advantages good intelligence can give to a political and military leader, and Hannibal was both. For nearly two decades the Romans found themselves locked in deadly warfare with a spymaster whose use of intelligence was unmatched. It was a contest that severely strained all of Rome’s resources – political, military, economic, and social – and yet it was Hannibal who ultimately lost the war. Hannibal, as a spymaster, can tell us much about the use of strategic and tactical intelligence, counterintelligence, and the role they played in the history, culture and international relations of the Mediterranean world in the third century BC. Hannibal’s War Hannibal came to his command after the death of his father and Carthage’s loss of the First Punic War. Losing Sicily, Sardinia, and Corsica to the Romans in the recent war led the Carthaginians to seek a new province to replace the sources of revenue and co-opted manpower of which they had recently been deprived. They began building a new empire in Spain that would help pay off their sizable war indemnity, and serve as a future base of operations against the Romans. -

Val Luretta.Pdf
Val Luretta La Val Luretta è una piccola vallata che si incunea tra la val Trebbia ad est e la val Tidone ad ovest, inizia alle pendici del monte Serenda (759 m s.l.m.) dove le due valli si riuniscono e si estende da una zona collinare fino alla Pianura Padana dove il torrente omonimo confluisce nel Tidone. Il torrente Luretta è formato dalla confluenza di due rami: quello di Monteventano che nasce al Moiaccio e quello di San Gabriele che nasce a Groppo. Ha una portata limitata e durante le estati secche l'acqua smette di scorrere. Essendo una vallata chiusa, e con una sola strada di una certa importanza, rimane una zona molto tranquilla e priva di traffico. Un quadro dove la campagna e i declivi sono ingentiliti dagli spazi verdi e dai geometrici tagli dei prati e delle vigne: in questa dolce valle sono le pietre e i sassi di fiume a rappresentare le più importanti tessere del grande mosaico storico. Con splendide case rurali di pietra e con un diffuso sistema di castelli, la Val Luretta costituisce sicuramente un osservatorio privilegiato per comprendere l'evoluzione dell'architettura castrense e rurale del Piacentino. Fin dai tempi più antichi, la Val Luretta è stata infatti una importante terra di passaggio ed ancora oggi un loro considerevole numero di castelli e rocche caratterizza in maniera evidente e marcata il suo paesaggio. Il centro più importante della valle è Agazzano, le cui origini risalgono ai tempi dell'occupazione romana. Qui s'impone una visita accurata al castello, uno dei più bei manieri della provincia piacentina, a lungo "corte" privilegiata della famiglia Scotti. -

Fa Pr PC 12Lu 2018 Corretto.Pdf
Provincia Piacenza Comuni Pop.resid. 1/1/2018 Sup. in Km2 Abitanti per Km2 Agazzano 2.060 36,15 56,99 Alseno 4.696 55,27 84,96 Besenzone 959 23,95 40,05 Bettola 2.756 122,37 22,52 Bobbio 3.588 106,53 33,68 Borgonovo Val Tidone 7.943 51,22 155,08 Cadeo 6.108 38,48 158,73 Calendasco 2.465 36,94 66,73 Caorso 4.733 40,98 115,49 Carpaneto Piacentino 7.742 63,08 122,74 Castell'Arquato 4.637 52,75 87,91 Castel San Giovanni 13.784 44,04 312,95 Castelvetro Piacentino 5.356 35,06 152,79 Cerignale 123 30,82 3,99 Coli 873 71,69 12,18 Corte Brugnatella 580 46,31 12,52 Cortemaggiore 4.677 36,47 128,23 Farini 1.201 112,36 10,69 Ferriere 1.237 178,5 6,93 Fiorenzuola d'Arda 15.299 59,77 255,96 Gazzola 2.068 44,48 46,5 Gossolengo 5.655 31,1 181,83 Gragnano Trebbiense 4.620 34,61 133,48 Gropparello 2.267 56,33 40,24 Lugagnano Val d'Arda 3.988 54,4 73,31 Monticelli d'Ongina 5.295 46,33 114,28 Morfasso 985 83,93 11,74 Ottone 495 98,96 5 Piacenza 103.262 118,24 873,36 Pianello Val Tidone 2.232 36,29 61,51 Piozzano 623 43,61 14,29 Podenzano 9.163 44,34 206,67 Ponte dell'Olio 4.720 43,92 107,48 Pontenure 6.509 33,85 192,3 Rivergaro 7.105 43,83 162,1 Rottofreno 12.243 35,17 348,13 San Giorgio Piacentino 5.685 49,19 115,56 San Pietro in Cerro 837 27,35 30,61 Sarmato 2.862 27,26 105 Travo 2.131 81,01 26,3 Vernasca 2.083 72,57 28,7 Vigolzone 4.308 42,04 102,48 Villanova sull'Arda 1.751 36,57 47,88 Zerba 77 24,13 3,19 Ziano Piacentino 2.534 32,78 77,31 Alta Val Tidone 3.060 100,87 30,34 Totale 287.375 2.585,86 111,13 Quadro riepilogativo degli ambiti territoriali e delle Unioni di Comuni Distretti sociosanitari Ambiti territoriali Unioni di Comuni Evoluzione delle Unioni di Comuni Popolazione Sup. -

Hydrogeologïcal Features of the Po Valley (Northern Italy)
HYDROGEOLOGÏCAL FEATURES OF THE PO VALLEY (NORTHERN ITALY) PARTICULARITÉS HYDROGÉOLOGIQUES DE LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE PO (ITALIE DU NORD) C. BORTOLAMI1, G. BRAGA2, A. COLOMBBTTI3, A. DAL PRÀ4, V. FRANCANT5, F. FRANCAVILLA6, G. GIULIANO7, M. MANFREDINI7, M. PELLEGRINI3, F. PETRTJCCI8, R. POZZI5, S. STEFANINI9 1 Institute of Geology, University of Torino. 2 Institute of Geology, University of Pavia. 3 Institute of Geology, University of Modena. 4 Institute of Geology, University of Padova. 5 Institute of Geology, University of Milano. 6 Institute of Geology, University of Bologna. 7 Water Research Institute, National Research Council, Rome. 8 Institute of Geology, University of Parma. 9 Institute of Geology, University of Trieste. RESUME Cette note donne pour la première fois une synthèse des conditions hydrogéologiques de la Plaine du Pô (Italie du Nord) : en effet les études entreprises jusqu'à présent ne concernaient que des secteurs très limités. Un programme de recherche, organisé et financé par l'Institut de Recherche sur les Eaux du Conseil National des Recherches et réalisé avec la collaboration des Instituts de Géologie de la région du Pô, a permis d'étudier les aspects hydrogéologiques de vastes unités territoriales de la Plaine. Sur la base d'environ 10 000 coupes stratigraphiques de puits d'eau ainsi que des données hydrauliques et chimiques de 21 000 autres puits il a été possible d'arriver à une evaluation approximative satisfaisante des conditions structurelles des aquifères, qui se trouvent presque exclusivement dans les dépôts continentaux du Quaternaire (dépôts rnorainiques, fluviatiles et fluvio-glaciaires). La Plaine du Pô est en effet un grand bassin subsidant et qui a été caractérisé au Quaternaire par une grande vitesse de dépôt (épaisseur moyenne de.800 m); il est limité au Nord et à l'Ouest par les Alpes, au Sud par les Apennins et à l'Est par la Mer Adriatique. -

State of Play Analyses for Po River Basin, Italy
State of play analyses for Po River Basin, Italy Contents Socio-economic characterization of the region ............................................................... 2 General ...................................................................................................................................... 2 Hydrology .................................................................................................................................. 7 Regulatory and institutional framework .......................................................................... 8 Legal framework ........................................................................................................................ 8 Standards .................................................................................................................................. 9 Other institutional aspects ...................................................................................................... 10 Identification of key actors ............................................................................................. 10 Existing situation of wastewater treatment and agriculture ......................................... 15 Characterization of wastewater treatment sector: ................................................................ 15 Characterization of agricultural sector: .................................................................................. 15 Existing related initiatives .............................................................................................. -

CHE CLASSE Classifica 28 Ottobre
1 PLURICLASSE ELE Primaria (San Pietro in Cerro) 412 2 VOLPI MAT Giovanni Rossi (Ponte Dell'Olio) 329 3 MONOSEZIONE MAT Scuola Infanzia (Vigolo Marchese) 257 4 SCOIATTOLI MAT San Giuseppe (Podenzano) 236 5 5 UNICA ELE Primaria (Ferriere) 230 6 4 UNICA ELE 25 Aprile - Borgotrebbia (Piacenza) 170 7 ROSSA MAT Nostra Signora di Lourdes (Piacenza) 138 8 BLU MAT Don Burgazzi (Carpaneto) 137 9 1A ELE Pascoli (San Polo) 125 10 3B ELE Due Giugno (Piacenza) 119 11 1A ELE Collodi (San Giorgio) 101 12 CARCIOFI VERDI MAT San Quintino (Gossolengo) 99 13 1A MED Italo Calvino - V. Boscarelli (Piacenza) 84 14 2A ELE Baiardi (Pianello) 83 15 3F ELE Pesaro (Castel San Giovanni) 82 16 3 UNICA ELE S. Eufemia (Piacenza) 78 17 2B ELE De Amicis (Piacenza) 74 18 UNICA MAT Fogliani Pallavicino (Castelnuovo Fogliani) 64 19 BLU MAT Scuola Infanzia (Borgonovo) 60 20 5 UNICA ELE Primaria (Quarto) 59 21 4E ELE Primaria (Gazzola) 58 22 B MAT Gerbido (Piacenza) 52 23 4A ELE Rodari (Podenzano) 46 24 4B ELE Carella (Piacenza) 41 25 5B ELE Rodari (Podenzano) 40 26 DELFINI MAT Inacqua (Piacenza) 40 27 C MAT Parrocchia di San Fiorenzo (Fiorenzuola) 38 28 PLURICLASSE MED Bruzzi (Farini) 36 29 2B ELE Collodi (San Giorgio) 35 30 2A ELE Mazzini (Piacenza) 32 31 3C ELE Amaldi (Carpaneto) 32 32 5B ELE Mazzini (Piacenza) 31 33 VERDE MAT Armani (Bobbio) 30 34 2I ELE Primaria (Calendasco) 28 35 5B ELE Don Minzoni (Piacenza) 26 36 1C ELE Pezzani (Piacenza) 24 37 2A ELE Don Minzoni (Piacenza) 24 38 3C ELE Rodari (Podenzano) 23 39 4A ELE Carella (Piacenza) 23 40 5G ELE Primaria (Besenzone) -
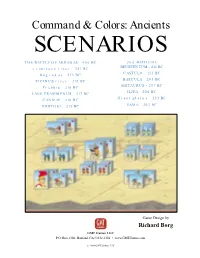
Command & Colors: Ancients SCENARIOS
Command & Colors: Ancients 1 Command & Colors: Ancients SCENARIOS THE BATTLE OF AKRAGAS – 406 BC 2nd BATTLE OF BENEVENTUM - 214 BC crimissos river – 341 BC CASTULO – 211 BC bagradas – 253 BC BAECULA – 208 BC TICINUS river – 218 BC METAURUS - 207 BC Trebbia – 218 BC ILIPA – 206 BC LAKE TRASIMENUS – 217 BC Great plains – 203 BC CANNAE – 216 BC DERTOSA – 215 BC ZAMA – 202 BC Game Design by Richard Borg GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 • www.GMTGames.com © 2006 GMT Games, LLC 2 Command & Colors: Ancients THE BATTLE OF AKRAGAS – 406 BC CARTHAGINIAN Mago Himilco MA HM A AA LC CH LB L CH LB LB L LC A H H H H A A MC Daphnaeus Dionysius SYRACUSAN Historical Background War Council It is a time of violent competition between the Syracusan Ty- Carthagian Army rants (military dictators) and Carthage for control of Sicily. The • Leader: Himilco Carthaginians under Himilco have besieged Akragas, a city al- • 5 Command Cards lied with Syracuse, prompting Daphnaeus and his army to march to its aid. The Carthaginians split their army into an observation Syracusan Army force in front of Akragas, and a blocking force sent to oppose • Use Roman blocks Daphnaeus. The Carthaginian army was almost totally merce- • Leader: Daphnaeus nary, while Daphnaeus’s contained veteran heavy infantry that • 6 Command Cards proved invincible when committed to the battle. The survivor’s • Move First of Himilco’s badly beaten army fled to the coastal fort shelter- Victory ing Mago’s observation force. There was no pursuit and no fur- 5 Banners ther battle. -

Albo Giudici Popolari Corte D'assise D'appello 2015
GESTIONE ALBO GIUDICI POPOLARI Giudici Corte d'Assise d'Appello __________________________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Cognome/Nome Residenza Professione Nascita: data/luogo Tit.studio __________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ALBERONI NEREO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 27/01/1961, SAN GIORGIO PIACENTINO ( S.NICOLO'-VIA ALICATA n.52/A MATURITA' COMMERCIALE LBRNRE61A27H887V 2 ALBERTELLI FABRICE ROTTOFRENO (PC) AUTISTA 16/08/1968, PARIGI (FRANCIA) ROTTOFRENO-VIA IACOPONE DA TODI LICENZA MEDIA SUPERIORE LBRFRC68M16Z110I 3 ASCIONE CIRO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 15/04/1962, TORRE DEL GRECO (NA) S.NICOLO'-VIA PASCOLI n.24 MATURITA'COMMERCIALE SCNCRI62D15L259C 4 BETTINARDI ROBERTO ROTTOFRENO (PC) IDRAULICO 21/10/1961, CAGLIARI (CA) S.NICOLO'-VIA DON BOREA n.2/A MATURITA' INDUSTRIALE BTTRRT61R21B354V 5 CALLEGARI DANILO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 19/06/1960, PIACENZA (PC) S.NICOLO'-VIA PAPA GIOVANNI PAO MATURITA' INDUSTRIALE CLLDNL60H19G535N 6 GHITTONI ANDREA ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 07/10/1962, PIACENZA (PC) S.NICOLO'-VIA AGAZZANO n.70/B MATURITA' INDUSTRIALE GHTNDR62R07G535U 7 IORIO ANTONIO FRANCESCO ROTTOFRENO (PC) IMPIEGATO 03/06/1957, ORTA NOVA (FG) S.NICOLO'-VIA ARGINE n.8 MATURITA' SCIENTIFICA RIONNF57H03G131O 8 LUPPATI FRANCESCO ROTTOFRENO (PC) DISEGNATORE MECCANIC 21/06/1967, PIACENZA (PC) S.NICOLO'-VIA GIORDANI n.5/D LICENZA MEDIA SUPERIORE CANCELLATO (GOSSOLENGO) 9 PANELLI