Classe V Sez. A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nr.7 (1215) 2015-04-03
ŠIAURĖS ATĖNAI ISSN 1392-7760 2015 m. balandžio 3 d. Nr. 7 (1215) Kaina 0,95 Eur / 3,28 Lt Gintautas Mažeikis: teisuoliai pasitiki ir dalinasi linksminančiomis žiniomis p. 4 Romanas gyveno labai amerikietišką pasaulio užkariautojo gyvenimą p. 5 Jūratės Sprindytės ir Giedros Radvilavičiūtės recenzijos p. 12, 13 Rašyti lietuviškai – vadinasi, būti Kalba, pasakyta Kovo 11-osios išvakarėse Lietuvių literatūros ir tautosakos institute atsiimant premiją už kūrybiškiausią 2014 metų knygą „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“, kurią išleido leidykla „Apostrofa“ Šis apdovanojimas išliks su manimi visam kaip vienas ryto“ iškirptų Rolando Rastausko tekstų būčiau kitokia džiugiausių mano gyvenimo įvykių. Spėju, kad jis išliks ir DALIA StApoNKutė autorė. Visų minėtų rašytojų kūrybą studijavau iš labai ar- instituto istorijoje kaip įdomus faktas, turintis ne tik kul- ti, kruopščiai. Galima ir reikia perskaityti šimtus knygų, tūrinį, bet ir politinį atspalvį. Juk šiemet apdovanojimas Pusę gyvenimo gyvenau, supama graikų ir kitų kultūrų, tačiau dėl vienos ar kitos priežasties didžiausią įtaką mums keliauja už Lietuvos ribų – balsui „iš šalies“. Jis sklinda ne mokiau savo vaikus lietuvių kalbos Kipre, ir tai leido man padaro tik geras dvyliktukas labai skirtingų autorių. Lie- iš galingo Europos centro, o, galima sakyti, – iš periferijos, pastebėti, jog mūsų, lietuvių, kelionė po pasaulį yra unika- tuva dovanojo man žanrą, Kipras – klausimus, pasaulis – iš tolimo Europos pakraščio, Homero kalbos slėptuvės – li. Niekas nepakartos mūsų maršrutų, ir mes neatkartosime turinį. Kipro. Gal dėl to labiausiai ir jaudina tas lietuvių kalbos ir kitų gyvensenos. Būdami lietuviai, mes žvelgiame į pasau- Toji nepaprasta sąsaja „Lietuva–Kipras“ ir toliau liks Homero kalbos saugotojos derinys. Jis politiškai svarbus lį kaip lietuviai. -

Cuando El Dios No Está Ausente
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo CUANDO EL DIOS NO ESTÁ AUSENTE: COSMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA EN EL TIMEO DE PLATÓN TESIS DOCTORAL: JORGE CANO CUENCA DIRECTOR: FRANCISCO L. LISI BERETERBIDE FACULTAD DE HUMANIDADES: DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 1 2 ÍNDICE………………………………………………………………………………….3 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………...5 AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………..11 I. ALETHINOS LOGOS, EIKOS LOGOS, EIKOS MYTHOS EN LOS RELATOS HISTÓRICO Y COSMOLÓGICO DEL TIMEO: MUNDO, VERDAD Y SENSACIÓN………………………...12 I, 1. Poetas, sofistas: mímesis y εἴδωλον………………………………………15 I, 2. τό µὴ πλασθέντα µῦθον ἀλλ᾽ ἀληθινὸν λόγον: diversos aspectos sobre Egipto y el relato de la Atlántida……………………………………………….37 I, 3. El proemio de Timeo………………………………………………………50 I, 3, 1. El contexto religioso del eikos logos: el logos como himno. El Timeo y la Teogonía de Hesíodo…………………………………………………………...50 I, 3, 2. Eikos logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo…..70 II. EL TIMEO Y LOS FRAGMENTOS DEL PERI PHYSEOS DE FILOLAO DE CROTONA...113 II, 1. El fragmento 6 de Filolao: la ἁρµονία………………………………….116 II, 1, 1. ἁρµονία y número: el cosmos como unidad y orden…………………119 II, 1, 2. La ἁρµονία como proporción matemático-musical. El fr. 6a y el alma del mundo en el Timeo………………………………………………………...141 II, 2. La creación del alma del mundo como introducción de número y límite: Timeo y los limitantes e ilimitados de Filolao………………………………...149 II, 3. Las cuatro causas del Filebo y los limitantes e ilimitados de Filolao…...155 II, 4. Platón como “lector” del pitagorismo, a modo de acercamiento………..173 II, 5. -

HIPPOLYTUS: a TRAGEDY of HUMAN AMECHANIA Link to the Abstract
Cecilia Cozzi University of Cincinnati [email protected] CAMWS 2020 HIPPOLYTUS: A TRAGEDY OF HUMAN AMECHANIA link to the abstract: https://camws.org/sites/default/files/meeting2020/abstracts/2089HippolytusAmechania.pdf 1.A Aeschylus Agam. 1112- 11131 ΧΟΡΟΣ::οὔπω ξυνῆκα· νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων ἐπαργέμοισι θεοσφάτοις ἀ μηχανῶ; Chorus: I still don’t understand; the riddling words in these obscure oracles leave me quite at a loss. 1.B Aeschylus Agam. ll. 1173-1177 ΧΟΡΟΣ: ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾿ ἐφημίσω, καί τίς σε κακοφρονῶν τίθησι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπίτνων μελίζειν πάθη γοερὰ θανατοφόρα· τέρμα δ᾿ ἀμηχανῶ. Chorus: What you have uttered now follows on from what went before, and some divinity that wishes you ill is assailing you very heavily and causing you to sing of woeful, deadly sufferings; I am at a loss how it will end 1.C Aeschylus Choe. 220-221 ΗΛΕΚΤΡΑ: ἀλλ᾿ ἦ δόλον τιν᾿ , ὦ ξέν᾿, ἀμφί μοι πλέκεις; ΟΡΕΣΤΗΣ: αὐτὸς κατ᾿ αὐτοῦ τἄρα μηχανορραφῶ. Electra: Look here, sir, are you trying to weave some web of trickery around me? Orestes: If I am, then I must be hatching plots against myself! 2.A Sophocles Elec. 140-144 1 for the Libation Bearers and the Agamemnon, translations by A.H. Sommerstein; for Electra, translation by H. Lloyd-Jones, for Hippolytus and Medea, translation by D. Kovacs 1 ΧΟΡΟΣ: ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾿ ἀμήχανον ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι, ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐστιν οὐδεμία κακῶν. τί μοι τῶν δυσφόρων ἐφίῃ; Chorus: No, leaving moderation aside and plunging into grief irresistible you lament ever, to your ruin. In this there is no way of undoing evil; why are you set on misery? 2.B Sophocles Elec. -
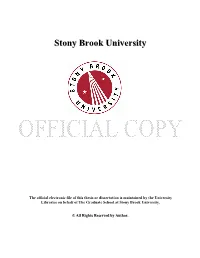
000000304.Sbu.Pdf
SSStttooonnnyyy BBBrrrooooookkk UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy The official electronic file of this thesis or dissertation is maintained by the University Libraries on behalf of The Graduate School at Stony Brook University. ©©© AAAllllll RRRiiiggghhhtttsss RRReeessseeerrrvvveeeddd bbbyyy AAAuuuttthhhooorrr... Borderlands of Psyche and Logos in Heraclitus: A Psychoanalytic Reading A Dissertation Presented by Jessica Ann Mayock to The Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Philosophy Stony Brook University May 2008 Stony Brook University The Graduate School Jessica Ann Mayock We, the dissertation committee for the above candidate for the Doctor of Philosophy degree, hereby recommend acceptance of this dissertation. Dr. Edward Casey – Dissertation Advisor Distinguished Professor of Philosophy Dr. Donn Welton – Chairperson of Defense Professor of Philosophy Dr. Peter Manchester Associate Professor of Philosophy Dr. Bruce Wilshire Professor of Philosophy, Rutgers University This dissertation is accepted by the Graduate School Lawrence Martin Dean of the Graduate School ii Abstract of the Dissertation Borderlands of Psyche and Logos in Heraclitus: A Psychoanalytic Reading by Jessica Ann Mayock Doctor of Philosophy in Philosophy Stony Brook University 2008 Heraclitus is the first philosopher to focus on the psyche, but he also raises language to a cosmological principle, thereby giving his enigmatic statements a unique status. They are not intended to describe cosmos as much as to evoke it, making his cosmology a psychology. The true subject of his work is the psychological process it initiates. Attempts by commentators to attribute a doctrine to Heraclitus or to impose an order upon his fragments have therefore always misrepresented him, since his ‘method’ is to frustrate any method that would project itself upon him. -

Near-Eastern Echoes in Iliad XVI 33–35
1 Near-Eastern Echoes in Iliad XVI 33–35 Apostolia Alepidou In Iliad XVI, Patroclus, devastated by the numerous deaths and injuries inflicted on the Achaean army by Hector, approaches Achilles and accuses him of being idle in the face of the disaster: he insists on his wrath, although the situation demands for immediate intervention. Right before asking Achilles to let him instead join the war as the commander of the Myrmidons (Iliad XVI 36–45), Patroclus addresses his dear friend with some harsh words: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς, οὐδὲ Θέτις μήτηρ˙ γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι,1 ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. Pitiless one, your father, it appears, was not the horseman Peleus, nor was Thetis your mother, but the gray sea bore you, and the sheer cliffs, since your mind is unbending.2 Iliad XVI 33–35 Patroclus’ comment on Achilles’ parentage, unparalleled in Homer’s epic, is puzzling and difficult to interpret. “You were born from the sea and the rocks, not from Thetis and Peleus,” is what Patroclus tells Achilles, and even though the context leaves no doubt that this is a reproach to cruel and merciless Achilles, the interpretation of this phrase has troubled readers and scholars since antiquity. This paper aims to shed light on the origin and, consequently, the 1 My emphasis. 2 Translation by Murray 1999. 2 exact meaning of Iliad XVI 33–35, taking a close look at the common theme of a creature being born from the sea/the rocks that these lines from Iliad XVI and the traditions of ancient cultures in Near East share. -

La Malattia Come Metafora Nelle Letterature Dell'occidente
LA MALATTIA COME METAFORA NEllE LETTERATURE DEll’OCCIDENTE a cura di Stefano Manferlotti LA MALATTIA COME METAFORA NELLE LETTERATURE DELL’OCCIDENTE NELLE LETTERATURE COME METAFORA LA MALATTIA S. Manferlotti (a cura di) LIGUORI EDITORE L’armonia del mondo 11 Collana di letteratura comparata diretta da Stefano Manferlotti La malattia come metafora nelle letterature dell’Occidente a cura di Stefano Manferlotti Liguori Editore Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore (http://www.liguori.it/areadownload/LeggeDirittoAutore.pdf). L’utilizzo del libro elettronico costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel Contratto di licenza consultabile sul sito dell’Editore all’indirizzo Internet http://www.liguori.it/ebook.asp/areadownload/eBookLicenza. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi forma, all’uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati. La duplicazione digitale dell’opera, anche se parziale è vietata. Il regolamento per l’uso dei contenuti e dei servizi presenti sul sito della Casa Editrice Liguori è disponibile all’indirizzo Internet http://www.liguori.it/politiche_contatti/default.asp?c=contatta#Politiche Liguori Editore Via Posillipo 394 - I 80123 Napoli NA http://www.liguori.it/ © 2014 by Liguori Editore, S.r.l. Tutti i diritti sono riservati Prima edizione italiana Giugno 2014 Manferlotti, Stefano (a cura di) : La malattia come metafora nelle letterature dell’Occidente/ Stefano Manferlotti (a cura di) L’armonia del mondo Napoli : Liguori, 2014 ISBN 978 - 88 - 207 - 6334 - 3 (a stampa) eISBN 978 - 88 - 207 - 6335 - 0 (eBook) ISSN 1972-0351 1. -

GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. Del – 1 IMMORTALS
BIOtransfer GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. del – 1 IMMORTALS GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. del IMMORTALS KAZALO: 1 Immortals 1.1 Olympian deities 2 1.2 Protogenoi (primordial) 3 1.3 Titans 4 1.4 Gigantes (giants) 6 1.5 Personified concepts 7 1.6 Chthonic deities 12 1.7 Sea deities 13 1.8 Sky deities 16 1.9 Rustic deities 19 1.10 Agricultural deities 31 1.11 Deified mortals 32 1.12 Health deities 33 1.13 Other deities 34 1.14 Seznam z merilnimi podatki o BIOtransferu 37 Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_gods Ljubljana, 04.04.2013 Stran 1 od 50 121010_BR_FOTO_grške_mitološke_osebe_1.del BIOtransfer GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. del – 1 IMMORTALS 1 IMMORTALS 1.1 OLYMPIAN DEITIES TWELVE OLYMPIANS 1. Aphrodite 2. Apollo 3. Ares 4. Artemis 5. Athena 6. Demeter 7. Dionysus 8. Hades 9. Hephaestus 10. Hera 11. Hermes 12. Hestia 13. Poseidon 14. Zeus Ljubljana, 04.04.2013 Stran 2 od 50 121010_BR_FOTO_grške_mitološke_osebe_1.del BIOtransfer GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. del – 1 IMMORTALS 1.2 PROTOGENOI (PRIMORDIAL) 15. Aether 16. Ananke 17. Erebos or Erebus 18. Gaia or Gaea 19. Hemera 20. Chaos 21. Chronos 22. The Nesoi 23. Nyx or Night 24. Uranus 25. The Ourea 26. Phanes 27. Pontus 28. Tartarus 29. Thalassa Ljubljana, 04.04.2013 Stran 3 od 50 121010_BR_FOTO_grške_mitološke_osebe_1.del BIOtransfer GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. del – 1 IMMORTALS 1.3 TITANS THE TWELVE TITANS 30. Hyperion 31. Iapetus 32. Coeus 33. Crius 34. Cronus 35. Mnemosyne 36. Oceanus 37. Phoebe 38. Rhea 39. Tethys 40. Theia 41. Themis Ljubljana, 04.04.2013 Stran 4 od 50 121010_BR_FOTO_grške_mitološke_osebe_1.del BIOtransfer GRŠKE MITOLOŠKE OSEBE 1. -

Orpheus As an Argonaut in Apollonius Rhodius' Argonautica
Inside Orpheus’ Songs: Orpheus as an Argonaut in Apollonius Rhodius’ Argonautica Andromache Karanika RPHEUS WAS KNOWN to be part of the Argonauts’ crew from at least the sixth century, to judge from a Ometope in Delphi.1 Pindar in his fourth Pythian ode, the first extant, non-fragmentary version in European literature of the famous myth of Jason and the Argonauts, presents Orpheus as an active participant, sent by Apollo, the father of song (Pyth. 4.176–177).2 His part in the expedition is high- lighted further in Apollonius’ Argonautica.3 In the narrative he is 1 The metope of the Sikyonian monopteros: M.-X. Garezou, LIMC 7.1 (1994) 81–105, at 84; G. N. Szeliga, “The Composition of the Argo Met- opes from the Monopteros at Delphi,” AJA 90 (1986) 297–305. For an overview of early literary accounts that include Orpheus in the expedition see W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion2 (London 1952) 27. For Simonides fr.62 (Page, PMG) as referring to the expedition see E. Robbins, “Famous Orpheus,” in John Warden (ed.), Orpheus: The Metamorphoses of a Myth (Toronto 1982) 3–23, at 21. A possible reference by Ibycus: fr.25 PMG. 2 Cf. E. Robbins, “Jason and Cheiron: The Myth of Pindar’s Fourth Pythian,” Phoenix 29 (1975) 205–213, at 205; C. Segal, Orpheus: The Myth of the Poet (Baltimore 1989) 12–13. The ode commemorated the victory of King Arcesilas of Cyrene in the chariot race at the games of 462 B.C.E.; Arcesilas claimed descent from one of the Argonauts. -

Images of Political Personifications
is is a version of an electronic document, part of the series, Dēmos: Clas- sical Athenian Democracy, a publicationpublication ofof e Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities [www.stoa.org]. e electronic version of this article off ers contextual information intended to make the study of Athenian democracy more accessible to a wide audience. Please visit the site at http:// www.stoa.org/projects/demos/home. Athenian Political Art from the Fi h and Fourth Centuries : Images of Political Personifi cations S During Athens’ democratic era, per- sonifi cations, or representations of things, places, or abstractions by the human form, appeared at fi rst on vase paintings and eventually on publicly displayed monuments such as free- standing statues, wall paintings, and low relief illustrations on stone stelai. Whereas few personifi cations in the Archaic period (before ). were political in nature, the use of personi- fi cations and mythological fi gures in a politically allusive manner, in the early Classical period (ca. -), paved Amy C. Smith, “Athenian Political Art from the Fi h and Fourth Centuries : images of political personifi cations,” in C. Blackwell, ed., Dēmos: Classical Athenian Democracy (A.(A. MahoneyMahoney andand R.R. Scaife,Scaife, edd.,edd., e Stoa: a consortium for electronic publi- cation in the humanities [www.stoa.org], . © , A.C. Smith. the way for the explicit use of political personifi cations during the Peloponnesian War (- ) and in the fourth century. is article provides basic information about personifi - cations of political ideas created in the era of the Athenian Democracy (- ). e lists of examples of each personifi cation include all known representations in con- texts that might be called political, “of, belonging, or per- taining to the state or body of citizens, its government and policy, especially in civil and secular aff airs” OED( .). -
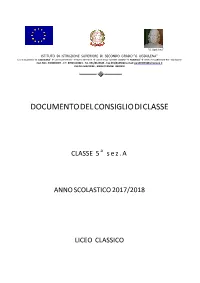
DOC 15 Maggio V a Liceo Classico 2017-18 X Pubbl
“G. Ugdulena” ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO “G. UGDULENA” LICEO CLASSICO “G. UGDULENA” LICEO ARTISTICO - TERMINI IMERESE LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T. PANZECA” ISTITUTO ALBERGHIERO - CACCAMO Cod. Min. PAIS00100T - C.F. 87001110821 - Tel. 091/8145643 - Fax 091/8145064 e-mail: pais00100 [email protected] VIA DEL MAZZIERE - 90018 TERMINI IMERESE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CL ASSE CL ASSE 5 a s e z . A ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LICEO CLASSICO INDICE Presentazione del Consiglio di Classe Pag. 3 Composizione della classe Pag. 4 Presentazione della classe Pag. 5 Programmazione del Consiglio di Classe Pag. 7 Griglie di valutazione Pag. 19 Attività curricolari ed extracurricolari Pag. 32 Terza prova Pag. 33 Prima simulazione Pag. 34 Seconda simulazione Pag. 41 Relazioni finali e programmi Pag. 48 Relazione di italiano Pag. 49 Relazione di latino Pag. 53 Relazione di greco Pag. 57 Relazione di storia Pag. 61 Relazione di filosofia Pag. 64 Relazione di inglese Pag. 67 Relazione di matematica Pag. 70 Relazione di fisica Pag. 75 Relazione di scienze Pag. 81 Relazione di storia dell’arte Pag. 85 Relazione di scienze motorie Pag. 87 1 Relazione di religione Pag. 90 Programma di italiano Pag. 92 Programma di latino Pag. 95 Programma di greco Pag. 97 Programma di storia Pag. 99 Programma di filosofia Pag. 101 Programma di inglese Pag. 107 Programma di matematica Pag. 109 Programma di fisica Pag. 111 Programma di scienze Pag. 113 Programma di storia dell’arte Pag. 117 Programma di scienze motorie Pag. 122 Programma di religione Pag. -

Cuando El Dios No Está Ausente
CUANDO EL DIOS NO ESTÁ AUSENTE: COSMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA EN EL TIMEO DE PLATÓN TESIS DOCTORAL: JORGE CANO CUENCA DIRECTOR: FRANCISCO L. LISI BERETERBIDE FACULTAD DE HUMANIDADES: DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 1 2 ÍNDICE………………………………………………………………………………….3 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………...5 AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………..11 I. ALETHINOS LOGOS, EIKOS LOGOS, EIKOS MYTHOS EN LOS RELATOS HISTÓRICO Y COSMOLÓGICO DEL TIMEO: MUNDO, VERDAD Y SENSACIÓN………………………...12 I, 1. Poetas, sofistas: mímesis y εἴδωλον………………………………………15 I, 2. τό µὴ πλασθέντα µῦθον ἀλλ᾽ ἀληθινὸν λόγον: diversos aspectos sobre Egipto y el relato de la Atlántida……………………………………………….37 I, 3. El proemio de Timeo………………………………………………………50 I, 3, 1. El contexto religioso del eikos logos: el logos como himno. El Timeo y la Teogonía de Hesíodo…………………………………………………………...50 I, 3, 2. Eikos logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo…..70 II. EL TIMEO Y LOS FRAGMENTOS DEL PERI PHYSEOS DE FILOLAO DE CROTONA...113 II, 1. El fragmento 6 de Filolao: la ἁρµονία………………………………….116 II, 1, 1. ἁρµονία y número: el cosmos como unidad y orden…………………119 II, 1, 2. La ἁρµονία como proporción matemático-musical. El fr. 6a y el alma del mundo en el Timeo………………………………………………………...141 II, 2. La creación del alma del mundo como introducción de número y límite: Timeo y los limitantes e ilimitados de Filolao………………………………...149 II, 3. Las cuatro causas del Filebo y los limitantes e ilimitados de Filolao…...155 II, 4. Platón como “lector” del pitagorismo, a modo de acercamiento………..173 II, 5. La ἁρµονία como δεσµός del cosmos: Filebo, Timeo………………….178 II, 6. La ἁρµονία como fisiología del cosmos: Banquete…………………….188 III. -

Allan Alves De Souza Dissertação De Mestrado
Allan Alves de Souza A palavra integradora: o mito na poesia de Orides Fontela Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós- Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Orientadora: Profª. Patricia Gissoni de Santiago Lavelle Rio de Janeiro Maio de 2021 Allan Alves de Souza A palavra integradora: o mito na poesia de Orides Fontela Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós– Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo. Profª. Patricia Gissoni de Santiago Lavelle Orientadora Departamento de Letras – PUC-Rio Prof. Paulo Fernando Henriques Britto Departamento de Letras – PUC-Rio Prof. Pedro Hussak van Velthen Ramos Departamento de Filosofia – UFRRJ Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021 Todos os direitos reservados. A reprodução, total ou parcial do trabalho, é proibida sem a autorização da universidade, do autor e do orientador. Allan Alves de Souza Graduou-se em Letras-Português/Inglês/Literaturas pela UFRRJ sendo bolsista PIBIC em Filosofia e Letras. Graduou-se em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília. Bolsista CNPq no Mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Publicou artigos, traduções e resumos em diversos periódicos acadêmicos nas áreas de Letras e Filosofia. Ficha Catalográfica Souza, Allan Alves de A palavra integradora : o mito na poesia de Orides Fontela / Allan Alves de Souza ; orientadora: Patricia Gissoni de Santiago Lavelle. – 2021. 140 f. : il. color. ; 30 cm Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 2021.