La Malattia Come Metafora Nelle Letterature Dell'occidente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Trying to Live Now Chronotopic Figures in Jenny Watson’S a Painted Page Series
Vol 3, No 1 (2014) | ISSN 2155-1162 (online) | DOI 10.5195/contemp.2014.98 http://contemporaneity.pitt.edu Trying to Live Now Chronotopic Figures in Jenny Watson’s A Painted Page Series Chris McAuliffe Abstract Between late 1979 and early 1980, Australian artist Jenny Watson painted a sequence of six works, each with the title A Painted Page. Combining gridded, painted reproductions of photographs, newspapers and department store catalogues with roughly painted fields of color, the series brought together a range of recent styles and painterly idioms: pop, photorealism, and non-objective abstraction. Watson’s evocation of styles considered dated, corrupted or redundant by contemporary critics was read as a sign of the decline of modernism and the emergence of a postmodernism inflected with irony and a cool, “new wave” sensibility. An examination of the Painted Pages in the context of Watson’s interest in autobiography and her association with the women’s art movement, however, reveals the works to be subjective, highly personal reflections on memory, self and artistic aspiration. Drawing on Bahktin’s model of the chronotope, this paper argues for a spatio-temporal reading of Watson’s Painted Pages rather than the crude model of stylistic redundancy and succession. Watson’s source images register temporal orders ranging across the daily, the seasonal and the epochal. Her paintings transpose Bahktin’s typology of quotidian, provincial and “adventuristic” time into autobiographical paintings of teenage memories, the vicissitudes of the art world and punk subcultures. Collectively, the Painted Pages established a chronotopic field; neither an aggregation of moments nor a collaged evocation of a period but a point at which Watson closed off one kind of time (an art critical time of currency and succession) and opened up another (of subjectivity and affective experience). -
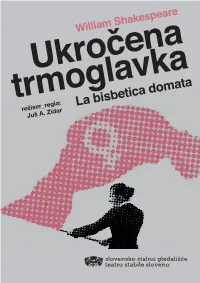
Gledališki List Uprizoritve
1 Na vest, da vam je boljše, so prišli z vedro komedijo vaši igralci; zdravniki so tako priporočili: preveč otožja rado skrkne kri, čemernost pa je pestunja blaznila. Zato da igra vam lahko le hasne; predajte se veselju; kratkočasje varje pred hudim in življenje daljša. William Shakespeare, UKROČENA TRMOGLAVKA 2 3 4 5 William Shakespeare Ukročena trmoglavka La bisbetica domata avtorji priredbe so ustvarjalci uprizoritve adattamento a cura della compagnia režiser/ regia: Juš A. Zidar prevajalec/ traduzione: Milan Jesih dramaturginja/ dramaturg: Eva Kraševec scenografinja/ scene:Petra Veber kostumografinja/ costumi:Mateja Fajt avtor glasbe/ musiche: Jurij Alič lektorica/ lettore: Tatjana Stanič asistent dramaturgije/ assistente dramaturg: Sandi Jesenik Igrajo/ Con: Iva Babić Tadej Pišek Zdravniki so tako priporočili: Vladimir Jurc Tina Gunzek preveč otožja rado skrkne kri, Jernej Čampelj Ilija Ota čemernost pa je pestunja blaznila. Andrej Rismondo Vodja predstave in rekviziterka/ Direttrice di scena e attrezzista Sonja Kerstein Lo raccomandano i medici: Tehnični vodja/ Direttore tecnico Peter Furlan Tonski mojster/ Fonico Diego Sedmak l’amarezza ha congelato Lučni mojster/ Elettricista Peter Korošic Odrski mojster/ Capo macchinista Giorgio Zahar il vostro sangue e la malinconia Odrski delavec/ Macchinista Marko Škabar, Dejan Mahne Kalin Garderoberka in šivilja/ Guardarobiera Silva Gregorčič è nutrice di follia. Prevajalka in prirejevalka nadnapisov/ Traduzione e adattamento sovratitoli Tanja Sternad Šepetalka in nadnapisi/ Suggeritrice e sovratitoli Neda Petrovič Premiera: 16. marca 2018/ Prima: 16 marzo 2018 Velika dvorana/ Sala principale 6 prvih del (okoli leta 1592) odločil, da bo obravnaval ravno t.i. žensko In živela sta srčno esej 01 vprašanje, odnos, ki so ga imeli moški do žensk v elizabetinski družbi, še posebno v pojmovanju inštitucije poroke. -

BTC Catalog 172.Pdf
Between the Covers Rare Books, Inc. ~ Catalog 172 ~ First Books & Before 112 Nicholson Rd., Gloucester City NJ 08030 ~ (856) 456-8008 ~ [email protected] Terms of Sale: Images are not to scale. All books are returnable within ten days if returned in the same condition as sent. Books may be reserved by telephone, fax, or email. All items subject to prior sale. Payment should accompany order if you are unknown to us. Customers known to us will be invoiced with payment due in 30 days. Payment schedule may be adjusted for larger purchases. Institutions will be billed to meet their requirements. We accept checks, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, and PayPal. Gift certificates available. Domestic orders from this catalog will be shipped gratis via UPS Ground or USPS Priority Mail; expedited and overseas orders will be sent at cost. All items insured. NJ residents please add 7% sales tax. Member ABAA, ILAB. Artwork by Tom Bloom. © 2011 Between the Covers Rare Books, Inc. www.betweenthecovers.com After 171 catalogs, we’ve finally gotten around to a staple of the same). This is not one of them, nor does it pretend to be. bookselling industry, the “First Books” catalog. But we decided to give Rather, it is an assemblage of current inventory with an eye toward it a new twist... examining the question, “Where does an author’s career begin?” In the The collecting sub-genre of authors’ first books, a time-honored following pages we have tried to juxtapose first books with more obscure tradition, is complicated by taxonomic problems – what constitutes an (and usually very inexpensive), pre-first book material. -

The Cea Forum 2019
Winter/Spring THE CEA FORUM 2019 Situated Interpretation: Teaching Shakespeare with Live Performance Jessica Winston Idaho State University Writing back in 1997, W.B. Worthen observed that “actual stage performance” had been largely “omitted from the catalogue of ‘discourses’ that inform criticism” (Shakespeare and 154). Now over twenty years later, the situation has changed: one of the liveliest areas of Shakespeare studies is performance criticism—that is, the study of Shakespeare-related theatrical production, performance, and reception. Just as important, actual performance has become an established part of pedagogical practice. As several recent articles attest, Shakespeare instructors routinely incorporate performance-related exercises in their classrooms (e.g. Bevington; Boyer; Costa; Esposito; Hartley, “Dialectical Shakespeare”). It is also relatively common to require or encourage students to attend a live production, such as one might see at a Shakespeare festival or professional theatre, for instance the Guthrie or Folger, or at a regional, university, or community stage. Yet despite this field-wide investment in performance, the viewing and analysis of live productions in teaching remains a curiously unexamined convention in Shakespeare pedagogy. Initially, this claim may sound counterintuitive, if not patently incorrect. Since the 1980s, publications in Shakespeare pedagogy have increasingly emphasized performance approaches to Shakespeare, presenting course and lesson plans with the foundational idea that a Shakespeare play -

Nr.7 (1215) 2015-04-03
ŠIAURĖS ATĖNAI ISSN 1392-7760 2015 m. balandžio 3 d. Nr. 7 (1215) Kaina 0,95 Eur / 3,28 Lt Gintautas Mažeikis: teisuoliai pasitiki ir dalinasi linksminančiomis žiniomis p. 4 Romanas gyveno labai amerikietišką pasaulio užkariautojo gyvenimą p. 5 Jūratės Sprindytės ir Giedros Radvilavičiūtės recenzijos p. 12, 13 Rašyti lietuviškai – vadinasi, būti Kalba, pasakyta Kovo 11-osios išvakarėse Lietuvių literatūros ir tautosakos institute atsiimant premiją už kūrybiškiausią 2014 metų knygą „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“, kurią išleido leidykla „Apostrofa“ Šis apdovanojimas išliks su manimi visam kaip vienas ryto“ iškirptų Rolando Rastausko tekstų būčiau kitokia džiugiausių mano gyvenimo įvykių. Spėju, kad jis išliks ir DALIA StApoNKutė autorė. Visų minėtų rašytojų kūrybą studijavau iš labai ar- instituto istorijoje kaip įdomus faktas, turintis ne tik kul- ti, kruopščiai. Galima ir reikia perskaityti šimtus knygų, tūrinį, bet ir politinį atspalvį. Juk šiemet apdovanojimas Pusę gyvenimo gyvenau, supama graikų ir kitų kultūrų, tačiau dėl vienos ar kitos priežasties didžiausią įtaką mums keliauja už Lietuvos ribų – balsui „iš šalies“. Jis sklinda ne mokiau savo vaikus lietuvių kalbos Kipre, ir tai leido man padaro tik geras dvyliktukas labai skirtingų autorių. Lie- iš galingo Europos centro, o, galima sakyti, – iš periferijos, pastebėti, jog mūsų, lietuvių, kelionė po pasaulį yra unika- tuva dovanojo man žanrą, Kipras – klausimus, pasaulis – iš tolimo Europos pakraščio, Homero kalbos slėptuvės – li. Niekas nepakartos mūsų maršrutų, ir mes neatkartosime turinį. Kipro. Gal dėl to labiausiai ir jaudina tas lietuvių kalbos ir kitų gyvensenos. Būdami lietuviai, mes žvelgiame į pasau- Toji nepaprasta sąsaja „Lietuva–Kipras“ ir toliau liks Homero kalbos saugotojos derinys. Jis politiškai svarbus lį kaip lietuviai. -

Edward De Vere and the Two Shrew Plays
The Playwright’s Progress: Edward de Vere and the Two Shrew Plays Ramon Jiménez or more than 400 years the two Shrew plays—The Tayminge of a Shrowe (1594) and The Taming of the Shrew (1623)—have been entangled with each other in scholarly disagreements about who wrote them, which was F written first, and how they relate to each other. Even today, there is consensus on only one of these questions—that it was Shakespeare alone who wrote The Shrew that appeared in the Folio . It is, as J. Dover Wilson wrote, “one of the most diffi- cult cruxes in the Shakespearian canon” (vii). An objective review of the evidence, however, supplies a solution to the puz- zle. It confirms that the two plays were written in the order in which they appear in the record, The Shrew being a major revision of the earlier play, A Shrew . They were by the same author—Edward de Vere, 17th Earl of Oxford, whose poetry and plays appeared under the pseudonym “William Shakespeare” during the last decade of his life. Events in Oxford’s sixteenth year and his travels in the 1570s support composition dates before 1580 for both plays. These conclusions also reveal a unique and hitherto unremarked example of the playwright’s progress and development from a teenager learning to write for the stage to a journeyman dramatist in his twenties. De Vere’s exposure to the in- tricacies and language of the law, and his extended tour of France and Italy, as well as his maturation as a poet, caused him to rewrite his earlier effort and pro- duce a comedy that continues to entertain centuries later. -

How the Induction Informs Katherine's Character in the Taming of the Shrew
Can’t Be Tamed: How the Induction Informs Katherine’s Character in The Taming of the Shrew Sophia Dobischok, Simon Fraser University Abstract This paper was originally written for Dr. Ronda Arab’s English 203 course Early Modern Literature. The assignment asked students to write an essay about the effect of the introductory scenes (induction) in Shakespeare’s The Taming of the Shrew. The paper uses MLA citation style. In analyses of Shakespeare’s The Taming of the Shrew there has always been contentious debate as to whether Katherine has or has not been successfully tamed by Petruchio. However, the induction provides a crucial framework with which to interpret Katherine’s character arc. The induction parallels the main play in that the lord attempts to tame Sly into performing the role of lord just as Petruchio attempts to tame Katherine into performing the role of submissive wife. Both the lord and Petruchio attempt to tame the person they control by constructing their reality, the lord by controlling Sly’s external environment and Petruchio by contradicting Katherine’s identity and experiences. However, the induction makes it clear that despite the lord’s attempt to make Sly believe in his environment and play the role of lord, he is not able to change Sly’s nature and make him truly become a lord. This provides a framework to understand the effect of Petruchio’s taming on Katherine. Thus, the purpose of the induction is to provide a framework to understand Petruchio and Katherine’s relationship, so we may ultimately understand that although Katherine outwardly plays the role of submissive wife her fierce nature has been undisrupted. -
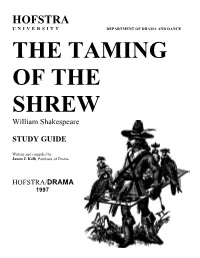
Dd Shrewstudyguide.Pdf
HOFSTRA UNIVERSITY DEPARTMENT OF DRAMA AND DANCE THE TAMING OF THE SHREW William Shakespeare STUDY GUIDE Written and compiled by James J. Kolb, Professor of Drama HOFSTRA/DRAMA 1997 A Study Guide to Hofstra University’s Department of Drama and Dance Production of The Taming of the Shrew by William Shakespeare March 1997 Table of Contents The New Cambridge Shakespeare version of The Taming of the Shrew, edited by Ann Thompson, is the text used in the About Shakespeare 2 current production. It is published in paperback by Cambridge University Press, 40 West 20th Street, New York, Title Page of the First Folio Edition New York 10011-4211 of Shakespeare’s Plays 2 ISBN # 0 521 29388 X ($10.95) Shakespeare’s Coat of Arms 3 Shakespeare’s Plays 3 Shakespeare’s Theatre 4 HOFSTRA/DRAMA Department of Drama and Dance Summary of the Story 5 Hofstra University (516) 463-5444 The Sources of the Story 5 The Date of Composition and Special Problems With the Text of The Taming of the Shrew As Related to The Taming of a Shrew 6 A Few Critical Comments 7 The cover engraving is taken from James Edmund Harting’s About the Play on Stage 10 The Birds of Shakespeare (1871). It depicts hawks in training being carried to the field in “the cadge,” carried by “the Notable Lines 15 cadger.” See page 8 of the Study Guide for some additional comments about falconry. About the Play in Other Forms 16 The idea and format of this study guide is by Peter Sander. -

Alienation and Loneliness of American Postmodern Characters
Journal of Applied Linguistics and Language Research Volume 5, Issue 6, 2018, pp. 28-41 Available online at www.jallr.com ISSN: 2376-760X Alienation and Loneliness of American Postmodern Characters in Salinger’s Masterpiece Catcher in The Rye Shiva Kheirkhah MA student of English language and literature, Islamic Azad University Jieroft Branch Kian Pishkar* Assistant Professor, Department of English language and literature, Islamic Azad University Jieroft Branch Abstract The alienation, loneliness and loneliness of modern man among crowed of the society are the main themes of Salinger's masterpieces which need to be clarified the combination of the two significant literary and social factors in this paper, namely, modern man and alienation, loneliness, and their exploration in Salinger's works of are not much investigated in the literature. Salinger's was one of the greatest literary masters in the last century who influenced and inspired literary masters. Keywords: loneliness, alienation, American literature, Salinger INTRODUCTION Salinger was born (1919–2010) in New York City in 1919. The son of a wealthy father, Salinger grew up in Manhattan and spent his youth was in various prep schools before his parents settled on the Valley Forge Military Academy in1934. Salinger had his first short story published in1940; he continued to write as he joined the army and fought in Europe during World War II. Upon his return to the United States and civilian life in1946, Salinger wrote more stories, publishing them in many respected magazines. His landmark novel, Cather in the Rye, set a new course for literature in post-World War II America and his short stories, many of which appeared in The New Yorker, inspired the early careers of writers such as Phillip Roth, John Updike and Harold Brodkey. -
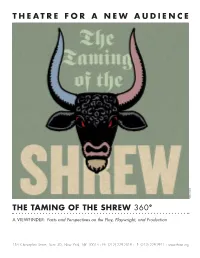
The Taming of the Shrew 360°
THEATRE FOR A NEW AUDIENCE Milton Glaser THE TAMING OF THE SHREW 360° A VIEWFINDER: Facts and Perspectives on the Play, Playwright, and Production 154 Christopher Street, Suite 3D, New York, NY 10014 • Ph: (212) 229-2819 • F: (212) 229-2911 • www.tfana.org tableTABLE OFOF CONTENTSCONTENTS The Play 3 Synopsis and Characters 4 Sources 7 The Induction 9 Sexual Politics and The Taming of the Shrew 13 Perspectives 16 Selected Performance History The Playwright 18 Biography 19 Timeline of the Life of the Playwright 22 Shakespeare and the American Frontier The Production 24 From the Director 25 Scenic Design 26 Building a Sustainable Set 28 Costume Design 31 Cast and Creative Team Further Exploration 35 Glossary 38 Bibliography About Theatre for a New Audience 40 Mission and Programs 41 Major Institutional Supporters Theatre for a New Audience’s production of The Taming of the Shrew is sponsored by Theatre for a New Audience’s production is part of Shakespeare for a New Generation, a national initiative sponsored by the National Endowment for the Arts in cooperation with Arts Midwest. Milton Glaser Notes This Viewfinder will be periodically updated with additional information. Last updated March 2012. Credits Compiled and written by: Carie Donnelson, with contributions from Jonathan Kalb | Edited by: Carie Donnelson and Katie Miller, with assistance from Abigail Unger | Literary Advisor: Jonathan Kalb | Designed by: Milton Glaser, Inc. | Copyright 2012 by Theatre for a New Audience. All rights reserved. With the exception of classroom use by teachers and individual personal use, no part of this study guide may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by an information storage and retrieval system, without permission in writing from the publishers. -

The Taming of the Shrew
Shakespeare The Taming of the Shrew SYNOPSIS The Taming of the Shrew Christopher Sly, a poor tinker, falls asleep after being thrown out of an ale‐house because he is drunk. A lord takes him into his house and plays a trick on him by making him think he is a lord who has lost his memory for whom a company of players will perform the play 'The Taming of the Shrew'. This 'induction' is the frame story. In the play itself Hortensio, who wants to marry a rich woman, old Gremio, who wants to use his money to find a young wife, and Lucentio, who has just arrived in Padua, all want to marry beautiful Bianca, but her father Baptista insists that her older sister Kate must marry first. Kate is a 'shrew', a woman with her own ideas and a violent temper. Petruchio, from Verona, agrees to woo Kate, both for her dowry and for the challenge of 'taming' her. Hortensio and Lucentio both manage to spend time with Bianca by pretending to be tutors, while Lucentio's servant Tranio plays the role of his master. Petruchio marries Kate, but he arrives at the church wearing totally unsuitable clothes and takes her to his country house, where he uses various forms of deprivation to break her will, for instance pretending that any dishes or clothes she is brought are not good enough and must be sent away, or making her agree with everything he says, otherwise she will not be able to sleep or visit her family. Tranio persuades a travelling schoolteacher to pretend to be Lucentio's father, because Baptista wants to be sure that his potential son‐in‐law is respectable and rich enough. -

Philip Seymour Hoffman
PHILIP SEYMOUR HOFFMAN CATHERINE KEENER CLIFTON COLLINS JR. CHRIS COOPER BRUCE GREENWOOD BOB BALABAN MARK PELLEGRINO AMY RYAN in CAPOTE Directed by Bennett Miller Written by Dan Futterman based on the book by Gerald Clarke A Sony Pictures Classics Release EAST COAST WEST COAST DISTRIBUTOR Donna Daniels Public Relations Block- Korenbrot Sony Pictures Classics Donna Daniels Melody Korenbrot Carmelo Pirrone Rona Geller Lee Ginsberg Angela Gresham Ph: (212) 869-7233 Ph: (323) 634-7001 Ph: (212) 833-8833. Fx: (212) 869-7114 Fx: (323) 634-7030 Fx: (212) 833-8844 1375 Broadway, 21st Floor 110 S. Fairfax Ave, Ste 310 550 Madison Ave., 8th Fl. New York, NY 10018 Los Angeles, CA 90036 New York, NY 10022 Visit the Sony Pictures Classics Internet site at: http:/www.sonyclassics.com CAPOTE The Cast Truman Capote PHILIP SEYMOUR HOFFMAN Nelle Harper Lee CATHERINE KEENER Perry Smith CLIFTON COLLINS Jr. Alvin Dewey CHRIS COOPER Jack Dunphy BRUCE GREENWOOD William Shawn BOB BALABAN Marie Dewey AMY RYAN Dick Hickock MARK PELLEGRINO Laura Kinney ALLIE MICKELSON Warden Marshall Krutch MARSHALL BELL Dorothy Sanderson ARABY LOCKHART New York Reporter ROBERT HUCULAK Roy Church R.D. REID Harold Nye ROBERT McLAUGHLIN Sheriff Walter Sanderson HARRY NELKEN Danny Burke KERR HEWITT Judge Roland Tate JOHN MACLAREN Jury Foreman JEREMY DANGERFIELD Porter KWESI AMEYAW Chaplain JIM SHEPARD Pete Holt JOHN DESTRY Lowell Lee Andrews C. ERNST HARTH Richard Avedon ADAM KIMMEL 2 ` CAPOTE The Filmmakers Director BENNETT MILLER Screenplay DAN FUTTERMAN Based on the book “Capote”