As.05.2011.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Libro D'oro Della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 E Preced.Ti. Ed. Collegio Araldico - Roma
FAMIGLIE NOBILI ITALIANE Titoli, Feudi, Riconoscimenti Fonte unica: Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma FAMIGLIA ORIGINE TITOLO FEUDO TRASM.TA' RICONOSCIMENTI ABBATE (de) Conte ved. Vol. III ABBATI PUGLIE Nobile BARLETTA mf D.M. 26.7.1913 ABBATI -MARESCOTTI EMILIA Conte m Patrizio MODENA m ABBIATE LOMBARDIA Nobile S.R.I. mf Conc. 26.2.1561 ABBONDI (de o degli) TRENTINO Nobile S.R.I. mf Conc. 10.7.1558; conf. 1.7.1759 ABELA Nobile ved. Vol. XIX ABIGNENTE CAMPANIA Nobile mf D.M. 9.3.1884 ABIGNENTE (linea Mariano) Barone mpr R.D. 6.9.1934; RR.LL.PP. 11,6.1936 ABIGNENTE Nobile ved. Vol. XXI ABIOSI CAMPANIA Nobile mf R.D. ric. 1.2.1930; RR.LL.PP. 26.6.1930 ABRIANI Conte Pal. ved. Vol. IX Nobile ABRO (d') Principe PAGRATIDE ved. Vol. XIII Don ACCIARDI Nobile ACCINNI Nobile ved. Vol. XIII ACCOLTI GIL PUGLIE Nobile CONVERSANO mf D.M. 10.6.1908 Nobile mf D.M. ric. 10.6.1898 Nobile mf D.M. ric. 22.11.1899 ACCORIMBONI UMBRIA Nobile SPELLO ved. Vol.XIV ACCORRETTI MARCHE Patrizio MACERATA ved. Vol. XIX Nobile FILOTTRANO Nobile CINGOLI Marchese ACCURSI UMBRIA Patrizio TODI ACCUSANI PIEMONTE Barone RETORTO e PORTANOVA Conc. 19.11.1748; D.M. 7.2.1902 ACERBO Barone ATERNO ved. Vol. XIX ACETO di CAPRIGLIA CAMPANIA Nobile Ricon. SMOM 5.12.2002 ACQUA UMBRIA Nobile OSIMO ved. Vol. XXVII Patrizio SPOLETO ACQUADERNI Nobile ved. Vol. XXIII ACQUARONE (d') LIGURIA Duca ved. Vol. XIX Conte Don ACQUAVIVA d'ARAGONA PUGLIE Duca ATRI ved. -

Collana Del Dipartimento Di Studi Storici Università Di Torino 9
COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI UNIVERSITÀ DI TORINO 9 Jennifer Cooke Millard Meiss Tra connoisseurship, iconologia e Kulturgeschichte Ledizioni © 2015 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Jennifer Cooke, Millard Meiss. Tra connoisseurship, iconologia e Kulturgeschichte Prima edizione: settembre 2015 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-370-4 ISBN ePub: 978-88-6705-371-1 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO DIRETTORE DELLA COLLANA: Adele Monaci COMITATO SCIENTIFICo: Secondo Carpanetto, Giovanni Filoramo, Carlo Lippolis, Stefano Musso, Sergio Roda, Gelsomina Spione, Maria Luisa Sturani, Marino Zabbia Nella stessa collana sono stati pubblicati in versione cartacea ed ePub: 1. DAVIDE LASAGNO, Oltre l’Istituzione. Crisi e riforma dell’assistenza psichiatrica a Torino e in Italia 2. LUCIANO VILLANI, Le borgate del fascismo. Storia urbana, politica e sociale della periferia romana 3. ALESSANDRO ROSSI, Muscae moriturae donatistae circumvolant: la costruzione di identità “plurali” nel cristianesimo dell’Africa Romana 4. DANIELE PIPITONE, Il socialismo democratico italiano fra la Liberazione e la legge truffa. Fratture, ricomposizioni e culture politiche di un’area di frontiera. 5. MARIA D’AMURI, La casa per tutti nell’Italia giolittiana. Provvedimenti e iniziative per la municipalizzazione dell’edilizia popolare 6. EMILIANO RUBENS URCIUOLI, Un’archeologia del “noi” cristiano. Le «comunità immaginate» -
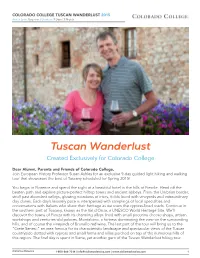
TUSCAN WANDERLUST 2015 Ability Level: Beginner / Duration: 9 Days / 8 Nights
COLORADO COLLEGE TUSCAN WANDERLUST 2015 Ability Level: Beginner / Duration: 9 Days / 8 Nights Tuscan Wanderlust Created Exclusively for Colorado College Dear Alumni, Parents and Friends of Colorado College, Join European History Professor Susan Ashley for an exclusive 9-day guided light hiking and walking tour that showcases the best of Tuscany scheduled for Spring 2015! You begin in Florence and spend the night at a beautiful hotel in the hills of Fiesole. Head off the beaten path and explore picture-perfect hilltop towns and ancient abbeys. From the Umbrian border, stroll past abundant valleys, glowing meadows of irises, fields laced with vineyards and extraordinary clay dunes. Each day’s leisurely pace is interspersed with samplings of local specialties and conversations with Italians who share their heritage as we roam the cypress-lined roads. Continue in the southern part of Tuscany, known as the Val d’Orcia, a UNESCO World Heritage Site. We’ll discover the towns of Pienza with its charming alleys lined with small pecorino cheese shops, artisan workshops and centuries-old palaces, Montalcino, a fortress dominating the view on the surrounding hills, and of course the vineyards of Brunello red wine. The last part of the tour will bring us to the “Crete Senesi,” an area famous for its characteristic landscape and spectacular views of the Tuscan countryside dotted with cypress and small farms and villas perched on top of the numerous hills of this region. The final day is spent in Siena, yet another gem of the Tuscan Wanderlust hiking tour. Ciclismo Classico 1-800-866-7314 | [email protected] | www.ciclismoclassico.com 1 COLORADO COLLEGE TUSCAN WANDERLUST 2015 Ability Level: Beginner / Duration: 9 Days / 8 Nights MEET SUSAN ASHLEY A member of the Department of History at Colorado College, Susan Ashley teaches European history, especially intellectual and social history, as well as environmental history. -

TUSCAN LEGACY L’Eredità Di Un Sapere Antico Tour & Experience
TUSCAN LEGACY L’eredità di un sapere antico Tour & experience Dolci colline di un verde acceso, filari di cipressi che si rincorrono, casolari che dominano le alture. Viaggiare in Val d'Orcia, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Concedetevi il lusso di scoprire questo angolo di toscana lentamente e intensamente, anche se avete solo pochi giorni di tempo. Amiamo profondamente questa terra e, dopo tanti anni di ricerche e soddisfazioni personali, abbiamo deciso di condividere le nostre conoscenze con chiunque voglia fare di un viaggio un'esperienza autentica ed indimenticabile. I colori, i sapori, la storia della terra e della sua gente sono indissolubili; quello che vi proponiamo non è solo un "tour enogastronomico" ma la condivisione dell'eredità di un territorio. Il progetto TUSCAN LEGACY si compone di percorsi, che attraverso il filo conduttore dell'esplorazione culinaria, uniscono apprendimento culturale, bellezza naturale e benessere. Il nostro obiettivo è quello di farvi sentire parte del territorio. Arte, storia, cultura, natura, salute, non saranno argomenti di visite guidate, ma motivo di incontro con persone che ve ne parleranno attraverso il loro vissuto, creando esperienze uniche ed irripetibili. Attraverso la cucina, le nostre ricette ed i loro ingredienti vorremmo farvi rivivere le stesse esperienze a tavola, arricchendo la vostra prospettiva, educando il palato a sapori non contraffatti, con la speranza di creare un bagaglio di emozioni che possiate utilizzare anche nella vostra vita quotidiana. 1 IL TOUR Domenica pomeriggio: arrivo e check-in nella struttura ricettiva, benvenuto, incontro con gli accompagnatori, visita di Monticchiello, cena e pernottamento. -

Portrait of Italian Jewish Life (1800S – 1930S) Edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue N
Portrait of Italian Jewish Life (1800s – 1930s) edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue n. 8, November 2015 QUEST N. 8 - FOCUS QUEST. Issues in Contemporary Jewish History Journal of Fondazione CDEC Editors Michele Sarfatti (Fondazione CDEC, managing editor), Elissa Bemporad (Queens College of the City University of New York), Tullia Catalan (Università di Trieste), Cristiana Facchini (Università Alma Mater, Bologna; Max Weber Kolleg, Erfurt), Marcella Simoni (Università Ca’ Foscari, Venezia), Guri Schwarz (Università di Pisa), Ulrich Wyrwa (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin). Editorial Assistant Laura Brazzo (Fondazione CDEC) Book Review Editor Dario Miccoli (Università Cà Foscari, Venezia) Editorial Advisory Board Ruth Ben Ghiat (New York University), Paolo Luca Bernardini (Università dell’Insubria), Dominique Bourel (Université de la Sorbonne, Paris), Michael Brenner (Ludwig-Maximilians Universität München), Enzo Campelli (Università La Sapienza di Roma), Francesco Cassata (Università di Genova), David Cesarani z.l. (Royal Holloway College, London), Roberto Della Rocca (DEC, Roma), Lois Dubin (Smith College, Northampton), Jacques Ehrenfreund (Université de Lausanne), Katherine E. Fleming (New York University), Anna Foa (Università La Sapienza di Roma), François Guesnet (University College London), Alessandro Guetta (INALCO, Paris), Stefano Jesurum (Corriere della Sera, Milano), András Kovács (Central European University, Budapest), Fabio Levi (Università degli Studi di Torino), Simon Levis Sullam (Università Ca’ -
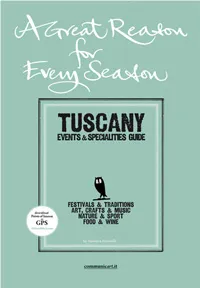
Preview Eng 2012.Pdf
Copyright © 2011 by Communicart.it – Firenze Printed by : Industria Grafica Pistolesi – Ed Il Leccio srl. Via della Resistenza, 117- Loc.Badesse Monteriggioni (Siena) Author: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) Concept Design: Arch. Nicola Natalizio Cover Calligraphy: Betty Soldi Editing Team Veronica Ficcarelli, Bess Melendez , Nina Brown, Rachel Mascetta Translation: Bess Melendez, Nina Brown , Rachel Mascetta Photographs: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) with the unique contribution of Rachel Mascetta & Dave Yoder Printed in February 2012 by Industria Grafica Pistolesi – Siena map of Tuscany __ 6 __ __ 7 __ Remembering Santa Lucia, One of the most magical places in Tuscany. For me, and for my friends from all over the world - a perfect place. “E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il lungo corso dei fiumi, e l’immensità dell’Oceano, ed il volgere degli astri... e si dimenticano di se medesimi” (Men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty billows of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, and pass themselves by) Sant’Agostino This book is dedicated to Mochy , my dog the best everything ever had in my life for over 17 years __ 8 __ __ 9 __ __ HOW TO CONSULT THE GUIDE __ Content Introduction Dedicated sections on Spring, Summer, Fall & Winter Events: Celebrations & Traditions; Art, Crafts & Music; Food & Wine; Nature & Sport Tuscan Specialties from the Producers’ Point of View: Tradition, Handicraft, -

Toscana Underground
TOSCANA UNDERGROUND TOSCANA www.turismo.intoscana.it UNDERGROUND nd u o gr r e d Un Underground BEAUTIFUL INSIDE AS OUTSIDE a n a c s o Toscana Regione Toscana T CAVES • MINES • NECROPOLISES d groun r Unde a an c os T grotte, miniere e musei ipogei, bottini, cantine e magazzini fenomeni carsici, della miniera, necropoli, cunicoli sotterranei, scavati nella roccia, sofoni minerali e opere di drenaggio interni delle mura nel tufo etc... relativi musei, e idrauliche, cittadine archeologia mineraria tagliate e industriale nd u o gr r e d Un Underground a n a c s o Toscana T d groun r Unde a an c os T grotte, miniere e musei ipogei, bottini, cantine e magazzini fenomeni carsici, della miniera, necropoli, cunicoli sotterranei, scavati nella roccia, sofoni minerali e opere di drenaggio interni delle mura nel tufo etc... relativi musei, e idrauliche, cittadine archeologia mineraria tagliate e industriale nd u o gr r e d Un Underground a n a c s o Toscana T The logo represents an ammonite, a fossil that was once alive and has become an object, a “treasure” d to discover, offered to us by the earth. The image is contrasted to groun such a point that it almost becomes r abstract; it is cold and immobile, Unde but at the same time the spiral is a a vortex that shows a way, and invites an c us to delve under the surface. os T LEGEND Services n Visiting rules b Bookshop s Special indications l Picnic area u Educational activities F Bar grotte, miniere e musei ipogei, bottini, cantine e magazzini fenomeni carsici, della miniera, necropoli, cunicoli sotterranei, scavati nella roccia, t Restaurant sofoni minerali e opere di drenaggio interni delle mura nel tufo etc.. -

I Parchi Archeologici: Un’Occasione Di Tutela E Sviluppo Per Il Territorio
I Parchi archeologici: un’occasione di tutela e sviluppo per il territorio. Indice. Abstract. Introduzione. 1. I parchi archeologici italiani. Problemi metodologici. 1.1. Storia degli studi 1.2. Definizione 1.3. Istituzione 2. I Parchi archeologici. Data base. 2.1. La schedatura 2.1.1 Parchi 2.2.2 Contatti 2.2.3 Servizi 2.1.4 Sito web 2.2.4 Web 2.0 2.1.6 Grado di turisticità 2.1.7 Potenzialità 2.2 I parchi 3. I parchi archeologici nell’ordinamento legislativo italiano: normativa e nuove “Linee guida”. 3.1. La normativa statale e regionale di riferimento 3.2. Le Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici 3.2.1 Progetto scientifico 3.2.2 Progetto di tutela e valorizzazione 3.2.3 Progetto di gestione 3.2.4 Accreditamento 4. La gestione dei parchi archeologici. 4.1. I piani di gestione UNESCO 4.2. Il confronto con alcuni parchi europei 4.3. I parchi archeologici italiani 1 5. La fruizione: dall’accessibilità ai servizi. 5.1. Accessibilità reale e virtuale 5.2. Accoglienza, biglietteria e servizio informazioni 5.3. Dotazioni fisse: strumenti di comunicazione multi-level, multi-target, multilingual. 5.4. Servizi accessori 5.4.1 BookShop e merchandising 5.4.2 Servizi igienici 5.4.3 Bar/caffetteria 5.4.4 Parcheggio 5.4.5 Parco giochi/area svago 5.5. Altri servizi 5.5.1 Guide cartacee 5.5.2 Audioguide 5.5.3 Visite guidate 5.5.4 File audio mp3 5.5.5 Applicazioni per smart phone 5.5.6 Sussidi alla visita multilingue 5.5.7 Servizio per non vedenti 5.5.8 Postazioni informatiche 5.5.9 Ricostruzioni a cielo aperto 5.5.10 Laboratori didattici 5.5.11 Archeologia sperimentale 5.5.12 Partecipazione ad attività di scavo 5.5.13 Formazione per operatori museali 5.5.14 Eventi 5.5.15 Museo, centr0 di documentazione 5.5.16 Fototeca e mediateca 5.5.17 Sala per attività didattiche 5.5.18 Altri spazi (laboratorio di restauro, biblioteche specializzate ecc) 5.5.19 Carta dei servizi 6. -

Landscape Influence on the Development of the Medieval City-State of Siena, Italy
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 23(2Bis), 2010 - Volume Speciale - 283-298 LANDSCAPE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE MEDIEVAL CITY-STATE OF SIENA, ITALY Armando Costantini1 & I. Peter Martini2 1Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Siena, Italy 2School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, ON, N1G 2W1 Canada Corresponding author: I.P. Martini <[email protected]> ABSTRACT: Costantini A. & Martini I.P., Landscape influence on the development of the medieval city-state of Siena, Italy. (IT ISSN 0394-3356, 2010) This paper examines how the landscape has influenced the development of the medieval–early Renaissance city-state of Siena, Italy. Siena is a hill-top town with a historic ~2 km2 wide core surrounded by ancient city walls. It still preserves the medieval urban plan and Gothic architecture, and its inhabitants keep ancient traditions alive. It is built on Pliocene, loosely cemented, calcareous, marine, porous sandstone that overlies impermeable marine calcareous silty clay. The town is limited on three sides by steep slopes indented by secondary deep, narrow, small valleys. The forth side to the north is a gently sloping terrain along the hilltop leading to distant high- lands. This geomorphologic setting had been beneficial to the development of the town during mediaeval times because readily defendable and, being far from wet, unhealthy, malaria-infested lowlands, it was crossed by a major medieval pilgrimage route (Via Francigena) to Rome. However the hilltop location presented difficulties such as scarce availability of water and limited space to expand. Siena tried valiantly to adapt to the demand of expanding population and international markets. -

Pisa in the Middle Ages: Archaeology, Sptial Analysis and Predictive Modeling
Mappa | Pisa in the Middle Ages: archaeology, sptial analysis and predictive modeling Mappa Pisa in the Middle Ages: archaeology, spatial analysis and predictive modeling www.mappaproject.org Gabriele Gattiglia UniversitA´ di PisA 9788868120948_216_LN_03 www.nuovacultura.it ISBN 978-88-6812-094-8 SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK Edizioni Nuova Cultura 26.00 EURO MAPPA PISA IN THE MIDDLE AGES: ARCHAEOLOGY, SPATIAL ANALYSIS AND PREDICTIVE MODELING Gabriele Gattiglia Edizioni Nuova Cultura MAPPA PROJECT Funding bodiesi: Implementing body: Regione Toscana Università di Pisa Università di Pisa Partner: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Artistici Storici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno Comune di Pisa Cooperation: Aerofototeca Nazionale Centro di documentazione aerofotografi ca “Marcello Cosci” – Università di Pisa Consorzio LAMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile – Regione Toscana e CNR Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia Laboratorio di cultura Digitale – CISIAU Centro Interdipartimentale di Servizi Informatici per l’Area Umanistica – Università di Pisa Research team: Francesca Anichini Collaborators: Dario Bini Federico Bertocchino Monica Bini Antonio Campus Nevio Dubbini Lorenza La Rosa Fabio Fabiani Chiara Mannari Gabriele Gattiglia Francesco Rinaldi Serena Giacomelli Claudia Sciuto Maria Letizia Gualandi Giulio Tarantino -

Florence & Tuscany
Italy | Tuscany Florence & Tuscany The Tuscan landscape is dotted prodigious talents to influence TUSCANY with cypresses, vineyard- the artists that followed through Lucca Torre del Lago Florence Pontassieve Pisa Montespertoli covered hills and walled towns the centuries. Radda in Chianti San Gimignano Arezzo Corsignano forming the backdrop for its Volterra Cortona Many of their works can be viewed in Florence, Mediterranian Siena Sea Lake one of the greatest artistic treasure-houses of Montepulciano Trasimeno classic Renaissance art which Campagnatico the world. But Florence is not only history and Grosseto flourished in the 15th-16th culture; shopping here is a delight, especially centuries. Michelangelo amidst the tiny jewellery shops on the Ponte Vecchio; there are the Boboli Gardens - the finest Buonarroti, along with Leonardo in Tuscany - and the local cuisine and regional Da Vinci, were two of the most wines which are simply devine. 1 2 3 4 UNESCO World Michelangelo’s ‘David’ The Palio Medieval Heritage sites No visit to Florence would A twice yearly (2nd July and hilltop towns be complete without seeing 16th August) horse race takes The historic centres of Florence, Visit the charming towns of Michelangelo’s most famous place in Siena’s main piazza. Siena, Pienza and San Gimignano; Montepulciano, Montalcino, masterpiece. The statue, This colourful medieval event the Medici Villas and gardens of Cortona, Rocca d’Orcia and Pienza completed between 1501 and celebrates competition between Tuscany; the grand Piazza del surrounded by the stunning 1503, depicts David before his neighbourhoods (contrade) to win Duomo in Pisa; and the Val d’Orcia. bucolic Tuscan countryside. -

Bel Paese: the Ligurian Coast, Tuscany, the Veneto & the Italian
Bel Paese: The Ligurian Coast, Tuscany, the Veneto & the Italian Lakes 31 AUG – 20 SEP 2016 Code: 21617 Tour Leaders David Henderson Physical Ratings Join David Henderson, a visual artist who has led over 30 tours to Italy and France, exploring the landscapes of the Ligurian Coast, Tuscany, the Veneto & the Italian Lakes. Overview Tour Highlights Join David Henderson, a visual artist who has led over 30 tours to Italy and France, exploring the landscapes of the Ligurian Coast, Tuscany, the Veneto & the Italian Lakes. Study the fine artistic traditions of Genoa, Siena, Florence, and Venice. Take a ferry excursion to study the fascinating terraced mountainsides and picturesque fishing villages of the rugged Cinque Terre. Visit the Abbey of San Gerolamo della Cervara, overlooking the Tigullio Gulf and containing the only surviving monumental Italian garden in Liguria. Visit the Etruscan city of Volterra, and Lucca with its 16th-century city walls and Romanesque churches. Attend a concert in the Church of San Giovanni, Lucca, which celebrates the work of Italian composer, Giacomo Puccini. Dine at two beautiful Tuscan villas and taste Tuscan specialties accompanied by Chianti Classico. Enjoy the genius of Andrea Palladio’s palaces and villas in the Veneto including Villa Barbaro, Maser and the Villa Capra ‘La Rotonda’ in Vicenza. Explore Ravenna, visiting San Vitale, the Mausoleum of Galla Placidia and other richly decorated Byzantine churches. View Verona’s amphitheatre and sites associated with the protagonists of Shakespeare's Romeo and Juliet. Attend an evening drinks reception and private concert at the home of opera singer Rosemary Forbes-Butler in Venice.