Miniere E Ferriere Nel Territorio Dello Stilaro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Caulonia – Gioiosa Jonica – Grotteria – Mammola – Marina Di Gioiosa Jonica – Martone – Monasterace - Pazzano – Placanica – Riace – Roccella Jonica – S
COMUNI DEL DISTRETTO NORD AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA – MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO – PLACANICA – RIACE – ROCCELLA JONICA – S. GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO - STILO. COMUNE CAPOFILA : CAULONIA ********** AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARA-INFERMIERISTICA IN FAVORE DI DISABILI GRAVI, VOUCHER DA EROGARE ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI GRAVISSIMI E SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA’ INFERIORE AI 65 ANNI. In attuazione del Piano degli Interventi socio-assistenziali in favore delle persone non autosufficienti – annualità 2014; - Vista la DGR n. 464 del 12.11.2015 relativa al Piano di Zona per la Non Autosufficienza annualità 2014; - Visto il Regolamento n. 40/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale – Comune Capofila del Distretto Nord – Caulonia, avente ad oggetto l’erogazione di contributi in favore di soggetti in condizione di disabilità grave e gravissima; - Visto il Piano zonale degli interventi (fondo annualità 2014) predisposto dal Distretto Nord secondo le linee guida regionali, dal quale si evince che tra le prestazioni da erogare alle persone con autosufficienti gravi o gravissimi previa elaborazione del Piano Individualizzato di Assistenza presenti nei 19 Comuni del Distretto Nord sono previsti i seguenti interventi: a) voucher per il Servizio di assistenza domiciliare e para- infermieristica, da effettuarsi presso le abitazioni dei disabili -

Expressions of the Calabrian Diaspora in Calabrian Australian Writing
University of Wollongong Research Online Faculty of Arts - Papers (Archive) Faculty of Arts, Social Sciences & Humanities 30-12-2007 Expressions of the Calabrian Diaspora in Calabrian Australian Writing Gaetano Rando University of Wollongong, [email protected] Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/artspapers Part of the Arts and Humanities Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Rando, Gaetano, Expressions of the Calabrian Diaspora in Calabrian Australian Writing 2007. https://ro.uow.edu.au/artspapers/160 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Expressions of the Calabrian diaspora in Calabrian Australian writing* Gaetano Rando University of Wollongong Paolo Cinanni’s (1968 and 1974) socio-historical studies of mass migration from Calabria between 1860 and 1970 have been augmented and enhanced by Pasquino Crupi’s work (1979, 1993-1997, 2002a, 2002b) on the articulation of themes related to this phenomenon in modern and contemporary Calabrian literature. As Joseph Pivato’s (2004) paper shows for Canada, Calabrians in the diaspora too have also given literary articulation to the migration experience and its consequences. Calabrian Australians constitute the second largest Italian regional group (the largest being the Sicilians) and according to community estimates currently number approximately 70000 of which about 38000 are Calabrian born. They have distinguished themselves in Australia mainly in the economic sector such as the many small businesses and the few large ones established by Calabrians while many of the second generation have experienced upwards socioeconomic mobility by entering the professions (solicitors, certified practicing accountants, doctors). -

Lista Generale Degli Aventi Diritto Al Voto.Xlsx
ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA DEL 7 AGOSTO 2016 Lista generale degli aventi diritto al voto Fascia Nr. Comune Cognome Nome luogo di nascita Carica A 1 AGNANA CALABRA FURFARO Caterina Locri SINDACO A 2 AGNANA CALABRA CATALANO Domenico Agnana Calabra CONSIGLIERE A 3 AGNANA CALABRA CUSATO Natale Locri CONSIGLIERE A 4 AGNANA CALABRA FILIPPONE Claudio Locri CONSIGLIERE A 5 AGNANA CALABRA LAROSA Antonio Cinquefrondi CONSIGLIERE A 6 AGNANA CALABRA LUPIS Giuseppe Canolo CONSIGLIERE A 7 AGNANA CALABRA MOIO Antonio Locri CONSIGLIERE A 8 AGNANA CALABRA PISCIONERI Paolo Cinquefrondi CONSIGLIERE A 9 AGNANA CALABRA SANSALONE Emanuele Vittorio Locri CONSIGLIERE A 10 AGNANA CALABRA SITA' Alfredo Agnana Calabra CONSIGLIERE A 11 AGNANA CALABRA SITA' Francesca Siderno CONSIGLIERE A 12 ANOIA DEMARZO Alessandro Anoia SINDACO A 13 ANOIA AUDDINO Salvatore Forbach (Francia) CONSIGLIERE A 14 ANOIA BITONTI Vincenzo Taurianova CONSIGLIERE A 15 ANOIA CERUSO Daniele Polistena CONSIGLIERE A 16 ANOIA CONDO' Anna Reggio Calabria CONSIGLIERE A 17 ANOIA MACRI' Francesco Anoia CONSIGLIERE A 18 ANOIA MARAFIOTI Giuseppe Anoia CONSIGLIERE A 19 ANOIA MEGNA Federico Polistena CONSIGLIERE A 20 ANOIA MIRENDA Luca Polistena CONSIGLIERE A 21 ANOIA SARLETI Domenico Anoia CONSIGLIERE A 22 ANOIA SORRENTI Mariantonella Messina CONSIGLIERE A 23 ANTONIMINA CONDELLI Antonio Antonimina SINDACO A 24 ANTONIMINA MAIO Francesco Locri CONSIGLIERE A 25 ANTONIMINA MURDACA Francesco Locri CONSIGLIERE A 26 ANTONIMINA PELLE Luciano Antonimina CONSIGLIERE A 27 ANTONIMINA -

San Giovanni Theristis. Una Basilica Bizantina in Epoca Normanna
HUMANITIES - Anno VII, Numero 13, Giugno 2018 DOI: 10.6092/2240-7715/2018.1.47-80 ELIA FIORENZA1 - NICOLA GIUDICE2 San Giovanni Theristis. Una basilica bizantina in epoca normanna Premessa La comprensione della storia di un luogo, generalmente, è aiutata dalla ricerca dei documenti che in qualche misura dimostrino la sincerità delle nostre affermazioni ed il rigore del nostro metodo. Nella nomenclatura dell’archeologia e dell’architettura religiosa Katholikón sta ad indicare l’oratorio di un monastero. Esso era situato o al centro del cenobio o al centro della laura (o “lavra”)3, ovvero una sorta di villaggio eremitico. Focus di questo lavoro è il Katholikón di San Giovanni Theristis (o Terista), monastero conosciuto anche come “San Giovanni Vecchio” ovvero “San Giovanni tra i due fiumi4”. Si tratta di una basilica normanna fondata non su rocce, ma su solidi 1 Elia Fiorenza, Dottorando c/o Dottorato di ricerca in “Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia” Università della Calabria. (Tematica: Territorio, architettura, costruzioni e beni culturali). Dottore magistrale in Archeologia, con tesi di laurea di ricerca in Storia Bizantina dal titolo il “Stilo Bizantina e la Cattolica”, relatore prof. Filippo Burgarella - correlatore prof. Gioacchino Strano, Università della Calabria. ([email protected]). 2 Nicola Giudice, laureando in ingegneria civile, specializzando nella tutela e fruizione del patrimonio culturale, presidente dell’Osservatorio Permanente per i Beni Culturali (onlus) c/o Università della Calabria. 3 Distinta dall’eremo - dove il monaco vive solo, - e dal cenobio - ove il monaco vive in comunità, in celle separate ma cinte da un muro - la laura indica un gruppo più o meno grande di celle monastiche - per lo più formate di piccole capanne o di grotte scavate nel terreno arido e roccioso -, ognuna separata dalle altre, ma con una chiesa in comune e con un sacerdote che amministra i sacramenti e, spesso, ma non sempre, guida i monaci nella vita spirituale - anacoreti, quindi, in senso stretto. -
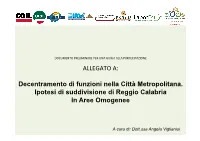
Ipotesi Di Suddivisione Di RC in Aree Omogenee Con Loghi.Pptx
DOCUMENTO PRELIMINARE PER UNA GUIDA ALLA PARTECIPAZIONE ALLEGATO A: Decentramento di funzioni nella Città Metropolitana. Ipotesi di suddivisione di Reggio Calabria in Aree Omogenee A cura di: Dott.ssa Angela Viglianisi Distretto 3 Città Metropolitana di Reggio Calabria Distretti Popolazione Distretto 1 Distretto 1 - Stretto (5 collegi elettorali) 209'428 Distretto 2 - Locride (4 collegi elettorali) 162'570 Distretto 3 - Piana (5 collegi elettorali) 178'797 Totale 550'795 Distretto 2 Circondari Popolazione Municipio 1 - Villa S. Giovanni (StreFo 5) 44'847 Municipio 2 - Reggio centro 1 (StreFo 1) 44'057 Municipio 3 - Reggio centro 2 (StreFo 2) 37'028 Municipio 4 - Reggio sud (StreFo 3) 39'341 Municipio 5 - Pellaro (StreFo 4) 44'155 Municipio 6 - Melito (Grecanica) 34'834 Municipio 7 - Bovalino (Locride 2) 37'441 Municipio 8 - Siderno (Locride 1) 42'752 Municipio 9 - Caulonia (Locride 3) 47'543 Municipio 10 - Polistena (Piana 1) 42'536 Municipio 11 - Palmi (Piana 2) 30'369 Municipio 12 - Gioia Tauro (Piana 3) 37'798 Municipio 13 - Taurianova (Piana 4) 37'488 Municipio 14 - Bagnara Calabra (Costa Viola) 30'606 Totale 550'795 Abitanti Abitanti Numero N. DISTRETTI N. MUNICIPI Residenti Residenti Comuni Villa San Giovanni (Villa San Giovanni, Campo Calabro, Santo Stefano in 1 Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi, Calanna, 44.847 7 Reggio Nord_Catona Salice Rosalì Villa San Giuseppe, Gallico Sambatello) Reggio Calabria Centro 1 (Reggio Centro_Archi, Ortì Pordagoni Terreti, Centro Storico, 2 44.057 - Pineta Zerbi Tremulini Eremo, Santa Caterine San Brunello 1 STRETTO 209.428 Vito) Reggio Calabria Centro 2 3 37.028 - (Reggio Centro_Ferrovieri Stadio Gebbione, Sbarre) Reggio Calabria Sud 4 (Trabocchetto Condera Spirito Santo, S. -

The Golden Eagle Aquila Chrysaetos in the Aspromonte National Park: First Surveys on Its Status and Ecology
Avocetta 41: 81-84 (2017) The Golden Eagle Aquila chrysaetos in the Aspromonte National Park: first surveys on its status and ecology GIUSEPPE MARTINO1,*, ANTONINO SICLARI2, SERGIO TRALONGO2 1 Ci.Ma. G.R. e C.A. (Gestione Ricerca e Consulenze Ambientali) - Via Temesa 16, 89131 Reggio Calabria, Italy 2 Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte - Via Aurora 1, 89057 Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC), Italy * Corresponding author: [email protected] In recent decades, the Golden Eagle Aquila chrysaetos ed into seven research zones, with field activities covering population in Italy has been negatively affected by numer- the period December 2015 up to August 2016. For the hab- ous environmental transformations determined through itat analysis, a vegetation map (Spampinato et al. 2008) anthropogenic actions: the gradual abandonment of tradi- was used, by dividing the territory into four environmental tional agricultural practices, together with the remarkable typologies (unsuitable areas, open areas, woods and refor- decline in pasture activity, mainly at higher altitudes, rep- estation) in order to calculate composition and percentages resent some of the threats that directly affect the species of the environmental typologies for each home range. (Mathieu & Choisy 1982, Huboux 1984, Esteve & Materac This research, carried out during the reproductive sea- 1987, Fasce & Fasce 1992, Pedrini & Sergio 2001, 2002). son, allowed to effectively monitor an area of approxi- In an unfavourable context, especially in regions such mately 310 km2, which is reduced slightly when consider- as Calabria, where these negative factors have had consid- ing the overlap between some observation points and the erable intensity, the role of protected areas has proved to be “shadow zones”. -

I Territori Della Città Metropolitana. Le Aggregazioni a Geometria Variabile
1 Gruppo di lavoro Riccardo Mauro - Vicesindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria Fabio Scionti - Consigliere Metropolitano - coordinamento attività Esperti ANCI Esperti ANCI: Maria Grazia Buffon - Erika Fammartino - Raffaella Ferraro - Domenica Gullone Tutti gli elaborati sono frutto di un lavoro comune e condiviso dal Gruppo di lavoro. Elaborazione documento a cura di:Maria Grazia Buffon Elaborazioni e cartografie (ad eccezione di quelle di cui è citata la fonte) a cura di: Maria Grazia Buffon Copertina e grafica a cura di: Erika Fammartino 2 3 I Territori della Città Metropolitana di Reggio Calabria LE AGGREGAZIONI DEI COMUNI A GEOMETRIA VARIABILE Analisi a supporto della tematica inerente alla Governance e al Riordino istituzionale INDICE 1. PREMESSA ................................................................................................................................................ 6 2. AGGREGAZIONI POLITICO-ISTITUZIONALI ................................................................................. 7 2.1.Unione di Comuni ..................................................................................................................................... 7 2.2. Associazioni di Comuni ........................................................................................................................... 9 2.3. I Comuni ricadenti nel Parco Nazionale dell'Aspromonte e i Landscape dell'Aspromonte Geopark ........................................................................................................................................................ -

Le Vie Dei Parchi” – Terza Edizione
Associazione TassoBarbasso Progetto: “Le vie dei Parchi” – terza edizione PROGRAMMA tappa calabrese (in fase di definizione) 13-18 novembre 2014 Giovedì 13 novembre 2014 Partenza dal Trentino nel primo pomeriggio con pulmino guidato dai soci dell’Associazione TassoBarbasso Durante il viaggio cena in condivisione a cura dei partecipanti Arrivo a Marina di Gioiosa Ionica, sistemazione e pernottamento nelle camere dell’Associazione Don Milani Venerdì 14 novembre 2014 Colazione Passeggiata lungo le spiagge di Marina di Gioiosa Pranzo Partenza per Gerace con una guida ambientale escursionistica ufficiale del Parco Nazionale Aspromonte ed escursione a piedi al monte S. Junio e/o visita del borgo medievale di Gerace. Trasferimento a Riace, cena, sistemazione e pernottamento nell’albergo diffuso dell’associazione Città Futura http://www.cittafuturariace.it/ Sabato 15 novembre 2014 Colazione Trasferimento a Stilo per l’escursione a piedi sul Monte Consolino accompagnati da una guida del Parco Nazionale Aspromonte Pranzo al sacco Associazione TassoBarbasso via Poli Guido 1, 38123 Trento - C.F. 96094750229 [email protected] www.tassobarbasso.it IBAN IT 06 K 08013 01801 000040343876 Associazione TassoBarbasso Trasferimento a Pazzano per l’escursione a piedi sul Monte Stella accompagnati da una guida del Parco Nazionale Aspromonte Trasferimento a Marina di Gioiosa Ionica per cena e pernottamento presso l’Associazione Don Milani Domenica 16 novembre 2014 Colazione Trasferimento a Mammola ed escursione a piedi a San Nicodemo accompagnati -

Middle Oligocene Extension in the Mediterranean Calabro-Peloritan Belt (Southern Italy)
Middle Oligocene extension in the Mediterranean Calabro-Peloritan belt (Southern Italy). Insights from the Aspromonte nappes-pile. Thomas Heymes, Jean-Pierre Bouillin, Arnaud Pecher, Patrick Monié, R. Compagnoni To cite this version: Thomas Heymes, Jean-Pierre Bouillin, Arnaud Pecher, Patrick Monié, R. Compagnoni. Middle Oligocene extension in the Mediterranean Calabro-Peloritan belt (Southern Italy). Insights from the Aspromonte nappes-pile.. Tectonics, American Geophysical Union (AGU), 2008, 27, pp.TC2006. 10.1029/2007TC002157. hal-00283182 HAL Id: hal-00283182 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00283182 Submitted on 29 May 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 Middle Oligocene extension in the Mediterranean Calabro-Peloritan belt (Southern 2 Italy). Insights from the Aspromonte nappes-pile. 3 4 Heymes, T., Bouillin, J.-P., Pêcher, A., Monié, P. & Compagnoni, R. 5 6 Abstract 7 The Calabro-Peloritan belt constitutes the eastward termination of the southern segment 8 of the Alpine Mediterranean belt. This orogenic system was built up during the convergence 9 between the Eurasian and the African plates, roughly directed North-South since the Upper 10 Cretaceous. It was subsequently fragmented during the opening of the Western Mediterranean 11 basins since Oligocene times. -

Page 1 Pag. 1 Di 7 Oggetto: Nazionale Aree Interne (SNAI
R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E Delibera n. _232_ della seduta del _31 MAG. 2021__. Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione della Strategia dell’Area Versante Ionico Serre. Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) _SPIRLI’ Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ___________________________ Dirigente/i Generale/i: ____ (timbro e firma) GIOVINAZZO – NICOLAI – MONTILLA Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) _AMATRUDA - SODA Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: Presente Assente Presidente F.F. 1 ANTONINO SPIRLÌ X 2 DOMENICA CATALFAMO Componente X 3 SERGIO DE CAPRIO Componente X 4 GIANLUCA GALLO Componente X 5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X 6 SANDRA SAVAGLIO Componente X 7 FRANCESCO TALARICO Componente X Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale. La delibera si compone di n. 07 pagine compreso il frontespizio e di n. 02 allegati. Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n°_247893_ del_31/5/2021_ Pag. 1 di 7 LA GIUNTA REGIONALE VISTI - l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, finalizzato all'impiego dei Fondi SIE per la crescita e l’occupazione nel periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che ha previsto, al punto 3.1.6, la Strategia per le Aree Interne, al fine di sollecitare i territori periferici e in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio- economico, stabilendo i criteri e le modalità di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI); - la Delibera CIPE n. -

La Patria; Geografia Dell' Italia. Cenni Storici
i«*T ìt% > t* '.*• ^5" v.4prea Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign http://archive.org/details/lapatriage422stra Ili GEOGRAFIA DELL'ITALIA PROVINCIE DI REGGIO CALABRIA, CATANZARO COSENZA —— PARTI DELL'OPERA PURRLIGATE Introduzione generale (97 figure e 4 carte) L. 7. 25 Legata L. 9. 75 Provincia di Torino (189 figure e 2 carte) » 8.60 » » 11. 10 Alessandria (111 figure e 3 carte) » 5.30 » » 7.80 » Cuneo (57 figure e 3 carte) » 5. — » > 7. 50 Novara (88 figure e 3 carte) » 6. — » » 8. 50 Genova e Porto Maurizio (113 figure e 4 carte) » 8. » » 10.50 » Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Mes- sina, Siracusa e Trapani (185 figure e 5 carte) » 15. — » » 17.50 Roma (274 figure e 29 carte) » 15. — « «17.50 Milano (145 figure e 2 carte) > 10. 60 » » 13. 10 Firenze (150 figure e 5 carte) » 8.40 • » 10. 90 Cagliari e Sassari, Corsica, Malta, Mari d'Italia (59 figure e 3 carte) » 8.60 » » 11. 10 » Arezzo, Grosseto e Siena (80 figure e 3 carte) » 5. 30 » » 7. 80 Perugia (135 figure e 1 carta) » 7. 30 • 9.80 » Como e Sondrio, Canton Ticino e Valli dei Grigioni (58 figure e 1 carta) » 9.30 » » 11.80 » Massa e Carrara, Lucca, Pisa e Livorno (104 figure e 3 carte) » 5. 30 » » 7. 80 Pavia (109 figure e 2 carte) » 6.— • » 8.50 Napoli (238 figure e 5 carte) » 9.30 » » 11.80 » Bergamo e Brescia, con Appendice sulle Valli del Versante lombardo appartenenti air Impero Austro- Ungarico (115 figure e 3 carte) > 10. -

Nature Emotions Culture
19. SIGNS OF ART Catanzaro Day: Saturday Price: 20 € Catalogue of excursions in Calabria Guided tour of the old town of Catanzaro, capital of Calabria Region and guardian of civil and religious buildings of great historical and artistic interest. We will enter the archaeological and numismatic museum and the MARCA, the new art museum that hosts interesting exhibitions of contemporary art, in addition to a rich art gallery-gipsothèque, At the end we Nature stroll into the Mediterranean Biodiversity Park, keeper of several species of lora and fauna and home to the International Sculpture Park, signed by famous artists. Emotions 20. PAINTINGS IN THE WOOD Culture Taverna (CZ) Day: Saturday Price: 25 € The trip starts with a visit to Taverna, an art place of rare depth guardian of the largest collection of Mattia Preti, the fa- mous “cavalier calabrese” follower of Caravaggio, who was born here. Contemporary art will be the protagonist both of a rich gallery and en plein air in the old town centre. Then we will move at the Sila National Park, marked by an undulating 1. CARTHUSIANS, CHARCOAL BURNERS AND PIPE MAKERS landscape of forests and sudden lakes. Here we enter the Visitor Center of Mancuso Village where, in addition to deers, roe deers and owls, two Forest Museums are ready to relate to adults and children the secrets of this green corner. Before to Serra San Bruno (VV) Day: Sunday Price: 20 € come back, free time for shopping of Calabrian souvenirs and typical food. Arrival at the medieval Charterhouse of St. Stephen founded by St.