P. Umberto Fasola. Cultore Dei Santi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XII - VOLUMEN XII ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MCMXX fr fr Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA BENEDICTI PP. XV CONSTITUTIO APOSTOLICA AGRENSIS ET PURUENSIS ERECTIO PRAELATURAE NULLIUS BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Ecclesiae universae regimen, Nobis ex alto commissum, onus Nobis imponit diligentissime curandi ut in orbe catholico circumscriptionum ecclesiasticarum numerus, ceu occasio vel necessitas postulat, augeatur, ut, coarctatis dioecesum finibus ac proinde minuto fidelium grege sin gulis Pastoribus credito, Praesules ipsi munus sibi commissum facilius ac salubrius exercere possint. Quum autem apprime constet dioecesim Amazonensem in Brasi liana Republica latissime patere, viisque quam maxime deficere, prae sertim in occidentali parte, in provinciis scilicet, quae Alto Aere et Alto Purus vocantur, ubi fideles commixti saepe saepius cum indigenis infidelibus vivunt et spiritualibus subsidiis, quibus christiana vita alitur et sustentatur, ferme ex integro carent; Nos tantae necessitati subve niendum duximus. Ideoque, collatis consiliis cum dilectis filiis Nostris S. R. E. Car dinalibus S. Congregationi Consistoriali praepositis, omnibusque mature perpensis, partem territorii dictae dioecesis Amazonensis, quod prae dictas provincias Alto Aere et Alto Purus complectitur, ab eadem dioe cesi distrahere et in Praelaturam Nullius erigere statuimus. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Quamobrem, potestate -

Huysmans Et L'affaire De L'index (1898-1899)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL Clermont Université Huysmans et l’affaire de l'Index (1898-1899) Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Barascud To cite this version: Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Barascud. Huysmans et l’affaire de l'Index (1898-1899). Bul- letin de la Soci´et´eJ.-K. Huysmans, 2007, pp.111-148. <halshs-01315416> HAL Id: halshs-01315416 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01315416 Submitted on 6 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Open licence - etalab JEAN-BAPTISTE AMADIEU PHILIPPE BARASCUD Huysmans et l’affaire de l’Index (1898-1899) Jusqu’à présent, l’éventuelle mise à l’Index de Huysmans n’avait été étudiée que d’après sa correspondance, les témoignages de contemporains, les articles de presse. Jean-Marie Seillan, dans un article récent sur « Huysmans et les censeurs1 », fait le point, à partir de ces matériaux, sur les menaces de censure qui pèsent sur l’auteur dans un chapitre intitulé « Huysmans censuré ? La Cathédrale et l’Index2 ». Pierre Jourde et Brigitte Cabirol avaient quant à eux étudié l’intervention de la princesse Bibesco, le rôle joué par Mme de Sainte-Foix, les réactions de Cécile Bruyère, dans leur édition de la « Correspondance de Huysmans et de la princesse Jeanne Bibesco, Mère Bénie de Jésus », publiée dans notre Bulletin et précédée d’une riche présentation3. -

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XX. - VOLUMEN XX TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DCCCC • XXVIII i fi f j ! f Annus XX - Vol. XX 10 Ianuarii 1928 Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XI LITTERAE ENCYCLICAE AD RR. PP. DD. PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APO STOLICA SEDE HABENTES: DE VERA RELIGIONIS UNITATE FOVENDA. PIUS PP. XI VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM Mortalium animos nunquam fortasse alias tanta incessit cupi ditas fraternae illius, qua - ob unam eandemque originem ac naturam - inter nos obstringimur copulamurque, necessitudinis eum confirmandae tum ad commune humanae societatis bonum transferendae, quantam per nostra haec tempora inoessisse vide mus. Cum enim nationes pacis muneribus nondum plene fruantur, quin immo vetera alicubi et nova discidia in seditiones inque civi les conflictiones erumpant; controversias autem sane plurimas, quae ad tranquillitatem prosperitatemque populorum pertinent, dirimi nequaquam liceat, nisi concors eorum actio atque opera intercedat, qui Civitatibus praesunt earumque negotia gerunt ac provehunt; facile intellegitur - eo magis quod de generis humani unitate iam nulli dissentiunt - quare cupiant plerique, ut, universa eiusmodi germanitate instructae, cotidie arctius variae inter se gentes cohaereant. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Bern haud dissimilem in iis, quae invectam a Christo Domino Novae Legis ordinationem respiciunt, efficere quidam conten dunt. Quod enim pro comperto habeant, homines quovis reli gionis sensu destitutus perraro inveniri, idcirco eam in spem in gressi videntur, haud difficulter eventurum, ut populi, etsi de rebus divinis alii aliud tenent, in nonnullarum tamen professione doctrinarum, quasi, in communi quodam spiritualis vitae funda mento, fraterne consentiant. -

Il Cardinale Pietro Gasparri Segretario Di Stato (1914–1930)
Lorenzo Botrugno Gasparri ed i rapporti con il Regno Unito nel pontificato di Pio XI Spunti per la ricerca a partire dalle sessioni della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Abstract Through unpublished documentary sources – the minutes of the meetings of the Sacred Congregation of Extraordinary Ecclesiastical Affairs – the essay aims to illustrate Pietro Gasparri’s privileged perspective over anglo-vatican relations. While mainly focused on his period as Cardinal Secretary of State of Pius XI (1922–1930), some hints will also be given to his tenure of office during the pontificate of Benedict XV, as well as to Consalvi’s and Rampolla’s influence on his way of perceiving British matters. Gasparri’s role and at titude will be analysed with particular reference to the negotiations on the appointments of Apostolic Delegates in the British Empire (1926) and the conflict between Church and State in Malta (1928–1932). 1 Introduzione Nel giudizio storiografico la persona e l’opera del Gasparri sono state associate, da sempre, a quella corrente della diplomazia pontificia che si richiama al realismo ed alla flessibilità nella ricerca di intese con gli Stati 1: è dal 1932 che Ernesto Vercesi ne percepì la figura allineata a quella di due suoi predecessori al vertice della Segreteria di Stato, i cardinali Ercole Consalvi e Mariano Rampolla del Tindaro, ognuno dei quali rappresentava natu 1 Tale fu, ad esempio, la percezione di Giovanni Spadolini: “Gasparri era, e restava in ogni atto della sua vita, il grand commis della Chiesa, il grande diplomatico spregiudicato e scettico, armato con tutti i ferri del mestiere ma capace di tutte le duttilità e di tutte le astuzie, pur di servire un fine che egli giudicava essenziale”. -

Os Tempos Da Diocese Do Porto”, Desdobrou-Se Por 11 Sessões Mensais, Que Decorreram Entre Janeiro E Dezembro De 2015 E Conheceram Uma Participação Muito Significativa
Adélio Fernando Abreu 25 Luís Carlos Amaral (coordenação) No contexto das celebrações dos 900 anos A coleção Estudos de História Religiosa da restauração da Diocese do Porto e na pretende contribuir para o conhecimento sequência do Colóquio Internacional e compreensão do fenómeno religioso que incidiu sobre o período medieval, o ao longo do tempo, no espaço geográfico Centro de Estudos de História Religiosa A. F. Abreu L. C. Amaral (CEHR) pretendeu dar continuidade (Coord.) português e nos seus círculos de influência, à reflexão, ao debate e à partilha de nas suas várias e diversificadas formas. ideias, conhecimentos e perspetivas de Atualmente, a história religiosa adquiriu análise e de compreensão da história da Dos Homens Diocese, mediante a organização de um peso específico no campo científico, tanto Seminário centrado nas épocas moderna quanto a religião deixou de ser considerada e contemporânea. Com esta iniciativa, foi e da Memória tema “residual” ou em vias de extinção, dada continuidade ao Seminário de História passando a ser perspetivada como fator Religiosa que, de maneira regular e formal, orto Contributos para a história incontornável no estudo das sociedades. tem decorrido no Centro Regional do P Porto da Universidade Católica Portuguesa da Diocese do Porto O manuseamento de nova documentação, desde 2012, dando corpo a uma presença as leituras amplas e interdisciplinares do CEHR no Porto em articulação com o acerca das diversas dimensões do religioso iocese do Gabinete D. Armindo Lopes Coelho. Assim, emória D e da sua articulação com a sociedade, e através de intervenções de especialistas M nas diversas áreas da História e da Teologia, bem como a descoberta de novos temas mas também da Arte e do Património, e problemas, suscitam metodologias recapitularam-se tempos e figuras que abertas e permitem inovadoras visões marcaram a História da Diocese. -

El Iter Del Concilio Plenario Latino Americano De 1899 O La Articulación De La Iglesia Latinoamericana
El iter del Concilio Plenario Latino Americano de 1899 o la articulación de la Iglesia latinoamericana Antón M. PAZOS El Concilio Plenario de América Latina dentro del pontificado de León XIII El Concilio Plenario de América Latina ha pasado de ser un tema ignorado1 a considerarlo piedra miliar o, mejor, embrión de la actual Iglesia latinoamericana. Empieza a generalizarse la idea de que la organización eclesiástica americana esta• ba ya presente en el Concilio Plenario y que desde entonces hasta hoy no se ha he• cho sino avanzar ininterrumpidamente, a través de las distintas conferencias gene• rales del episcopado latinoamericano. Ahora que se cumple el centenario parece oportuno intentar delimitar algo más el tema. En concreto, me parece importante precisar cómo se gestó el Plena• rio, la importancia real que tuvo para América Latina y qué papel jugó Roma en la creación de una conciencia de unidad en la jerarquía eclesiástica latinoamericana. No entraré, por tanto ni en el contenido teológico o canónico del Concilio ni en su desarrollo y aplicación, algo que me parece debería estudiarse también con detalle, sobre todo esto último, que conocemos muy poco. Utilizaré fundamentalmente documentación inédita de los los archivos vatica• nos2, y seguiré, en las líneas generales, el concienzudo trabajo de Diego Piccardo so- 1. En un artículo de 1957 sobre el Plenario Latinoamericano, el autor lamentaba que la Iglesia lati• noamericana hubiese olvidado tan fácilmente «aquel hecho trascendental, con culposa ingratitud» (Pa• blo CORREA LEÓN, El concilio Plenario Latinoamericano de 1899 y la Conferencia Episcopal Latino• americana de 1955, en «Cathedra» XI [1957] 47-61, 54). -

Camillo Mazzella
Camillo Mazzella Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica. 100% Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici. Segui @Cathopedia Camillo Mazzella (Vitulano, 10 febbraio 1833; † Roma, 26 marzo 1900) è stato un Camillo Mazzella, S.J. cardinale italiano. Indice 1 Biografia 1.1 Prebitero e gesuita 1.2 Cardinale 1.3 Vescovo 2 Genealogia episcopale 3 Successione degli incarichi Cardinale Biografia Nacque in una famiglia benestante e molto religiosa. Due dei suoi fratelli, il gemello Ernesto e Pietro, furono pure loro presbiteri: il primo divenne arcivescovo di Bari e il secondo entrò, come Camillo, nella Compagnia di Gesù. Dopo l'istruzione di base avuta da un tutore in casa, all'età di undici anni entrò con il fratello gemello nel seminario di Benevento, dove compì gli studi in filosofia e teologia. Prebitero e gesuita Fu ordinato sacerdote a Benevento l'8 settembre 1855 da mons. Camillo Siciliano di Rende, arcivescovo di Benevento; fu necessaria la dispensa papale perché non aveva ancora raggiunto l'età canonica. Fu canonico di Vitulano del 1855 al 1857. Entrò poi nella Compagnia di Gesù il 4 settembre dello stesso anno. Emise la professione religiosa il 5 settembre 1859 e i voti perpetui il 2 febbraio 1869. Dopo l'espulsione dall'Italia dei gesuiti (1860) studiò alla facoltà francese della Fourvières , dove ottenne il dottorato nel 1867. Terminati gli studi si trasferì negli Stati Uniti, dove fu professore, dapprima presso la Georgetown University di Washington (1867-1869), e poi nell'Università del Sacro Cuore di Woodstock, Maryland (1869- 1875). Dal 1872 al 1875 fu consultore della provincia gesuita del Maryland. -
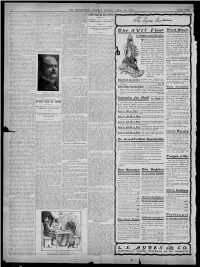
'Petticoats T Taken to Prevent Bites from the Tiger Annual Convention Was Set for June 23, but Mosquitoes
TUE IXDTAXAPOLIS JOÜRXAL, SUNDAY, APRIL 27, 1902 PAKT TWO. lari.il ftjvtr aj If bitten by one of them. by avoiding mosquito bites. To prove that untold suffering to the miners, a great loss Of course, th. m-s- t malignant form of m.i-- J this was true several English surgeons In money to the operators, and the effect SARTO MAY BE NEXT POPE would be so far-reachi- ng that It would be iri.i th.it the mosquitn carries i that in lived for months in a mosquito-proo- f house telt in moft parts of the United States. which one, of them 1ms cither fed upon a In the Roman Campagna and escaped the For the lirst time in the history of the in il.ri.l patient r upon some form of de-cav- fd lever, while the neighboring Inhabitants anthracite' tkld the operators have met - the head officials of the miners' organiza- 1'ATIIIAUCH OF VliMCC AVIIO matter which contained germs of ma- were shaktn daily by th ir chills and many tion and through the mediation of the fed- J larl i an ! l itrr has Mttrn an Individual. died from the fever. These surgeons tar- eration committee discussed their differ- GA1M:U FA.MC AS A PHKACIIEU. "Many popio wonder how the mnquito ried mosquitoes ences. The rer.ült has not been made which had bitten Roman known but will soon be announced. cirrus m tl.Triil pnijn in Us bite. It (Joes fever patient.? this lace back to London at HAS ACCOMPLISHED MISSION. -

October 2014
October, 2014 No. 14 ligious and lai News Re ty th AAof the Assumption e same mission EDITORIAL A year of the Rule of Life “The Assumption will find here, and here only, the secret of its vocation, of its common life and of its mission in the Church.” >> Official Agenda Emmanuel • September 30-October 3, 2014: Inter-Assumption meeting in preparation for the Formators session in Nairobi (Africa). Ordinary General Councils • October 8-223: in Nairobi (Province of Africa). • November 10 to 14, 2014 • January: Council of the Province of Europe. • November 24, 2014: extraordinary Council on finance • December 12, 2014 John • February 2 to 6, 2015 • March 9 to 13, 2015 • September-December 2014: Chaplaincy of the Worcester • June 3 to 8, 2015 students in Rome. • June 22 to 24, 2015 • January-April, 2015: Chaplaincy of the Worcester students • September 14 to 26, 2015 in Rome. • May-June, 2015: Chaplaincy of the American students in Rome. Plenary General Councils • End of July, 2015: Provincial Assembly of the Andean • December 1 to 10, 2014 (December 5, Wenger Province. Colloquium) • June 10 to 20, 2015 Marcelo • September 23-October 8: in Madagascar. Benoît • November 15-25: Meeting of the Latin-American Laity in • September 23-October 23, 2014: Canonical Visitation Bogota. to the Kinshasa region (RDC) and Nairobi • March 30-April 3: Visit to Bulgaria. • October 25, 2014: meeting with the San Egidio • May 1-9: Visit to Jerusalem. community. • May 29-June 1: Visit to Korea • November 25-28, 2014: Reunion of the USG. Launching of the Year of Consecrated Life. -
El Iter Del Concilio Plenario Latino Americano De 1899 O La Articulación De La Iglesia Latinoamericana
El iter del Concilio Plenario Latino Americano de 1899 o la articulación de la Iglesia latinoamericana Antón M. PAZOS El Concilio Plenario de América Latina dentro del pontificado de León XIII El Concilio Plenario de América Latina ha pasado de ser un tema ignorado1 a considerarlo piedra miliar o, mejor, embrión de la actual Iglesia latinoamericana. Empieza a generalizarse la idea de que la organización eclesiástica americana esta- ba ya presente en el Concilio Plenario y que desde entonces hasta hoy no se ha he- cho sino avanzar ininterrumpidamente, a través de las distintas conferencias gene- rales del episcopado latinoamericano. Ahora que se cumple el centenario parece oportuno intentar delimitar algo más el tema. En concreto, me parece importante precisar cómo se gestó el Plena- rio, la importancia real que tuvo para América Latina y qué papel jugó Roma en la creación de una conciencia de unidad en la jerarquía eclesiástica latinoamericana. No entraré, por tanto ni en el contenido teológico o canónico del Concilio ni en su desarrollo y aplicación, algo que me parece debería estudiarse también con detalle, sobre todo esto último, que conocemos muy poco. Utilizaré fundamentalmente documentación inédita de los los archivos vatica- nos2, y seguiré, en las líneas generales, el concienzudo trabajo de Diego Piccardo so- 1. En un artículo de 1957 sobre el Plenario Latinoamericano, el autor lamentaba que la Iglesia lati- noamericana hubiese olvidado tan fácilmente «aquel hecho trascendental, con culposa ingratitud» (Pa- blo CORREA LEÓN, El concilio Plenario Latinoamericano de 1899 y la Conferencia Episcopal Latino- americana de 1955, en «Cathedra» XI [1957] 47-61, 54). -

EDIZIONE DIGITALE EMENDATA Settembre 2014
EDIZIONE DIGITALE EMENDATA Settembre 2014 Convento S. Maria del Buon Consiglio Padri Agostiniani – Genazzano Associazione turistica Pro Loco - Genazzano Gruppo rinascimentale ‘Brancaleone’ Palio di Brancaleone IN MEMORIA DI CAMILLO, ANNA CAROSELLI E CARLO BRAVO ISBN 978-88-909766-0-5 Proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i paesi. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata. L’editore è a disposizione degli aventi diritto per eventuali fonti iconografiche non individuate. Per le fotografie realizzate a Genazzano si ringrazia la signora Rita Camicia (Genazzano). Idea grafica della copertina di Mario Ronzani (Genazzano). In copertina: coperta secentesca del registro appartenente ai Bracaloni de Carlonibus Finito di stampare nel mese di aprile 2014 dalla Tipolitografia Trullo s.r.l. - Roma UN REGISTRO DELLA FAMIGLIA DI GIOVANNI ‘BRANCALEONE’. I BRACALONI DE CARLONIBUS Introduzione, trascrizione e note storiche a cura di ROCCO RONZANI - EMANUELE ATZORI Genazzano-Roma 2014 INDICE Saluti . IX Introduzione . 1 Nota alla trascrizione . 19 Abbreviazioni e sigle . 21 TRASCRIZIONE . 23 APPENDICI E TAVOLE ILLUSTRATIVE . 69 Documenti sciolti presenti nel registro . 71 Testamento e inventario dei beni di Giovanni ‘Brancaleone’ . 77 Note araldico-genealogiche sugli affreschi del chiostro di S. Pio . 85 INDICE DEI NOMI . 111 na città è fatta dalle sue case, dai suoi monumenti, dai suoi paesaggi. UUna comunità è fatta dalle sue genti, dalle storie individuali che passo dopo passo hanno contribuito a costruire quell’identità collettiva che affonda nella sua storia millenaria radici salde e speranza per il futuro. E questa è la nostra storia, di una comunità che ha origini antiche testi- moniate ogni giorno dalle bellezze che ci circondano, dalle vicende dei personaggi più o meno noti che hanno avuto i natali, abitato o frequentato Genazzano dandogli gloria e celebrità. -

Il Cardinale Pietro Gasparri Segretario Di Stato
4 Laura Pettinaroli Massimiliano Valente (a cura di) Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914–1930) HEIDELBERG UNIVERSITY PUBLISHING Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914–1930) Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. Nuova serie Bd. | vol. 4 Laura Pettinaroli, Massimiliano Valente (a cura di) Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914–1930) HEIDELBERG UNIVERSITY PUBLISHING Informazione bibliografica della Deutsche Nationalbibliothek (Biblioteca nazionale tedesca) La Deutsche Nationalbibliothek elenca questa pubblicazione nella Deutsche National bibliografie (Bibliografia nazionale tedesca); dati bibliografici dettagliati sono disponibili su Internet all'indirizzo http://dnb.dnb.de. Quest'opera è stata pubblicata con la licenza Creative Commons 4.0 (CC BY-SA 4.0). Il design della copertina è soggetto alla licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0. Pubblicato da Heidelberg University Publishing (heiUP) Heidelberg 2020. La versione online di questa pubblicazione è disponibile in modo permanente e gratuito (Open Access) sul sito web dell'Università di Heidelberg https://heiup.uni-heidelberg.de. URN: urn:nbn:de:bsz:16-heiup-book-589-3 DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.631 Testo © 2020. I rispettivi autori detengono il copyright dei testi. Impaginazione: werksatz · Büro für Typografie und Buchgestaltung, Berlin ISBN 978-3-947732-84-5 (Hardcover) ISBN 978-3-947732-85-2 (Softcover) ISBN 978-3-947732-86-9 (PDF) Indice sommario Tavola delle abbreviazioni IX Laura Pettinaroli, Massimiliano Valente Introduzione. Pietro Gasparri tra politica estera e Curia romana: giurista intransigente o diplomatico realista? 1 I Immagini di Gasparri tra storia e memoria Luca Carboni Le “Memorie” del cardinale Gasparri e la “Storia documentata della Conciliazione”.