Bollettino D'arte TAV
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

S. Maria Degli Angeli / Bettona / Cannara CANNARA (PG) Southeast of Perugia Cannara Is Just 9.5 Km from Bettona (SS 75, Then SP 410)
ITINERARY 3 ITINERARY 3 S. Maria degli Angeli / Bettona / Cannara CANNARA (PG) Southeast of Perugia Cannara is just 9.5 km from Bettona (SS 75, then SP 410). Founded in the Roman era, the town is situated on the left bank S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) of the Topino river. An impressive cylin- Located about 20 km from Perugia (SS drical tower remains of the old enclo- 75), Santa Maria degli Angeli is a small sure walls, erected in 13th-14th c. industrial centre on the outskirts of As- sisi and a shrine for pilgrims, as it is the WHAT TO SEE site of the Porziuncola, the small chapel Town Hall, where numerous Roman ar- where St. Francis founded the Francis- Perugia chaeological finds are exhibited. S. MARIA can Order in 1209. Pilgrims travel to S. DEGLI Church of S.Matteo, built in the 14th c. Maria degli Angeli, where St. Francis BETTONA ANGELI and reconstructed in 1786, where you frequently sojourned and where he died can admire the triptych Madonna con CANNARA in October 1226, to obtain indulgence. i Ss. Francesco e Matteo by Niccolò di Liberatore, known as Niccolò Alunno. WHAT TO SEE Church of the Buona Morte, which holds Basilica of Santa Maria degli Angeli. An effigies of the Madonna di Loreto. imposing Renaissance structure that Terni Church of S. Sebastiano, with numerous protects and incorporates the ancient frescoes from various epochs removed rural chapel of Porziuncola. Designed from the walls of churches and mona- by Perugian architect Galeazzo Alessi steries of the zone. Cannara – Archaeological sites in 1569, it also houses the Cappella Church of S. -
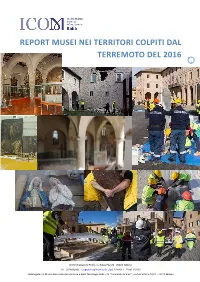
Al Comando Provinciale
REPORT MUSEI NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 2016 1 ICOM Grattacielo Pirelli, via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano T/F. 02/4695693 | [email protected] | P.IVA/C.F. 11661110152 Sede legale c/o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Italia c/o “Leonardo da Vinci”, via San Vittore 19/21 - 20123 Milano Il report è una prima ricognizione realizzata in collaborazione con i soci ICOM presenti nelle regioni colpite. Le notizie sui musei diocesani sono state condivise e verificate dai colleghi dell’AMEI e per i musei scientifici dai colleghi dell’ANMS. Altre notizie sono state fornite per le Marche dal Legambiente Volontariato Marche Gruppo Protezione Civile Beni Culturali. Le informazioni sono aggiornate al 26 novembre 2016, potrebbero modificarsi nel tempo sia per lo sciame sismico ancora in atto, sia per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e delle collezioni. 2 Le segnalazioni si riferiscono ai 33 musei colpiti dall’evento. Va considerato per molti di questi musei il ruolo e il valore dei paesaggi culturali di riferimento. Il terremoto ha colpito duramente il patrimonio diffuso in particolare chiese e palazzi di pregevole valore storico artistico. LAZIO – 2 musei danneggiati Amatrice (RI) |Ex chiesa S. Emidio Museo Civico Crollato L’edifico ha subito il crollo del tetto e di parte delle mura perimetrali est. Distrutti gli affreschi. Distrutto l’allestimento, la collezione non sembra aver subito danni gravissimi. Le opere sono state recuperate dalle macerie. -------- Castelnuovo di Farfa (RI) | Museo dell’Olio Sabina In fase di verifica Non sembrano esservi stati danni strutturali. Ad oggi risultano lesioni su alcuni rivestimenti. -
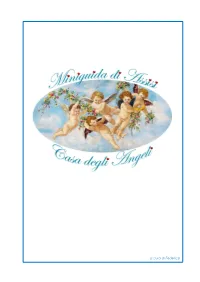
A Cura Di Federico
a cura di Federico Questa nostra miniguida vuole consigliarvi su cosa visitare ad Assisi e su cosa non potete assolutamente perdervi durante il soggiorno nella nostra amatissima città. Le prima parte è dedicata a chi viene ad Assisi per sole poche ore e che quindi non ha tempo per approfondire tutti gli aspetti più interessanti, da quello storico-artistico a quello culinario. Pertanto vi proponiamo una passeggiata per le vie più note della città, che vi permetterà comunque di entrare nella suggestiva atmosfera che solo Assisi sa donare. Vi invitiamo a sfilare dal raccoglitore le pagine di vostro interesse e che considerate essere utili durante il vostro soggiorno. SOMMARIO pag. 3 - Cosa vedere ad Assisi ...se hai fretta !!! pag. 6 - Itinerari consigliati ...per chi non ha fretta !!! pag. 22 - Cosa mangiare ad Assisi pag. 24 - Eventi e ricorrenze principali pag.2 - www.casadegliangeli.onweb.it Cosa vedere ad Assisi...se hai fretta !! La nostra miniguida vuole aiutarti a decidere cosa vedere, cosa fare e cosa mangiare per scoprire la nostra Città, simbolo della pace che si identifica con uno dei santi più amati e venerati al mondo, San Francesco d'Assisi e che è, al contempo, una deliziosa cittadina medievale ricca di angoli caratteristici e tipicità culinarie. Ci sembra d'obbligo cominciare il nostro tour dalla magnifica Basilica di San Francesco, costruita nell'XIII secolo e composta da due parti talmente diverse da essere complementari, la Chiesa Inferiore e la Chiesa Superiore. Varcate le belle porte di quercia scolpite da Niccolò da Gubbio ed entrate nella Chiesa Inferiore; proseguendo in fondo alla navata potrete ammirare la cappella di Santa Caterina, costruita dal famoso cardinale Albornoz, che vi è sepolto. -

Galleria Nazionale Dell'umbria
GALLERIA NAZIONALE 2 DELL’UMBRIA 3 PRESENTAZIONE Il Piano strategico 2020–2023 costituisce il portolano che consentirà di orientare la navigazione della Galleria Nazionale dell’Umbria nei prossimi quattro anni. Nel redigerlo si è tenuto conto delle linee programmatiche messe in atto nel periodo 2016–2019 e della loro realizzazione, considerando le attività previste nel Piano strategico 2020–2023 come il naturale proseguimento e completamento di ciò che è stato previsto, avviato o compiuto fin qui. Alla fine del percorso di otto anni, i primi durante i quali il museo ha speri- mentato le possibilità offerte dall’autonomia scientifica, gestionale e finan- ziaria conferita ai sensi del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, la Galleria avrà cambiato completamente volto, pur avendo mantenuta integra la propria identità storica. Lo scopo del processo evolutivo che si è intrapreso, infatti, è quello di ren- dere il museo un luogo sempre più accogliente, inclusivo, concentrato non soltanto sulla conservazione del patrimonio ma anche sulla ricerca e sulla sua massima condivisione, sull’estensione delle tipologie di pubblico, sul- la completa accessibilità e sull’apertura nei confronti di altre forme d’arte, dalla musica al teatro, dalla letteratura al cinema. In questo senso la radicale digitalizzazione della Galleria ha impresso un ritmo decisamente più sostenuto a tutte le attività, a partire da quelle legate alla conservazione e allo studio, fino alla comunicazione e all’ordinaria ge- stione amministrativa, nella piena consapevolezza che l’unico modo che un museo ha per rimanere sé stesso è quello di trasformarsi continuamente. Il Direttore 4 5 STORIA, IDENTITÀ E COLLEZIONE La Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle principali raccolte d’arte d’Italia, è ospitata ai piani superiori del Palazzo dei Priori di Perugia, sede del Comune fin dall’epoca medievale e significativo esempio di architettura civile gotica. -

Full Article
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE ISSN: 2067-533X Volume 9, Issue 3, July-September 2018: 401-412 www.ijcs.uaic.ro AN INTEGRATED AND ANALYTICAL APPROACH TO STUDY OF MURAL PAINTINGS: THE CASE OF “LO SPAGNA” IN SPOLETO Manuela VAGNINI1*, Marco MALAGODI2, Francesca GABRIELI3, Michela AZZARELLI1, Francesca NUCERA1, Alessia DAVERI1 1 Laboratorio di diagnostica per i beni culturali, piazza Campello 2, 06049 Spoleto (PG)-Italy 2 Dipartimento di musicologia e beni culturali, Laboratorio Arvedi di Diagnostica non Invasiva Museo del Violino, via Bell'Aspa 3, 26100 Cremona 3 National Gallery of Art, 4th and Constitution Avenue NW, Washington, D.C., 20565 USA Abstract The present work shows the advantages of a multi-analytical methodology based on non- invasive and micro-invasive spectroscopic techniques in the study of wall paintings located in San Giacomo’s church in Spoleto (Italy). The cycle of these mural paintings was realized by Giovanni di Pietro named Lo Spagna and his collaborators between 1526 and 1530. This study was focused on the characterization of pigments, in particular the blue ones, binders and degradation products to define the conservation state of these mural paintings and localize the repaints. Portable reflection infrared spectroscopy allowed us to identify the areas to be sampled to perform deeper analyses by scanning electron microscopy with an energy dispersive spectrometer (SEM-EDS). Keywords: - mural painting, blue pigments, reflection infrared spectroscopy, SEM- EDS Introduction Painting materials identification on archaeological works of art such as mural painting is an important task to better understand the materials and the painting technique, especially to select the most suitable conservation and restoration procedures. -

Splendidissima
w eekend Umbria • Spello Splendidissima colonia La prossima apertura al pubblico di una villa romana decorata da pregevoli mosaici offre un motivo in più per visitare l’antica Hispellum e i suoi tesori. n tempo capitale federale degli Umbri, Spello fu della Gens Iulia. Lo si percorre per qualche centinaio di Upresto conquistata dai Romani che continuarono metri fino a incontrare sulla destra la cattedrale dedicata però a riconoscerle un ruolo centrale all’interno del suo a Santa Maria Maggiore, dalla pregevole facciata in stile territorio. Nelle vicinanze della chiesa di San Claudio, presso romanico. Al suo interno si trova la cappella Baglioni le rovine dell’antico teatro, venne rinvenuta nel 1733 un’e- decorata dai meravigliosi affreschi cinquecenteschi del pigrafe nota come il Rescritto di Costantino – gli studiosi Pinturicchio. Al momento l’edificio non è visitabile a ritengono risalga intorno al 335 dopo Cristo – nella quale causa di alcuni interventi di restauro, ma si può ammirare l’imperatore accorda agli Umbri il permesso di celebrare un’altra opera del maestro umbro poco più avanti nella i propri riti e riconosce a Spello il ruolo di città centrale concedendole l’appellativo di Flavia Constans. Oggi il do- cumento, conservato nel palazzo comunale, è lo spunto per La villa dei mosaici Appena fuori dalle mura di Spello, una rievocazione storica che alla fine di agosto d’ogni anno verrà aperta il 24 marzo la Villa di Sant’Anna edificata tra il III riporta la cittadina agli antichi fasti. Ma la scoperta della Spello e il IV secolo dopo Cristo in età tardoimperiale. -

I Pittori Dono Doni E Cesare Sermei (L’Arte Versità Degli Studi Di Firenze
Salvatore Pezzella, ha conseguito la specializzazione in Paleografia presso l’Uni- Salvatore Pezzella, Assisi, i celebri pittori Dono Doni e Cesare Sermei (L’arte versità degli Studi di Firenze. Ex Bibliotecario della Civica d’Assisi (dove ha svolto sacra tra Rinascimento ed epoca moderna)- Edizioni - Viator, Perugia 2019: anche le mansioni di Direttore), professore di Lettere, studioso e ricercatore di SALVATORE PEZZELLA è questa l’ultima fatica dell’Autore. Lo scrittore Herriot afferma che ‘ la cultura manoscritti antichi concernenti la tradizione della medicina popolare dell’Italia centrale e la cucina storica (trattati inediti e pubblicati). Per la storia della medi- è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto’. cina ha pubblicato testi come “Gli erbari, i primi libri di medicina”; “Fitoterapia e I pittori DONO DONI E CESARE SERMEI E Salvatore Pezzella è tra gli studiosi che amano rimestare tra i ‘cassetti medicina in Umbria tra passato e presente”; “Avvelenatori e Avvelenati” (il viag- polverosi ‘ del passato artistico, rivisitare i musei e le pinacoteche e indaga- gio affascinante della storia del veleno in Italia), ecc. Per queste sue opere, ha (La splendida arte sacra in Umbria tra fine Rinascimento e Barocco) re l’arte religiosa. E’ il momento “spirituale” quello di Salvatore Pezzella che, ricevuto riconoscimenti accademici dal Nobile Collegio chimico farmaceutico di dopo la pubblicazione del Libro delle Ore di Anna di Bretagna (2016), e Assisi Roma e dall’Accademia di storia della Medicina. sempre nella Capitale. Esperto di e i luoghi di San Franceasco in una Guoda dimenticata del ‘600 (2017), con “cucina” antica, ha recuperato, negli Archivi dell’Italia centrale, diversi “ricettari” questo nuovo libro si si è cimentato nella sua ultima fatica storico – artistica restituendoli agli appassionati di gastronomia in una forma godibile nella lettura con la vita, le opere e la critica di due grandi artisti assisani: Dono Doni e e con le indicazioni degli “ingredienti” ed “esecuzione” in modo da consentire Cesare Sermei. -
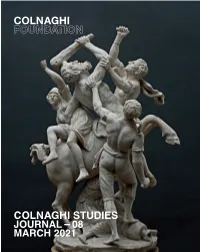
Journal 08 March 2021 Editorial Committee
JOURNAL 08 MARCH 2021 EDITORIAL COMMITTEE Stijn Alsteens International Head of Old Master Drawings, Patrick Lenaghan Curator of Prints and Photographs, The Hispanic Society of America, Christie’s. New York. Jaynie Anderson Professor Emeritus in Art History, The Patrice Marandel Former Chief Curator/Department Head of European Painting and JOURNAL 08 University of Melbourne. Sculpture, Los Angeles County Museum of Art. Charles Avery Art Historian specializing in European Jennifer Montagu Art Historian specializing in Italian Baroque. Sculpture, particularly Italian, French and English. Scott Nethersole Senior Lecturer in Italian Renaissance Art, The Courtauld Institute of Art, London. Andrea Bacchi Director, Federico Zeri Foundation, Bologna. Larry Nichols William Hutton Senior Curator, European and American Painting and Colnaghi Studies Journal is produced biannually by the Colnaghi Foundation. Its purpose is to publish texts on significant Colin Bailey Director, Morgan Library and Museum, New York. Sculpture before 1900, Toledo Museum of Art, Ohio. pre-twentieth-century artworks in the European tradition that have recently come to light or about which new research is Piers Baker-Bates Visiting Honorary Associate in Art History, Tom Nickson Senior Lecturer in Medieval Art and Architecture, Courtauld Institute of Art, underway, as well as on the history of their collection. Texts about artworks should place them within the broader context The Open University. London. of the artist’s oeuvre, provide visual analysis and comparative images. Francesca Baldassari Professor, Università degli Studi di Padova. Gianni Papi Art Historian specializing in Caravaggio. Bonaventura Bassegoda Catedràtic, Universitat Autònoma de Edward Payne Assistant Professor in Art History, Aarhus University. Manuscripts may be sent at any time and will be reviewed by members of the journal’s Editorial Committee, composed of Barcelona. -

Prof.Ssa CARLA MANCINI RESTAURATRICE BENI
Prof.ssa CARLA MANCINI Nata a Perugia il 15 settembre 1960 Dal 1998 docente di discipline pittoriche e restauro con contratto MIUR a tempo indeterminato RESTAURATRICE BENI CULTURALI in base alla normativa vigente (schema di regolamento ex art. 8, comma 11_ sexies della legge 109 del 1994 concernente la individualizzazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) ACCADEMICO DI MERITO con nomina del 9 Marzo 2003 presso l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia in riconoscimento alla sua attività artistica Prof. CARLA MANCINI Born in Perugia on the15th of September 1960 Since 1998 regular teacher of Lacquer, Gilding and Restoration Tecnique at Bernardino di Betto Institute of Art in Perugia RESTORER OF CULTURAL HERITAGE According to the following regulation ex art. 8, comma 11_sexies of the Law nr. 109/1994 regarding the identification of requirements for those performing restoration and manutention of chattels and decorated surfaces of architectural heritage. SCHOLAR OF EXCELLENCE Nomination on 9th March, 2003 by the Academy of Fine Arts Pietro Vannucci of Perugia, in acknowledgment of her artistic career BIOGRAFIA La mia formazione artistica deriva principalmente dall'ambiente familiare in cui nasco nel Settembre del 1960. Mio padre, ultimo di tre fratelli, eredi di una stirpe di artisti, decoratori e restauratori che opera nel campo dell'arte da almeno quattro secoli, mi insegna con naturalezza e garbo ad apprezzare il gusto del bello, dell'eleganza e dell'equilibrio attraverso gli oggetti, gli arredi e le opere che passano nel suo studio, nel centro di Perugia, dove svolge l'attività di antiquario, restauratore e collezionista. -

Saint Francis and the Sultan
www.malankaralibrary.com SAINT FRANCIS AND THE SULTAN www.malankaralibrary.com This page intentionally left blank www.malankaralibrary.com SAINT FRANCIS AND THE SULTAN THE CURIOUS HISTORY OF A CHRISTIAN-MUSLIM ENCOUNTER JOHN TOLAN 1 www.malankaralibrary.com 1 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © John Tolan 2009 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2009 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Tolan, John Victor, 1959– Saint Francis and the sultan: the curious history of a Christian-Muslim encounter/John Tolan. -
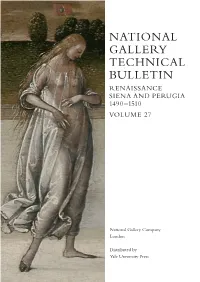
Working with Perugino: the Technique of an Annunciation Attributed to Giannicola Di Paolo
NATIONAL GALLERY TECHNICAL BULLETIN RENAISSANCE SIENA AND PERUGIA 1490–1510 VOLUME 27 National Gallery Company London Distributed by Yale University Press This volume of the Technical Bulletin has been funded by the American Friends of the National Gallery, London with a generous donation from Mrs Charles Wrightsman. ‘The Master of the Story of Griselda and Paintings for Sienese Palaces’ is published with the additional generous support of The Samuel H. Kress Foundation. Series editor Ashok Roy Photographic credits All photographs reproduced in this Bulletin are © The National Gallery, London, unless credited otherwise below. © National Gallery Company Limited 2006 BALTIMORE MD.Walters Art Gallery: p. 23, pl. 25; p. 51, pl. 70; p. All rights reserved. No part of this publication may be 53, pl. 74; p. 56, pl. 77. transmitted in any form or by any means, electronic or BLOOMINGTON IN. Indiana University mechanical, including photocopy, recording, or any Art Museum. Photo Michael Cavanagh and Kevin Montague: p. 22, information storage and retrieval system, without the pl. 23; p. 54, pls. 75, 76; p. 55, figs. 38, 39. BORDEAUX. Musée des prior permission in writing of the publisher. Beaux-Arts, photo Lysiane Gauthier: p. 106, pl. 9. BUDAPEST. Szépmüvészéti Muzeum. Photo: András Rázsó: p. 21, pl. 22; p. 57, pl. 2006 First published in Great Britain in by 78; p. 59, pl. 82. FANO. Chiesa di Santa Maria Nuova © 1997. Photo National Gallery Company Limited Scala, Florence: p. 102, pl. 5. FLORENCE. Galleria dell’ Accademia. St Vincent House, 30 Orange Street Courtesy of the Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, London wc2h 7hh Florence: p. -

Scarica L'elenco Delle Guide Turistiche Ed Escursionistiche
S P O L E TO GUIDE TURISTICHE/TOURIST GUIDES AGTU GUIDE IN UMBRIA srl Associazione Guide Turistiche dell’Umbria Via Favorita, 9 - Perugia Via Dono Doni, 18/B - Assisi Info e prenotazioni: Tel. 075 57 32 933 – 335 61 20 265 Tel. 075 81 52 28 Fax 075 57 37 898 www.assoguide.it - [email protected] [email protected] - www.guideinumbria.com ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI SISTEMA MUSEO Soc. Coop. ESCURSIONISTICHE Informazioni e prenotazioni per guide turistiche e interpreti, Coordinamento Umbria visite guidate e attività didattiche Tel./Fax 0743 46 434 - Tel. 345 26 18 814 Raffaele Capponi - Via Col Macerano, 4 06028 Sigillo (PG) [email protected] - www.sistemamuseo.it Mob. 335 12 51 250 - fax 075 92 20 799 [email protected] UMBRIA IN. ITINERE www.aigae.eu - www.umbriaguide.org Attività escursionistiche Via M. Quadrio, 17/a – Spoleto Tel./Fax 0743 46 518 – Mob. +39 338 58 10 869 [email protected] – www.umbriainitinere.com ***************** Elenco delle guide turistiche ed escursionistiche residenti nel comprensorio turistico di Spoleto, aggiornato alla data di stampa. L’elenco completo delle guide regionali autorizzate è consultabile sul sito www.umbriatourism.it/guide-e-accompagnatori o presso lo IAT di Spoleto. List of tourist and excursions guides living in the district of Spoleto, updated at the date of print. The complete list of licensed regional guides is available on www.umbriatourism.it/guide-e-accompagnatori or by the IAT – Spoleto Tourist Office. GUIDE TURISTICHE PROIETTI ANNALISA Tel. 338 38 05 503 - [email protected] TOURIST GUIDES Lingua: inglese ANGELI EBE ZAMPOLINI FEDERICA Tel.