La Frana Della Cresta Sud Del Rocciamelone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Giorgio Raineri I Progetti Di Case Unifamiliari Definiscono Una Vera E Propria Poetica Del Quotidiano
Firenze Architettura (1&2, 2020), pp. 134-141 ISSN 1826-0772 (print) | ISSN 2035-4444 (online) © The Author(s) 2020. This is an open access article distribuited under the terms of the Creative Commons License CC BY-SA 4.0 Firenze University Press DOI 10.13128/FiA-12236 - www.fupress.com/fa/ All’interno dell’opera di Giorgio Raineri i progetti di case unifamiliari definiscono una vera e propria poetica del quotidiano. In essi sguardo poetico e ragione compositiva, dispositiva e tecnica convergono delineando un universo domestico di una coraggiosa semplicità, nel quale sono riverberati i significati profondi dei gesti apparentemente ordinari e marginali della quotidianità. In Giorgio Raineri’s work, the projects for single-family houses determine an actual poetics of everydayness. In those projects a poetic gaze and a distributional, compositional and technical reason converge to design a courageously simple domestic universe, in which the deep meanings of apparently ordinary and marginal everyday gestures reverberate. Giorgio Raineri Case in Piemonte Houses in Piedmont Francesca Privitera Ora voglio quello stesso fiore Ora voglio quello stesso fiore Di frantumi di vetro Di frantumi di vetro Che fu benvenuto d’infanzia Che fu benvenuto d’infanzia In un corridoio domestico In un corridoio domestico Dove Dove Si tiravano a braccia le lenzuola […]1 Si tiravano a braccia le lenzuola […]1 Il tema della casa unifamiliare accompagna l’attività di Giorgio The theme of the single-family house accompanied Giorgio Raineri’s Raineri per un arco temporale di due decadi, dal 1951 al 1977. activities over the span of two decades, from 1951 to 1977. -

Comunicato Funghi 2017
FUNGHI 2017 Con il subentro dal 1° gennaio 2016 della Unione Montana valle Susa al posto della precedente Comunità Montana, cambiano i riferimenti per il versamento degli importi per la raccolta funghi anno 2017. Il pagamento può avvenire: 1. mediante bonifico bancario; i dati identificativi sono: Unione Montana Valle Susa Via Carlo Trattenero 15 1053 Bussoleno (TO) Servizio di Cassa e Tesoreria: conto n. 46024 IBAN: IT30J 03069 30180 1000000 46024 Causale: raccolta funghi anno 2017 2. mediante versamento sul conto corrente postale n. IT-93-L-07601-01000-00 1037819503 Intestato a: Unione Montana Valle Susa Servizio Tesoreria Causale: raccolta funghi anno 2017 Gli importi sono i seguenti: € 30,00 per il titolo di raccolta con validità annuale € 60,00 per il titolo di raccolta con validità biennale € 90,00 per il titolo di raccolta con validità triennale Il titolo di raccolta ha validità su tutto il territorio regionale Per i residenti nei Comuni dell’Unione (Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo) sono stati deliberati il 31 marzo 2016 dal Consiglio i seguenti importi ridotti: euro 20,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi annuale, euro 40,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi biennale euro 60,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi triennale Il titolo di raccolta ha validità solo sul territorio dei Comuni sopra elencati TRA TUTTI COLORO CHE EFFETTUARANNO UN VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI 2017 VERRANNO SORTEGGIATI, A FINE OTTOBRE 2017, TRE NOMINATIVI CUI SARA’ OFFERTA IN OMAGGIO UNA COPIA DEL VOLUME “TUTTO FUNGHI, CONOSCERLI, RACCOGLIERLI, CUCINARLI” . -

Strategia Per Le Valli Di Lanzo Strategia Nazionale Per Le Aree Interne
STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE LA MONTAGNA SI AVVICINA STRATEGIA PER LE VALLI DI LANZO SETTEMBRE 2020 strategia nazionale per le aree interne Strategia per le Valli di Lanzo Il passato recente e il futuro prossimo La realtà socioeconomica territoriale e le sue dinamiche evolvono rapidamente, spesso più rapidamente delle idee e delle strategie che ne sono a fondamento, sempre più velocemente della percezione che anche un osservatore attento riesce ad avere del mutamento stesso. Nel periodo intercorso tra l’approvazione della Bozza di Strategia (28 Settembre 2018) e la redazione della Strategia d’Area, di seguito presentata, il mondo nella sua globalità ha vissuto una delle fasi più drammatiche registrate negli ultimi decenni, ma nel contempo più propulsive, pur nella preoccupante contabilizzazione di dati econometrici negativi e della ancor più tragica registrazione dei decessi correlati alla pandemia di COVID 19. Il territorio dell’Area Interna delle Valli di Lanzo non solo non è stato esente dal diffuso fenomeno epidemiologico e dalle relative conseguenze dell’impatto negativo subito dalle famiglie, dalle imprese, dal tessuto sociale nel suo complesso e ancor più dal tessuto economico. Il territorio tutto ha registrato - forse si comincia ad averne contezza solo ora - nuove tendenze e mutamenti di ruoli, possibilità di azione e di abitudini più marcate rispetto ad altre aree montane, in quanto la realtà locale è strettamente correlata con il tessuto cittadino di Torino e di tutta l’area metropolitana torinese. In tal senso, le Valli di Lanzo nella loro accezione più ampia e il territorio della Città Metropolitana, sono da sempre caratterizzati da una forte correlazione con maggiori rapporti di biunivocità rispetto a quanto possa darne conto un primo sguardo: pendolarismo per lavoro e studio, flusso di merci da e verso le valli, fruizione turistica e frequentazione occasionale, seconde case e storicità di presenza, senso di appartenenza e di comunità. -

TOPONOMASTICA Nome Ufficiale Del Comune Usseglio Nome L.M
TOPONOMASTICA Nome ufficiale del comune Usseglio Nome L.M. (escolo dou pò) Nome L.M. (normalizzata) Useui Microtoponimo Nome ufficiale Non documentato Nome tradiz. L.M. (escolo dou pò) Nome tradiz. L.M. (normalizzata) la Bòiri Coordinate UTM GPS ED1950 32 T 359277 5011294 Quota in m CTR 1:10000 1620 Eventuale significato Cavità naturale o artificiale sfruttata dall’uomo Descrizione geografica Il microtoponimo indica una cavità mineralizzata, del tutto o in parte artificiale, che si apre nel versante destro del basso vallone di Servin (‘d Servìn) entro una fascia di calcescisti. La mineralizzazione consiste in una concentrazione di solfuri massivi di ferro-rame-zinco legata a processi esalativo- sedimentari, formatasi in contesto geologico di tipo ofiolitico; essa può essere stata sfruttata, in età per ora imprecisabile, per il rame o per la produzione di acido solforico (a partire dalla pirite). Poco più in alto (1626 m) è presente una seconda cavità più piccola, interamente artificiale (fori di barramina). Parte turistico - storico - Bòira, nelle sue diverse varianti (bòiri, bora, boùira, boùire, etnografica bouìri, bourì, bura), è termine ampiamente diffuso non solo in area francoprovenzale (valli di Susa, Cenischia, Ala, Orco e Soana, alta Dora Baltea), ma anche occitana (sino ai Pirenei catalani), con significato di ‘grotta, cavità anche artificiale, buca profonda su terreno piano o fra grossi blocchi rocciosi’. A Usseglio B. Terracini registra “boiri botro” senza precisare se intenda botro nel senso letterario di ‘fossato, valloncello scosceso soggetto a forte erosione’ o in quello archeologico di ‘pozzo per rifiuti, libagioni od offerte’. In val Soana boijra/boijro compare in atti notarili del 1679-1749 con significato di ‘taglio del terreno dovuto a cause naturali (frane del terreno morenico, affossamenti talora con piccolo lago) o artificiali (gallerie e scarichi di miniere)’. -

Elenco Stazioni
ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Livello pioggia 22-07-1993 STURA DI TO ALA DI STURA LANZO 250 ALA DI STURA 367642 5019242 1006 Temperatura dell'aria 22-07-1993 Altezza neve 08-09-1999 09-05-2005 Livello pioggia 08-09-1999 ANDRATE TO ANDRATE SESIA 346 PINALBA 413632 5046071 1580 Radiazione solare 04-05-2006 Temperatura dell'aria 08-09-1999 Livello pioggia 05-08-1999 TO ANGROGNA PELLICE 353 VACCERA 358034 4970850 1435 Temperatura dell'aria 05-08-1999 Direzione vento 18-08-2002 Livello pioggia 09-01-1991 AVIGLIANA DORA AVIGLIANA Radiazione TO RIPARIA 142 373774 4994834 340 solare 09-01-1991 Temperatura dell'aria 09-01-1991 Velocita' vento 18-08-2002 Livello pioggia 28-09-2006 STURA DI TO BALME LANZO S4101 BALME 360677 5018290 1410 Temperatura dell'aria 28-09-2006 Direzione vento 06-11-2002 Altezza neve 25-09-1987 STURA DI RIFUGIO TO BALME LANZO 004 GASTALDI 354502 5017939 2659 Livello pioggia 03-07-1996 Temperatura dell'aria 25-09-1987 Velocita' vento 06-11-2002 Direzione vento 09-07-2003 22-07-2010 Livello pioggia 10-10-2002 22-07-2010 BARDONECCHIA DORA BARDONECCHIA Radiazione TO RIPARIA S2895 MELEZET 317833 4990752 1791 solare 10-10-2002 22-07-2010 Temperatura dell'aria 10-10-2002 22-07-2010 Velocita' vento 09-07-2003 22-07-2010 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice -

Bumble Bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae)
Bulletin of Insectology 63 (1): 137-152, 2010 ISSN 1721-8861 Bumble bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae) Aulo MANINO, Augusto PATETTA, Giulia BOGLIETTI, Marco PORPORATO Di.Va.P.R.A. - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino, Grugliasco, Italy Abstract A survey of bumble bees (Bombus Latreille) of the Susa Valley was conducted at 124 locations between 340 and 3,130 m a.s.l. representative of the whole territory, which lies within the Cottian Central Alps, the Northern Cottian Alps, and the South-eastern Graian Alps. Altogether 1,102 specimens were collected and determined (180 queens, 227 males, and 695 workers) belonging to 30 species - two of which are represented by two subspecies - which account for 70% of those known in Italy, demonstrating the particular value of the area examined with regard to environmental quality and biodiversity. Bombus soroeensis (F.), Bombus me- somelas Gerstaecker, Bombus ruderarius (Mueller), Bombus monticola Smith, Bombus pratorum (L.), Bombus lucorum (L.), Bombus terrestris (L.), and Bombus lapidarius (L.) can be considered predominant, each one representing more than 5% of the collected specimens, 12 species are rather common (1-5% of specimens) and the remaining nine rare (less than 1%). A list of col- lected specimens with collection localities and dates is provided. To illustrate more clearly the altitudinal distribution of the dif- ferent species, the capture locations were grouped by altitude. 83.5% of the samples is also provided with data on the plant on which they were collected, comprising a total of 52 plant genera within 20 plant families. -

Pier Carlo BOCCA
Pier Carlo BOCCA - geologo - Nato a Villamiroglio (Al) l'8 febbraio 1945 Studio Tecnico - Via Circonvallazione 2 Sostegno (BI) C.so Regina Margherita 1bis Torino Laurea in geologia conseguita presso l'Università di Torino nel 1978. Iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 81 CURRICULUM PROFESSIONALE DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI a giugno 2015 Espletamento di incarichi professionali e collaborazioni nei seguenti ambiti geologico-applicativi. In grassetto i lavori eseguiti negli ultimi 10 anni Pianificazione territoriale. Progetti di Piano Regolatore Generale ai sensi della LR 56/77 e di valutazione di compatibilità idrogeologica degli strumenti urbanistici di P.R.G.C. ai fini del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). • Moncalieri, Vercelli, Usseglio, Sauze di Cesana, Ala di Stura, Brosso, San Ponso, Caluso, Candia C.se, Villareggia, Mazzè, Foglizzo, San Benigno C.se, Villamiroglio, Ronco Canavese, Castiglione Torinese, Roasio, Postua. • E' stato membro di Commissione Igienico Edilizia nei seguenti Comuni: Roasio, Caravino, Strambino, Sauze di Cesana, Mercenasco, Caluso, Castiglione Torinese, Forno Canavese. Attualmente: Sostegno, Ailoche, San Benigno Canavese, Mazzè. Pianificazione Territoriale. Indagini specialistiche per la definizione del quadro del dissesto idrogeologico a supporto dei progetti di PRGC. Studi di pianificazione in ambito territoriale vasto. • Provincia di Torino. Dipartimento Territorio e Difesa del Suolo. In collaborazione con SIGEA s.r.l. Studio idrologico, geomorfologico ed idraulico dei rii minori nei comuni di Alpignano, Pianezza, Druento, Caselette e San Gillio quale strumento di indagine ai fini della pianificazione territoriale e della prevenzione idrogeologica. • Provincia di Torino- Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Torino (API). Progetto di rilocalizzazione delle aree industriali a rischio idrogeologico del raggruppamento dei comuni del Canavese e Pinerolese (182 comuni). -

Cave E Miniere Attive Della Provincia Di TORINO (In Giallo Sono Evidenziate Le Attività Estrattive Con Autorizzazione Scaduta Da Meno Di 3 Anni)
Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere Cave e miniere attive della provincia di TORINO (in giallo sono evidenziate le attività estrattive con autorizzazione scaduta da meno di 3 anni) COMUNE LOCALITA' LITOTIPO IMPRESA CODICE ALPETTE BISDONIO DETRITO DI FALDA C.E.V.I.G. SRL V0007T ALPETTE CASE BISDONIO GNEISS TIBOLDO GRANITI S.R.L. G0265T BORGOFRANCO D'IVREA RIO SAN GERMANO-PESCATORI MATERIALE ALLUVIONALE COGEIS SPA M1921T CAMBIANO CASCINA TALPONE ARGILLA FORNACE LATERIZI CARENA S.R.L. A0090T CAPRIE TRUC LE MURA SERPENTINA ING. VITO ROTUNNO S.R.L. S0003T CARAVINO Grivellino MATERIALE MORENICO IVIES SPA O0003T UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE CARIGNANO CERETTO MATERIALE ALLUVIONALE M0040T UNICAL S.P.A. UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE CARIGNANO CERETTO MATERIALE ALLUVIONALE M0040T UNICAL S.P.A. CARIGNANO GERMAIRE MATERIALE ALLUVIONALE CAVE GERMAIRE S.P.A. M0047T CARIGNANO GERMAIRE MATERIALE ALLUVIONALE CAVE GERMAIRE S.P.A. M0047T UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE CARIGNANO LA GORRA 2 MATERIALE ALLUVIONALE M0757T UNICAL S.P.A. CARIGNANO MADONNA DEGLI OLMI MATERIALE ALLUVIONALE CAVA DEGLI OLMI S.R.L. M0043T CARIGNANO MADONNA DEGLI OLMI MATERIALE ALLUVIONALE CAVA DEGLI OLMI S.R.L. M0043T CARIGNANO Po Morto - Tetti Faule MATERIALE ALLUVIONALE CALCESTRUZZI S.P.A. M0049T CARIGNANO PROVANA MATERIALE ALLUVIONALE CAVE PROVANA - S.P.A. M0042T CARIGNANO PROVANA MATERIALE ALLUVIONALE CAVE PROVANA - S.P.A. M0042T CARIGNANO PROVANA MATERIALE ALLUVIONALE CAVE PROVANA - S.P.A. M0042T CARIGNANO S. MICHELE MATERIALE ALLUVIONALE CALCESTRUZZI S.P.A. M0048T CARIGNANO S. MICHELE MATERIALE ALLUVIONALE CALCESTRUZZI S.P.A. M0048T CASELETTE C.na Baldon MATERIALE ALLUVIONALE GEOSERVIZI srl M1837T CASELETTE C.na La Grangetta MATERIALE ALLUVIONALE ALLARA S.P.A. -

Strategia Valli Di Lanzo La Montagna Si Avvicina
strategia nazionale per le aree interne Strategia per le Valli di Lanzo Il passato recente e il futuro prossimo STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE La realtà socioeconomica territoriale e le sue dinamiche evolvono rapidamente, spesso più rapidamente delle idee e delle strategie che ne sono a fondamento, sempre più velocemente della percezione che anche un osservatore aento riesce ad avere del mutamento stesso. Nel periodo intercorso tra l’approvazione della Bozza di Strategia 28 Seembre 2018) e la redazione della Strategia d’Area, di seguito presentata, il mondo nella sua globalit ha vissuto una delle fasi pi dramma'che registrate negli ul'mi decenni, ma nel contempo pi propulsive, pur nella preoccupante contabilizzazione di da' econometrici nega'vi e della ancor pi tragica registrazione dei decessi correla' alla pandemia di COVI, 19. Il territorio dell’Area Interna delle Valli di Lanzo non solo non . stato esente dal di/uso fenomeno epidemiologico e dalle rela've conseguenze dell’impao nega'vo subito dalle famiglie, dalle imprese, dal tessuto sociale nel suo complesso e ancor pi dal tessuto economico. Il territorio tuo ha registrato 0 forse si comincia ad averne contezza solo ora 0 nuove tendenze e mutamen' di ruoli, possibilit di azione e di abitudini pi marcate rispeo ad altre aree montane, in 1uanto la realt locale . streamente correlata con il tessuto ciadino di 2orino e di tua l’area metropolitana torinese. In tal senso, le Valli di Lanzo nella loro accezione pi ampia e il territorio della Ci 3etropolitana, sono da sempre caraerizza' da una forte correlazione con maggiori rappor' di biunivocit rispeo a 1uanto possa darne conto un primo sguardo4 pendolarismo per lavoro e studio, 5usso di merci da e verso le valli, fruizione turis'ca e fre1uentazione occasionale, seconde case e storicit di presenza, senso di appartenenza e di comunit . -

TESTO COORDINATO DELL'allegato a ALLA DCR N. 563-13414 Del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANIST
TESTO COORDINATO DELL’ALLEGATO A ALLA DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31.3.1998 114/98” COME MODIFICATO DALLA DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 E DALLA DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 ELENCO COMUNI MINORI PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO, BUROLO, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOGLIZZO, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI -

It1110039 – Rocciamelone
NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTE COMUNE ITALO FRANCESE - TRATTA IN TERRITORIO ITALIANO CUP C11J05000030001 PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI VEGETAZIONE FLORA FAUNA ECOSISTEMI CENSIMENTO ED INDIVIDUAZIONE SORGENTI - NOTA TECNICA (Commissione VIA – Richiesta N. 15a) Indice Date / Data Modifications / Modifiche Etabli par / Concepito da Vérifié par / Controllato da Autorisé par / Autorizzato da BERNARDI GARAVOGLIA CHANTRON 0 15/12/2010 PRIMA EMISSIONE (TECNIMONT) OGNIBENE MANCARELLA N° P P 2 C 3 0 T S 3 1 1 5 1 0 P A N O T Doc Phase / Fase Sigle étude / Sigla Émetteur / Emittente Numero Indice Statut / Stato Type / Tipo ADRESSE GED / C3C // // 55 01 15 10 01 INDIRIZZO GED ECHELLE / SCALA - LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 F-73006 CHAMBERY CEDEX (France) Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.59 RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952 Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3 BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANTA-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA SOMMAIRE – INDICE 1 PREMESSA 3 2 METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE SVOLTA 3 SIC IT1110039 – ROCCIAMELONE 8 SIC IT1110030 – OASI XEROTERMICHE DELLA VAL DI SUSA - ORRIDO DI CHIANOCCO 10 SIC/ZPS IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRÈ 12 SIC IT1110027 – BOSCAGLIE DI TASSO DI GIAGLIONE 13 SIC IT1110055 – ARNODERA - COLLE MONTABONE 14 3 CONCLUSIONI 15 4 ALLEGATI 16 ALLEGATO 1 - SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI RICADENTI NEI SIC. 16 C30_1151-55-01-15-10-01_0_Flora -
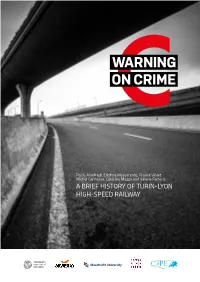
A Brief History of Turin-Lyon High-Speed Railway 2
1 Paola Manfredi, Cristina Massarente, Franck Violet, Michel Cannarsa, Caterina Mazza and Valeria Ferraris A BRIEF HISTORY OF TURIN-LYON HIGH-SPEED RAILWAY 2 Paola Manfredi, Cristina Massarente, Franck Violet, Michel Cannarsa, Caterina Mazza and Valeria Ferraris1 A brief history of Turin-Lyon high-speed railway Table of Content 1. Introduction 2. The origin of the project and the stakeholders involved 3. The history of the project 4. Criminal infiltration and high-speed railway in the media 5. References 1. Introduction The history of the project of the New Railway Line Turin-Lyon, shortened as NLTL and currently known as high-speed train Turin- Lyon (named TAV Turin-Lyon), saw a lot of stakeholders that interacted, exchanged, conflicted and overlapped. The first part of this paper aims at understanding the evolution/origin of the project in order to clarify the role of the Italian and French stakeholders involved. Then, the paper continues with the description of the main steps of the history of TAV project. In these steps will be underlined the moments in which some stakeholders have been involved in incidents of lawlessness and corruption. 2. The origin of the project and stakeholders involved 2.1 The Italian stakeholders The project for the TAV Turin-Lyon involved many Italian stakeholders, institutional and not. First of all in 1989 the Associazione Tecnocity2 presented in a public meeting at the Fondazione Agnelli the project of a high-speed railway line for passengers between France and Italy. The project foresees the construction of a transalpine tunnel 50 km long as a part of the future railway line between East and West Europe (Number Five Corridor3).