Migranti Africani Di Castel Volturno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
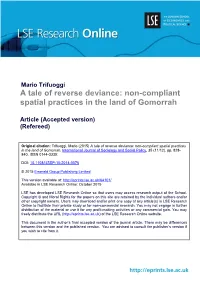
A Tale of Reverse Deviance: Non-Compliant Spatial Practices in the Land of Gomorrah
Mario Trifuoggi A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Trifuoggi, Mario (2015) A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah. International Journal of Sociology and Social Policy, 35 (11/12). pp. 828- 840. ISSN 0144-333X DOI: 10.1108/IJSSP-10-2014-0076 © 2015 Emerald Group Publishing Limited This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/64101/ Available in LSE Research Online: October 2015 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. A TALE OF REVERSE DEVIANCE: NON-COMPLIANT SPATIAL PRACTICES IN THE LAND OF GOMORRAH Mario Trifuoggi [email protected] Abstract Racketeering local activities, though less relevant in terms of financial turnover, still represents a distinctive feature of mafia-like organisations for it provides them with striking social power. -

Litorale Domizio Con Grattacieli E Funivie Masterplan Di Sogni Per Una Terra Desolata
anno XVIII n.1 14 novembre 2018 Periodico della Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretto da Marco Demarco Reportage Gli inviati di Inchiostro da Ischitella a Sessa Aurunca. L’emergenza immigrazione, i progetti e le oasi verdi Litorale domizio con grattacieli e funivie Masterplan di sogni per una terra desolata. Sarà firmato dall’archistar Andreas Kipar L’EDITORIALE Il litorale della vergogna in un polo di attrazione turi- Il cinema stica. La riviera romagnola del Sud. È l’intenzione del La storia Dopo i registi governatore Vincenzo De Luca. Il lungo declino La grande ascesa Per questo motivo, la Regione ha presentato un Master- gli architetti plan di riqualificazione della costa domizio-flegrea. del litorale del set d’autore Tra i progetti presentati, uno particolarmente ambizio- Marco Demarco Una storia lunga oltre duemila Castel Volturno è diventata so: quello del Comune di Mondragone. ome Norma Desmond in anni: da centro termale di epo- la nuova frontiera del cine- Il piano è trasformare l’ex Idac Food da gigantesco eco- Viale del tramonto anche il ca romana a terra di camorra, ma impegnato. Con il profes- mostro ad albergo di lusso, con tanto di funivia diretta C litorale domizio sogna i bei cementificazione e immigra- sor Lando, una panoramica al porto. tempi di una volta, quando dai zione incontrollata. sull’importanza di questo set. Campi Flegrei al Garigliano era Messina e Damato a pagg. 2-3 Sorice a pag. 4 Iadanza a pag. 12 tutto un susseguirsi di spiagge, pi- nete e stabilimenti balneari. Al tempo delle prime Cinquecen- to e dei mangiadischi, la festa si ce- lebrava nei picnic del fine settima- na. -

Caserta and Matese
Generale_INGL 25-03-2008 13:28 Pagina 122 Caserta and Matese 122 123 This is the area referred to as “Campania Felix ” by ancient populations due to its privileged position i and the fertility of its soil. Irrigated by the Volturno and favoured by a mild climate, the province extends from the sea to the Apennines, alternating between lush vegetation and places of great historic and cultural interest. The vast plains of the Caserta area Ente Provinciale per il open onto the sea and host one of the most famous Turismo di Caserta and widely visited monuments of the Region: the Palazzo Reale Royal Palace (Reggia) of Caserta. tel. 0823 321137 www.eptcaserta.it Santa Maria Capua Vetere, Capua and Sessa Aurunca, are also of historic and archaeological Ente Parco del Matese interest, all concentrated in the area of Caserta via Sannitica known as Terra di Lavoro. The Domitian shore is Piedimonte Matese the province’s coastline, an area rich with pine tel. 0823 917232 stands, wide sandy beaches and famous bathing Comunità Montana establishments. Monte Santa Croce Inland, the massif of Matese offers marvellous via Roma 30 uncontaminated nature and villages where art and Roccamonfina popular traditions are still strongly felt; one of the tel. 0823 921276 least contaminated areas of Italy. Calvi Vecchia Scavi archeologici di Cales strada statale Casilina tel. 0823 652533 Capua Museo Provinciale Campano via Roma 68 tel. 0823 961402 Santa Maria Capua Vetere Museo Archeologico dell’antica Capua via Roberto d’Angiò 48 tel. 0823 844206 Caserta Reggia e Parco via Douhet 22 tel. -

Immigrant and Urban Re-Generation
ISSN 2411-9563 (Print) European Journal of Social Sciences Sep. Dec. 2017 ISSN 2312-8429 (Online) Education and Research Vol.11 Nr. 2 Immigrant and Urban Re-Generation Bianca Petrella Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, DICDEA – Dip. di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente Claudia de Biase Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, DADI – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Abstract This study has started from the knowledge of the juridical-normative frame regulating the foreigners’ social rights in EU and in Italy and from the reading of directives, programs and documents produced from the EU and from the Region Campania. After this, the study has moved toward the tab of around fifty national and international case studies related to the activity of inclusion and of integration of the immigrated ones. From the comparative reading of the case studies, some immediately transferable strengths have been individualized. Then, we compared the cases studies with the European, Italian and regional Program; the next step has been the examination of the weight of the population immigrated in Italy and in the Region Campania and of its burden in the variation and formation of the real estate. In this way we have had useful "suggestions" for the elaboration of Urban Plans able to support the construction of the inter-cultural city and urban community (Consiglio d’Europa, 2003). In fact, in conclusion, the paper proposes an urban design in the city of Castel Volturno, which is one of four municipalities, along with Mondragone, Sessa Aurunca and Cellole, that belongs to the Domitian coast (Caserta). -

Stories of Revenge in Italian Popular Culture. a Narrative Study of Vigilante Films Ferdinando Spina*
Stories of Revenge in Italian Popular Culture. A Narrative Study of Vigilante Films Ferdinando Spina* Author information * Department of History, Society and Human Studies, University of Salento, Italy. Email: ferdinando. [email protected] Article first published online July 2019 HOW TO CITE Spina, F. (2019). Stories of Revenge in Italian Popular Culture. A Narrative Study of Vigilante Films. Italian Journal of Sociology of Education, 11(2), 218-252. doi: 10.14658/pupj-ijse-2019-2-11 VA ADO UP P Stories of Revenge in Italian Popular Culture. A Narrative Study of Vigilante Films Ferdinando Spina* Abstract: In recent years, we have witnessed, particularly in Italy, a growing support for the “self-defence” argument and the vigilante justice. This troubling phenomenon requires further empirical and theoretical attention to determine why and how media manage to draw the interest of the public when they tackle revenge and private justice topics. The objective of this paper is to explore narratives of private revenge in popular culture, specifically in Italian cinema. The first section introduces some reflections on the relations between narrative and criminology and the interest of cinema in revenge tales. Then follows a reconstruction of the historical evolution and narrative structures of both American and Italian vigilante films. Finally, a detailed analysis is presented of a representative sample of Italian films of the genre, highlighting the narrative structures and main themes, as well as the similarities and differences with respect to the American models. Keywords: private justice, vigilantism, narrative, popular criminology, vigilante film * Department of History, Society and Human Studies, University of Salento, Italy. -

“Monitoring of Mediterranean Coastal Areas. Problems and Measurement
DOMITIAN COAST. REHABILITATION’ OUTLOOKS OF THE NORTHERN COAST OF CAMPANIA Giuseppe Mazzeo CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo, Via Guglielmo Sanfelice, 8, 80134, Naples (Italy), phone +39 081 7682315, e-mail: [email protected] Abstract – Object of the paper is the Domitian Coast, an area belonging to the North-West of Campania Region, characterized by a series of contrasting factors. The fertility of the soil and the considerable length of an easily accessible and available coastline are threatened by an indiscriminate exploitation of the ground for anthropogenic uses. The uncontrolled expansion of urbanized areas and the reckless use of soil have transformed a potentially rich land into an example of a kind of management that is completely indifferent to the territorial risks. This state of affairs puts the brakes on any kind of developmental action. Policies tending to the redevelopment of urban centres and to the regeneration of natural and agricultural sites are focusing on this area. In fact, there is no lack of territorial planning and programming tools, despite the poor results. Therefore, it is not possible at the moment to forecast or, in any case, to hypothesise a future improvement of the situation. The first part of the paper analyses the Domitian territory and the issues characterizing this particular area on the basis of three categories of elements. Starting from the problems encountered, the second part indicates the possible intervention policies set up to redevelop this territory. Introduction The Domitian coastal strip in the Campania Region extends for about 52 kilometres from the estuary of the Garigliano, at the border of the Lazio Region, to the Municipality of Bacoli, in the Phlegrean Fields. -

Camera Dei Deputati Senato Della Repubblica
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XI LEGISLATURA Doc. XXIII n. 12 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI (istituita con decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356) (composta dai deputati: Violante, Presidente; Sorice, Segretario; Tri• podi, Segretario; Abbate, Acciaro, Angelini Piero Mario, Ayala, Bargone, Biondi, Borghezio, Buttitta, Cafarelli, D'Amato, Fausti, Ferrauto, Folena, Galasso Alfredo, Grasso, Imposimato, Leccese, Mastella, Matteoli, Olivo, Ricciuti, Rossi Luigi, Taradash; e dai senatori: Cabras, Vice Presi• dente; Calvi, Vice Presidente; Biscardi, Boso, Brutti, Butini, Cappuzzo, Casoli, Covello, Crocetta, D'Amelio, De Matteo, Ferrara Salute, Fiorino, Frasca, Garofalo, Gibertoni, Guerritore, Marchetti, Montini, Ranieri, Ra- pisarda, Robot, Smuraglia, Zuffa) RELAZIONE SULLA CAMORRA (Relatore: onorevole Luciano VIOLANTE) approvata dalla Commissione il 21 dicembre 1993 Presentata alle Presidenze il 15 febbraio 1994 ai sensi dell'articolo 25-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica XI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Signor Presidente, Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 25 quinquies, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la relazione sulla camorra, approvata da questa Commissione nella seduta del 21 dicembre 1993. Con molti cordiali saluti (Luciano Violante) On. Dott. Giorgio NAPOLITANO Presidente della Camera dei Deputati PS/mp Camera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Roma, -*íT /¿ A ^ Prot. -

The Case of Castel Volturno, in Campania Region, Italy
sustainability Article Immigration and the Housing Market: The Case of Castel Volturno, in Campania Region, Italy Fabiana Forte 1, Valentina Antoniucci 2,* ID and Pierfrancesco De Paola 3 ID 1 Department of Architecture and Industrial Design, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Via S. Lorenzo ad Septimum, 81031 Aversa, Italy; [email protected] 2 Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Padova, Via Venezia 1, 35131 Padova, Italy 3 Department of Industrial Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio 80, 80125 Napoli, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 16 December 2017; Accepted: 26 January 2018; Published: 29 January 2018 Abstract: According to Eurostat, Italy is the fifth country of the European Union per immigrant population. The complexity of the phenomenon, as it has evolved in recent years, leads to analyzing it from a specific point of view, that of the real estate market. The article represents the early stage of research on the housing condition of the immigrant population in the Southern Italy and its effect on the housing market. First, we describe the spatial segregation phenomenon affecting the immigrant population in Campania Region; then we analyze data of the municipality of Castel Volturno, which has one of the greater migratory pressure throughout the whole region. We provide statistical regressions correlating housing prices and socio-economic features from 2006 to 2016. The results confirm the findings of the current literature on the subject: there is a specific phenomenon associated with the presence of an immigrant population residing in conjunction with a reduction of housing prices. -

Monitoraggio Integrato Di Un'area Marino- Costiera: La Foce Del Fiume Volturno (Mar Tirreno Centrale)
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320519461 Monitoraggio integrato di un'area marino- costiera: la foce del fiume Volturno (Mar Tirreno centrale) Technical Report · October 2017 CITATIONS READS 0 107 29 authors, including: Luciana Ferraro Laura Giordano Italian National Research Council Italian National Research Council 94 PUBLICATIONS 719 CITATIONS 34 PUBLICATIONS 72 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Sergio Bonomo Antonio Cascella Italian National Research Council National Institute of Geophysics and Volcano… 68 PUBLICATIONS 513 CITATIONS 60 PUBLICATIONS 591 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Preservation, restoration, rehabilitation of historical structures View project MedSudMed View project All content following this page was uploaded by Luciana Ferraro on 20 October 2017. The user has requested enhancement of the downloaded file. ISSN 1590-2595 Anno 2017_Numero 146 Monitoraggio integrato di un’area marino-costiera: la foce del fiume Volturno (Mar Tirreno centrale) Quaderni di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Quaderni di Direttore Responsabile Silvia MATTONI Editorial Board Luigi CUCCI - Editor in Chief (INGV-RM1) Raffaele AZZARO (INGV-CT) Mario CASTELLANO (INGV-NA) Viviana CASTELLI (INGV-BO) Rosa Anna CORSARO (INGV-CT) Mauro DI VITO (INGV-NA) Marcello LIOTTA (INGV-PA) Mario MATTIA (INGV-CT) Milena MORETTI (INGV-CNT) Nicola PAGLIUCA (INGV-RM1) Umberto SCIACCA (INGV-RM2) -
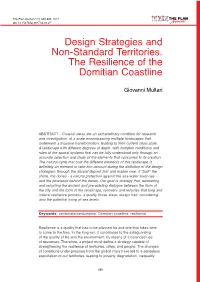
Design Strategies and Non-Standard Territories. the Resilience of the Domitian Coastline
The Plan Journal 2 (2): 669-683, 2017 doi: 10.15274/tpj.2017.02.02.07 Design Strategies and Non-Standard Territories. The Resilience of the Domitian Coastline Giovanni Multari ABSTRACT - Coastal areas are an extraordinary condition for research and investigation, at a scale encompassing multiple landscapes that underwent a massive transformation, leading to their current crisis state. A landscape with different degrees of depth, with complex conditions and rules of the spatial systems that can be fully understood only through an accurate selection and study of the elements that concurred to its creation. The natural cycle that built the different elements of this landscape is definitely an element to take into account during the definition of the design strategies: through the alluvial deposit first and marine next, it “built” the shore, the dunes - a natural protection against the sea-water level rise - and the pinewood behind the dunes. Our goal is strategy that, recovering and recycling the ancient and pre-existing dialogue between the form of the city and the form of the landscape, recovers and recycles that long and natural resilience process: a quality those areas always had, considering also the potential rising of sea levels. Keywords: centuriatio/centuriation, Domitian coastline, resilience Resilience is a quality that has to be planned for and one that takes time to come to the fore. In the long run, it contributes to the safeguarding of the quality of life and the environment, by means of a balanced use of resources. Therefore, a project must define a strategy capable of strengthening the resilience of territories, cities, and people. -

Ritual Activism and the Contestation Over Urban Space in the Everyday”
“Ritual activism and the contestation over urban space in the everyday” Nicholas DeMaria Harney* © by the author(s) (*) Prof. Nicholas DeMaria Harney School of Social Sciences M257, Cassamarca Foundation The University of Western Australia | 35 Stirling Highway, CRAWLEY WA 6009, Australia; ph: +61 8 64882831; Email: [email protected] Paper presented at the RC21 International Conference on “The Ideal City: between myth and reality. Representations, policies, contradictions and challenges for tomorrow's urban life” Urbino (Italy) 27-29 August 2015. http://www.rc21.org/en/conferences/urbino2015/ Nicholas DeMaria Harney RC21: The Ideal City: between myth and reality Session E5: Immigrants and the domesticization of public spaces in Europe Friday, August 28, 2015, 17:00-1900, Room C5, Urbino, Italy Title: Ritual activism and the contestation over urban space in the everyday1 Abstract: Naples, Italy offers a complex site for exploring the political agency of migrants in the making of ‘home’ in public spaces. Corruption, crime, exclusion, precarity and insecurity structure, in real and imagined ways, the everyday lives of migrants in southern Italy’s largest city. In this paper, I explore what it is to be political in place - making for the migrants I encountered in Naples over the last decade 2004-2013 and the challenges they encountered in negotiating place in the city. This paper argues that the importance of migrant politics can better be understood through what I call their ritual activism. Drawing on anthropological engagements with ritual action, the everyday (Das) and the Deleuzian concept of habit, I explore migrant place-making in Naples. -

Atti Associazione Italiana Di Oceanologia E Limnologia
ATTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI OCEANOLOGIA E LIMNOLOGIA Proceedings of the Italian Association of Oceanology and Limnology Volume 17 Genova 2004 Responsabile della Pubblicazione / Editor in Chief Mauro PICCAZZO Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova Vice-Responsabile della Pubblicazione / Associate Editor Carlo Nike BIANCHI Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova Comitato di Redazione / Editorial Board Giancarlo ALBERTELLI Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova Riccardo DE BERNARDI Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, CNR, Verbania Pallanza Roberto FRACHE Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Genova Vincenzo SAGGIOMO Stazione Zoologia “A. Dohrn”, Napoli Giancarlo SPEZIE Istituto di Meteorologia e Oceanografia, Università di Napoli Parthenope Consulenti Editoriali / Editorial Assistants Antonio ARTEGIANI, Ancona Lucien LAUBIER, Marseille Roberto BERTONI, Pallanza Cristophe LEBOULANGER, Thonon les Bains Giorgio BUDILLON, Napoli Fiorenza MARGARITORA, Roma Cristiana CALLIERI, Pallanza Giuseppe MORABITO, Pallanza Jordi CATALAN, Barcelona Carla MORRI, Genova Riccardo CATTANEO-VIETTI, Genova Jean-François PAVILLON, Paris Paul R. DANDO, Bangor Joandomènec ROS, Barcelona Roberto DANOVARO, Ancona Alan J. SOUTHWARD, Plimouth Manos DASSENAKIS, Athens Sergio TUCCI, Genova Marco FIRPO, Genova Leonardo TUNESI, Roma Joern GEISTER, Bern Adolf WEBER, Hamburg Josep-Maria GILI, Barcelona Karl WITTMAN, Wien Karl-J. HESSE, Kiel Adriana ZINGONE, Napoli L’Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (AIOL) è un’associazione scientifica indipendente formata da ricercatori interessati allo studio di tutti gli ambienti acquatici, sia marini sia continentali, ed ha lo scopo di facilitare lo scambio culturale sia tra i membri sia nei confronti del resto della comunità scientifica.