James Guillaume L'internazionale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
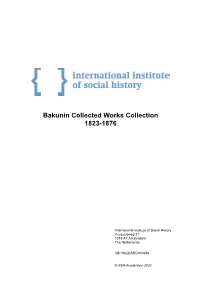
Bakunin Collected Works Collection 1823-1876
Bakunin Collected Works Collection 1823-1876 International Institute of Social History Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam The Netherlands hdl:10622/ARCH04384 © IISH Amsterdam 2020 Bakunin Collected Works Collection 1823-1876 Table of contents Bakunin Collected Works Collection..................................................................................................3 Context............................................................................................................................................... 3 Content and Structure........................................................................................................................3 Access and Use.................................................................................................................................4 Allied Material.....................................................................................................................................5 Inventaire............................................................................................................................................5 Lettres: correspondance à caractère personnel.......................................................................... 5 Ecrits: articles, brochures, livres, lettres ouvertes et discours...................................................90 Divers: textes personnels et documents administratifs, notes sur la philosophie et l'histoire, documents isolés......................................................................................................................120 -

F O Gli 39 /2018
Fogli Biblioteca Salita dei Frati di Lugano Rivista dell’Associazione Contributi Giancarlo Reggi, La “Summa naturalium” di Paolo Veneto in un codice della Biblioteca cantonale di Lugano [p. 1] / Marco Sampietro, “Nel Canton Ticino” di Ermanno Monteferri. Un raro taccuino di viaggio del 1878 [p. 27] / Vito Calabretta, Alcune considerazioni 3 9 / 2018 compilative sul lavoro di Giulia Napoleone nel XX secolo [p. 37] / Per Giovanni Pozzi Giovanni Pozzi, Varie fortune del libro italiano in Svizzera [p. 43] / Rara et curiosa Laura Luraschi Barro, Due dubbie edizioni Agnelli di Lugano: gli “Elementi della pronunzia e dell’ortografia” e gli “Elementi della calligrafia” di Francesco Soave [p. 55] / In biblioteca Luciana Pedroia, Il 2017 in biblioteca [p. 66] / Fernando Lepori, Bibbia e letteratura [p. 80] / Alessandro Soldini, L’attività espositiva nel porticato della biblioteca [p. 85] / Cronaca sociale Relazione del Comitato [p. 91] / Conti [p. 95] / Nuove accessioni Pubblicazioni entrate in biblioteca nel 2017 [p. 98] Fogli Progetto grafico Rivista dell’Associazione Marco Zürcher Biblioteca Salita dei studio ccrz, Balerna Frati di Lugano. Esce di www.ccrz.ch regola una volta all’anno; Impaginazione ogni fascicolo costa Andrea Novali 7 franchi; ai membri dell’Associazione è Stampa e confezione inviato gratuitamente. Progetto Stampa, Chiasso È consultabile sul sito della Carte biblioteca Kaskad Wasserblau 160 g/m2 ISSN Munken Lynx, Edizione stampata: 80 g/m2 2235-4697 Tiratura Edizione online: 1’000 copie 2235-5189 In copertina Redazione Elaborazione -
Bakunin E L'internazionale in Italia
Max Nettlau Bakunin e l'Internazionale in Italia www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Web design, Editoria, Multimedia (pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!) http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Bakunin e l'Internazionale in Italia AUTORE: Nettlau, Max TRADUTTORE: Flores, Paolo – Frigerio, Carlo CURATORE: NOTE: CODICE ISBN E-BOOK: n. d. DIRITTI D’AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/online/opere/libri/licenze/ TRATTO DA: Bakunin e l'Internazionale in Italia : dal 1864 al 1872 / Max Nettlau ; con prefazione di Errico Malatesta. - Ginevra : Edizione del Risveglio, 1928. - XXXI, 397 p. ; 22 cm. CODICE ISBN FONTE: n. d. 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 15 luglio 2015 INDICE DI AFFIDABILITA’: 1 0: affidabilità bassa 2 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima DIGITALIZZAZIONE: Paolo Alberti, [email protected] REVISIONE: Paolo Oliva, [email protected] IMPAGINAZIONE: Paolo Alberti, [email protected] PUBBLICAZIONE: Catia Righi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. -

James Guillaume L'internazionale
James Guillaume vai all’indice L’INTERNAZIONALE documenti e ricordi (1864 -1878) QUARTO TOMO edizioni del Centro Studi Libertari Camillo Di Sciullo Chieti 2004 Titolo originale: L’Internationale. Documents et souvenirs (1864-1878) Traduzione di Andrea Chersi La riproduzione totale o parziale è permessa a tutti sotto la condizione della fedeltà al testo e della indicazione della fonte C.S.L. Di Sciullo casella postale 86 66100 Chieti James Guillaume L’INTERNAZIONALE documenti e ricordi (1864-1878) QUARTO TOMO Centro Studi Libertari Camillo Di Sciullo Adhémar Schwitzguébel PREFAZIONE Potrei forse pubblicare quest’ultimo tomo di “Documen- ti e Ricordi” senza farlo precedere da qualche riga? Degli amici mi hanno domandato se non sia il caso di tirare a que- sto punto una conclusione di questi quattro volumi, di tenta- re di riassumere la filosofia di quanto ho riferito. A questi amici ho risposto: no. Il carattere di una pubblicazione come la presente è proprio quello di non aver nulla di sistematico: sta al lettore formarsi da sé un’opinione. Inoltre, il termine stesso di conclusione mi pare esprima una falsa idea. Nulla si conclude né si completa; tutto continua, ricomincia trasfor- mandosi. L’evoluzione è costantemente in marcia, la vita è immortale. Engels aveva scritto a Sorge, nel settembre 1874: “Con il tuo ritiro la vecchia Internazionale è del tutto finita ed ha cessato di esistere”. Questo voleva semplicemente dire che la cricca marxista era alla deriva. Per ricuperare l’influenza perduta, Engels e Marx progettarono di favorire la costitu- zione di partiti socialisti nazionali, destinati a prendere il posto delle federazioni dell’Internazionale. -

Il Romagnolo
RENATO ZANGHERI ( IL ROIÀAGNOLO,, (1868.1874): UN GIORNALE RAVENNATE DAL MAZZINIANESIMO AL SOCIALISMO Uscito a Ravenna, con varie interruzioni, dal z6 settembre 1868 al 4 aprile 1874 in 164 numeri (t), u Il Romagnolo u è fra i giornali che meglio documentano da noi la cisi degli uomini e delle formazioni politiche dd Risorgimento e il passaggio, incerto e contradditorio, come allora non poteva non essere, ai nuovi ideali socialisti. Al < Romagnolo > hanno fatto cenno diversi scrittori di cose socialiste, dal Malon all'Angiolini al Nettlau al Gr-rillaume. Solo il Rosselli I'ha però citato difiusamente, nel suo noto lavoro sulla storia del movimento operaio italiano (z), soprattutto per quanto riguarda il periodo della più vivace polemica antimazziniàna e filocomunarda, ma in via esemplificativa e dall'esterno, sicchè non si può dire che esista un'idea precisa di ciò che n I1 Romagnolo > sia stato, propriamente, dei suoi svolgimenti e riferimenti concreti. Le Provincie della Romagna straziate da una stampa male intenzionata e più-spesso male informata, rese zimbello di una ignoiante e.palrrosa con- sorteria, malmenate da un inconsulto reggimento governativó, ebbero la disgrazia di vedere la Pubblica Opinione delle altre Provincie italiane fuor, viata per guisa da voler rendere solidale tutta una popolazione di alcuni (r) Furono pure pubblicati alcuni supplementi. La copia conservata presso la Biblioteca Classense di Ravenna, da me consultatà, è mancante di 8 numeri. Figurano responsabili Giovanni Resta, dall'inizio al 3 settem. bre r87r, Lodovico Nabruzzi, di qui al z9 ottobre r87t, e Giuséppe San- t'Andrea, negli ultimi mesi. Il giornale, settimanale, venne stampato nella tipografia Alighieri fino al z9 ottobre r87r, indi nella tipografia Calderini. -

Anarco-Socialisti Di Fine Secolo
Anarco-socialisti di fine secolo di Gustavo Buratti Un elenco di “sovversivi” del 1891 Nel mio archivio familiare ho trovato un manoscritto di due fogli protocollo per complessive otto facciate, non datato, riportante un "elenco di individui trovati annotati nelle carte e corrispondenze state sequestrate all'arrestato Caspani Antonio con le informazioni somministrate dalle rispettive autorità". Non mi spiego la provenienza di tale documento; probabilmente doveva appartenere alla famiglia di mia nonna paterna, Casaccia (da Bioglio), a sua volta imparentata con i Monticelli di Torino. Nell'una e nell'altra famiglia erano infatti magistrati ed avvocati: avvocato Candido Monticelli, magistrato (padre di Carlo Monticelli 1, Andorno Micca 1875 - Torino 1952, giornalista antifascista schedato nel Casellario politico centrale 1896-1945) 2; avvocato Giuseppe Casaccia (1861-1915); avvocato Pierino Casaccia. Il riferimento al periodico "La nuova gioventù", che si trova nella nota riguardante l'anarchico Ottavio Nannelli (erroneamente nominato "Mannelli") "che dovrebbe veder la luce fra poco a Firenze" (infatti il primo numero uscì il 18 ottobre 1891, dopo aver superato difficoltà che dovevano essere note a chi aveva redatto la nota), nonché l'età dei personaggi, datano la redazione della nota al 1891, molto probabilmente all'estate di quell'anno. Dell'Antonio Caspani, presso il quale tali nominativi furono rinvenuti, non sappiamo nulla; si può presumere che quei contatti fossero proprio in vista dell'uscita del periodico dei giovani anarchici, considerata la giovane età di molti di loro e le corrispondenze che saranno pubblicate dal settimanale, provenienti per la maggior parte proprio dalle località dove operavano i compagni del Caspani, i quali sono perlopiù riconducibili alla linea "radicale" del movimento anarchico, che comprendeva anche gli individualisti (come Angelo Mancini) e gli "espropriatori diretti" (come Rodolfo Pennicchi), il che conferisce una certa "omogeneità" al documento. -

Brogliaccio Dello Spoglio Di Cose Notabili Dai Fondi Archivistici Comunali Fino Al 1933
SILVIO BERNICOLI BROGLIACCIO DELLO SPOGLIO DI COSE NOTABILI DAI FONDI ARCHIVISTICI COMUNALI FINO AL 1933 con postille bibliografiche aggiornate al 1934 Trascritto e ordinato da UMBERTO ZACCARINI SOCIETA’ DI STUDI RAVENNATI Ravenna 2015 Avvertenze del curatore. Lo scritto incluso fra parentesi tonde appartiene al testo originale e alla mano del Bernicoli, ivi compresi gli eventuali puntini di reticenza o di lacuna (…). Lo scritto racchiuso fra parentesi quadre, invece, deve intendersi aggiunto dal curatore a chiarimento del testo cui immediatamente si riferisce. I tre puntini racchiusi fra parentesi quadre […] sono anch’essi aggiunti dal curatore, e segnalano l’illeggibilità materiale dello scritto in quel punto, dovuta o meno alla fotoriproduzione, di entità ed estensione imprecisate e da accertare di volta in volta. Quando nell’indicare la cartulazione di un libro il Bernicoli al numero non faccia seguire anche l’indicazione facciale, questa deve intendersi normalmente riferita al recto della carta. Il verso d’essa è in genere segnalato. Per agevolare eventuali ricontrolli autoptici dell’utente, gli spogli aggiunti in calce al ms., collocati fra le carte 180 e 189, sono contrassegnati da un asterisco (*). Quelli che si contengono in fogli e foglietti sciolti intercalati alle varie pagine del libro sono evidenziati con un doppio segno d’asterisco (**). Ove il semplice o il doppio asterisco contrassegni la voce reggente, esso deve intendersi esteso a tutte le sottovoci. Il presente lavoro è la trascrizione del ms. di cc. 197 conservato, per lascito dell’autore, nel fondo Carte Bernicoli, busta XLII, n. 2 dell’Archivio Storico Comunale di Ravenna. Il modello fornitomi per l’esecuzione d’esso è, purtroppo, una fotocopia di fotocopia, e precisamente della fotocopiatura del 1986 collocata a “scaffale aperto” presso la Sala di studio della Biblioteca Classense. -

L'internazionale a Cesena
fi* {2tu*"5- !'a-.-n-^^ c.'- f-77-^*\ 'k71-r' 'rt/tz/tÌ^ SIGFRIDO SOZZT L]INTERNAZIONALE A CESENA Estratto da Ricerche Cesenati, 1977 FAENZA - FRATEI,LI LEGA . EDITORI -: Iit. Kl-"- t.\; / '\l ì "\ \.4;^ _ rlj' ' ',\'1, '. ' ,.1 ', i..; SIGFRIDO SOZZL L'INTERNAZIONALE A CESENA Da circa dieci anni vado esponendo ai convegni di questa Società e in altri incontri scientifici i risultati di una mia paziente ricerca sugli inizi del movimento socialista in Romagna. Da Bo- logna a Ravenna, da Rimini a Lugo ho illustrato le vicende spesso drammatiche, vissute dai fondatori delle prime associazioni in- ternazionaliste, e il modo con cui essi si richiamarono idealmente all'esempio e alf insegnamento dei pionieri, Garibaldi più che Pisa- cane, Bakunin più che Marx ed Engels. Colgo, ora, I'occasione offertami dal ritorno degli Studi Romagnoli in questa città, per parlare dei casi capitati ai primi socialisti cesenati ampliando la nanazione fattane nel mio Gli inizi del mouimento socialísta a Cesena, libro che si ferma al 1871, Esporrò alcune notizie inedite riguardanti le circostanze, nelle quali si è formato il partito socialista nel Cesenate, e mi soffermerò, in particolar modo, a ttaffe una conclusione di quan- to sono andato dicendo finora. Ricapitolate, dare un giudizio conclusivo: perché a Cesena? Non fu Imola Ia città,, che si costituì culla del partito socialista in Romagna? Forlì, Bologna, Rimini, non prestarono le sedi ai primi incontri tra i pionieri romagnoli nel 1871 e, addirittura, tra quelli di tutta ltalia nel 1872? Ravenna, grazie alle sette società operaie, che per prime, in Romagna, dichianrono di fare propri Statuto e Regolamento dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori la famosa A.I.L. -

Uluslararası İşçiler Derneği
Modem Sosyalizm I. Enternasyonal (Uluslararası İşçiler Derneği) I. Enternasyonal, 28 Eylül 1864’te Londra’da Uluslararası İşçiler Demeği adı altında kuruldu. Sosyalizm tarihinde büyük öneme sahip olan ve çeşitli ülkelerdeki hareketleri çatısı altında birleştiren bu örgütün kuruluşundaki enternasyonalizm düşüncesi 18. yüzyılın sonundan itibaren kurulmuş olan pek çok örgütün de temel anlayışını oluşturdu. 1792’den başlayarak İngiltere’de kurulan Corresponding Societies’den (Yazışma Grupları), Kommunistische Korrespondenzkomitees (Komünist Yazışma Komiteleri) ve Bund der Kommunisten'e (Komünisder Birliği), Fraternal Democrats'dan (Kardeş Demokratlar) International Association'a (Uluslararası Dernek) kadar pek çok örgütte, tüm ülkelerdeki ezilenler arasında dayanışma ruhunun yaratılması ve yaşatılması düşüncesi hayat buldu. Fakat enternasyonalizmin I. Entemasyonal'le hayata geçirilen en gelişkin biçiminin, yani işçi sınıfının bir siyasal hareketi olarak enternasyonalizmin temelleri, 1848’in devrimci dalgası sırasında atıldı. 1848 Devrimleri'nin yenilgiyle sonuçlanması ve onu izleyen dönemdeki siyasal iktidarların gericiliği ve baskıcılığı, tüm ülkelerdeki işçi hareketlerinde de bir durgunluğu beraberinde getirmişti. Ama bu durum çok sürmedi. 1850’de başlayan ekonomik yükseliş, işçi sınıhnm nitelik ve nicehk açısından gelişmesine yolaçtı. 1857-58 yıllarında yaşanan bunalım, artan grevlerle birlikte işçi hareketlerinin yeniden canlanmasını sağladı. En önemli gelişmeler, kapitalizmin, dolayısıyla da işçi smıhmn en gelişkin olduğu ülkede, İngiltere’de -

Universidade Estadual De Campinas Instituto De Filosofia E Ciências Humanas Gualtiero Marini Revolução, Anarquia E Comunismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS GUALTIERO MARINI REVOLUÇÃO, ANARQUIA E COMUNISMO: ÀS ORIGENS DO SOCIALISMO INTERNACIONALISTA ITALIANO (1871-1876) CAMPINAS 2017 Agência(s) de fomento e nº(s) de processo(s): FAPESP, 2013/16178-3 Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Cecília Maria Jorge Nicolau - CRB 8/3387 Marini, Gualtiero, 1983- M338r MarRevolução, anarquia e comunismo : às origens do socialismo internacionalista italiano (1871-1876) / Gualtiero Marini. – Campinas, SP : [s.n.], 2017. MarOrientador: Walquíria Gertrudes Domingues Leão Rego. MarTese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Mar1. Cafiero, Carlo, 1846-1892. 2. Costa, Andrea, 1851-1910. 3. Malatesta, Errico, 1853-1932. 4. Associação Internacional dos Trabalhadores. 5. Anarquismo e anarquistas. I. Rego, Walquíria Gertrudes Domingues Leão,1946-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. Informações para Biblioteca Digital Título em outro idioma: Revolution, anarchy and communism : to the roots of Italian internationalist socialism (1871-1876) Palavras-chave em inglês: International Workingmen's Association Anarchism and anarchists Área de concentração: Ciência Política Titulação: Doutor em Ciência Política Banca examinadora: Walquíria Gertrudes Domingues Leão Rego [Orientador] Carlo Maurizio Romani Claudio Henrique de Moraes Batalha Luigi Biondi Michael McDonald Hall Data de defesa: 15-02-2017 Programa de Pós-Graduação: Ciência Política Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa de Tese de Doutorado, composta pelos Professores Doutores a seguir descritos, em sessão pública realizada em 15/02/2017, considerou o candidato Gualtiero Marini aprovado. -

LA PRIMA INTERNAZIONALE in ITALIA: Una Sintesi Nella Nascita E
LA PRIMA INTERNAZIONALE IN ITALIA: una sintesi Nella nascita e sviluppo del movimento operaio in Italia un ruolo fondamentale è dovuto al rivoluzionario russo Michail Aleksandrovic Bakunin, giunto in Italia nel 1864. 1864 nasce la Prima internazionale Nello stesso anno a Londra era stata costituita la Associazione internazionale dei lavoratori (nota in seguito come Prima internazionale) ad opera dei rappresentanti delle nascenti trade unions inglesi e delle associazioni operaie francesi di ispirazione proudhoniana. Impropriamente viene attribuito a Karl Marx il ruolo di principale ispiratore dell'Internazionale, essa “nacque come organo comune dei sindacati inglesi e francesi, con la partecipazione di un certo numero di esuli di altri paesi europei che in quel periodo vivevano a Londra […] essa fu in origine un organismo sindacale, espressione della solidarietà degli operai organizzati di Francia e Gran Bretagna, e non un movimento politico, anche se fin dall'inizio un colorito politico lo ebbe.” (Cole, p. 99). Vennero invitati alcuni esuli e “Marx dovette il suo invito soprattutto a fatto che due suoi amici – il sarto tedesco Georg Eccarius (1818-89) e l'orologiao svizzero Hermnn Jung (1830-1901) – avevano ottenuto un incarico nel movimento sindacale inglese; essi riuscirono a farlo includere nella lista fin dal primo momento” (Cole, p. 101). E' vero piuttosto che Marx, grazie alle sue notevoli doti intellettuali e ad altrettanto notevoli capacità manovriere, riuscì fin dall'inizio a giocare un ruolo di primo piano. Nella conferenza inaugurale, dopo aver esaminato varie proposte di statuti, era stata inizialmente approvata quella proposta dal mazziniano maggiore Wolff, Marx riuscì però a riscriverla completamente col pretesto di “migliorarne qua e là la forma” (Rosselli, p. -

Il Garibaldi “Socialista” (Nel 150° Dei Mille) Scritto Da Avanti! Mercoledì 05 Maggio 2010
Il Garibaldi “socialista” (nel 150° dei Mille) Scritto da Avanti! mercoledì 05 maggio 2010 La storiografia risorgimentale ha prestato scarsa attenzione al socialismo di Giuseppe Garibaldi. La sua azione politica, pervasa da sincera umanità, s’inserisce invece in quelle tendenze ideali che hanno caratterizzato il socialismo nel suo sviluppo originario. Come egli stesso ricordò più volte, fu nel 1833, durante un viaggio per l’Oriente, che conobbe le idee umanitarie e sociali di Saint-Simon. Il contatto con un gruppo di sansimoniani, guidati da Emile Barrault, e l’influenza di Saint-Simon lasciarono nel giovane Garibaldi (allora venticinquenne) un’impronta indelebile. Quel socialista francese, che predicava il libero sviluppo delle facoltà umane attraverso il ritorno all’interezza armonica della natura, orientò Garibaldi nella sua successiva evoluzione politica. I primi passi di Garibaldi risalivano agli anni Trenta del secolo XIX. Dall’adesione alla Giovane Italia - la cui affiliazione avvenne senza bruschi passaggi per l’influenza che Saint-Simon esercitò su Mazzini - e poi alla Massoneria (1844), Garibaldi corroborò gli influssi socialisti provenienti dalla Francia. L’assidua frequenza delle logge Asile de la Veru e Amis de la patrie gli permise a Montevideo di partecipare al dibattito, che si sviluppò con la pubblicazione nel 1839 de L’organisation du travail di Louis Blanc e de De lesclavage moderne di Félicité R. de Lamennais; o due anni dopo con quella di Voyage en Icarie di Etienne Cabet. Attraverso la conoscenza di queste opere, l’anticlericalismo di Garibaldi, influenzato dalle idee di Proudhon e dalle battaglie anticuriali di Lamennais, si accentuò e la sua religione naturale assomigliò sempre di più al mondo ideale dei socialisti francesi.