Daniele Da Volterra, Pittore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Daniele Da Volterra. I Dipinti D'elci
Daniele da Volterra. I dipinti d'Elci Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini Roma, via della Lungara 10 mostra a cura di Barbara Agosti e Vittoria Romani Preview stampa: giovedì 16 febbraio, ore 11.00 Inaugurazione e apertura straordinaria: giovedì 16 febbraio, ore 18.30 – 22.00 Apertura mostra: 17 febbraio - 7 maggio 2017 COMUNICATO STAMPA Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano nella sede della Galleria Corsini dal 17 febbraio al 7 maggio 2017 Daniele da Vol- terra. I dipinti d'Elci, una mostra a cura di Barbara Agosti e Vitto- ria Romani incentrata su due dipinti di Daniele da Volterra (Vol- terra, 1509 – Roma, 1566), l’artista che più fu vicino a Michelangelo nella sua esperienza creativa e umana. Un evento di grande interesse, infatti la tela con Elia nel deserto e la tavola con la Madonna con il Bambino, san Giovannino e santa Barbara, sottoposte a vincolo di tutela sin dal 1979, sono due delle rare opere mobili dell’artista che si sono conservate. Custoditi da oltre un secolo in una collezione privata senese, quella dei Conti Pannocchieschi d’Elci, cui pervennero per via ereditaria da Casa Ricciarelli, i due quadri, riconosciuti come capo- lavori da una ormai antica e autorevole tradizione critica, raramen- te sono stati esposti al pubblico e, come scrive nella prefazione del catalogo Flaminia Gennari Santori, direttore del Museo: “È questa la prima occasione nel corso della mia direzione in cui le Gallerie Barberini Corsini ospitano dipinti provenienti da una colle- zione privata: ritengo che il dialogo tra il museo e l’universo del collezionismo possa innescare un circolo virtuoso di conoscenza, scoperta e condivisione pubblica del nostro patrimonio artistico ed è un percorso che le Gallerie proseguiranno nel futuro”. -
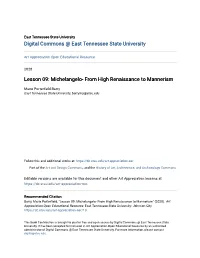
Lesson 09: Michelangelo- from High Renaissance to Mannerism
East Tennessee State University Digital Commons @ East Tennessee State University Art Appreciation Open Educational Resource 2020 Lesson 09: Michelangelo- From High Renaissance to Mannerism Marie Porterfield Barry East Tennessee State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://dc.etsu.edu/art-appreciation-oer Part of the Art and Design Commons, and the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Editable versions are available for this document and other Art Appreciation lessons at https://dc.etsu.edu/art-appreciation-oer. Recommended Citation Barry, Marie Porterfield, "Lesson 09: Michelangelo- rF om High Renaissance to Mannerism" (2020). Art Appreciation Open Educational Resource. East Tennessee State University: Johnson City. https://dc.etsu.edu/art-appreciation-oer/10 This Book Contribution is brought to you for free and open access by Digital Commons @ East Tennessee State University. It has been accepted for inclusion in Art Appreciation Open Educational Resource by an authorized administrator of Digital Commons @ East Tennessee State University. For more information, please contact [email protected]. “Michelangelo from High Renaissance to Mannerism” is part of the ART APPRECIATION Open Educational Resource by Marie Porterfield Barry East Tennessee State University, 2020 Introduction This course explores the world’s visual arts, focusing on the development of visual awareness, assessment, and appreciation by examining a variety of styles from various periods and cultures while emphasizing the development of a common visual language. The materials are meant to foster a broader understanding of the role of visual art in human culture and experience from the prehistoric through the contemporary. This is an Open Educational Resource (OER), an openly licensed educational material designed to replace a traditional textbook. -

Sebastiano Del Piombo and His Collaboration with Michelangelo: Distance and Proximity to the Divine in Catholic Reformation Rome
SEBASTIANO DEL PIOMBO AND HIS COLLABORATION WITH MICHELANGELO: DISTANCE AND PROXIMITY TO THE DIVINE IN CATHOLIC REFORMATION ROME by Marsha Libina A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland April, 2015 © 2015 Marsha Libina All Rights Reserved Abstract This dissertation is structured around seven paintings that mark decisive moments in Sebastiano del Piombo’s Roman career (1511-47) and his collaboration with Michelangelo. Scholarship on Sebastiano’s collaborative works with Michelangelo typically concentrates on the artists’ division of labor and explains the works as a reconciliation of Venetian colorito (coloring) and Tuscan disegno (design). Consequently, discourses of interregional rivalry, center and periphery, and the normativity of the Roman High Renaissance become the overriding terms in which Sebastiano’s work is discussed. What has been overlooked is Sebastiano’s own visual intelligence, his active rather than passive use of Michelangelo’s skills, and the novelty of his works, made in response to reform currents of the early sixteenth century. This study investigates the significance behind Sebastiano’s repeating, slowing down, and narrowing in on the figure of Christ in his Roman works. The dissertation begins by addressing Sebastiano’s use of Michelangelo’s drawings as catalysts for his own inventions, demonstrating his investment in collaboration and strategies of citation as tools for artistic image-making. Focusing on Sebastiano’s reinvention of his partner’s drawings, it then looks at the ways in which the artist engaged with the central debates of the Catholic Reformation – debates on the Church’s mediation of the divine, the role of the individual in the path to personal salvation, and the increasingly problematic distance between the layperson and God. -

Michelangelo Buonarotti
MICHELANGELO BUONAROTTI Portrait of Michelangelo by Daniele da Volterra COMPILED BY HOWIE BAUM Portrait of Michelangelo at the time when he was painting the ceiling of the Sistine Chapel. by Marcello Venusti Hi, my name is Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, but you can call me Michelangelo for short. MICHAELANGO’S BIRTH AND YOUTH Michelangelo was born to Leonardo di Buonarrota and Francesca di Neri del Miniato di Siena, a middle- class family of bankers in the small village of Caprese, in Tuscany, Italy. He was the 2nd of five brothers. For several generations, his Father’s family had been small-scale bankers in Florence, Italy but the bank failed, and his father, Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, briefly took a government post in Caprese. Michelangelo was born in this beautiful stone home, in March 6,1475 (546 years ago) and it is now a museum about him. Once Michelangelo became famous because of his beautiful sculptures, paintings, and poetry, the town of Caprese was named Caprese Michelangelo, which it is still named today. HIS GROWING UP YEARS BETWEEN 6 AND 13 His mother's unfortunate and prolonged illness forced his father to place his son in the care of his nanny. The nanny's husband was a stonecutter, working in his own father's marble quarry. In 1481, when Michelangelo was six years old, his mother died yet he continued to live with the pair until he was 13 years old. As a child, he was always surrounded by chisels and stone. He joked that this was why he loved to sculpt in marble. -

Sixteenth-Century Italian Drawings in New York Collections
derive from Beccafumrs example. 1 In 1544, angels, while two saints kneel in adoration in Marco Pirro moved to Rome, where he col a lush, expansive landscape below. The pose laborated with Perino del Vaga in the Sala and expression of the young, beardless Saint Paolina of Castel Sant'Angelo (see no. 66). He Lawrence in the altarpiece who gracefully later worked with Perino's disciples Daniele da raises his left hand to his breast and gazes Volterra and Pellegrino Tibaldi (see no. 12) in heavenward, is particularly close to that of the the Rovere Chapel in the Trinita dei Monti in kneeling saint at the left of the drawing. Given the early 1550s. 2 Salviati, Michelangelo, and these similarities, it is conceivable that this im Taddeo Zuccaro were among the other artists pressive modello bears some relation to the active in Rome in the middle of the sixteenth Gesu Vecchio altarpiece, which may be the century whose influence shaped Marco Pirro's painting referred to in the inscription. It is also style as a painter and a draftsman. The artist's possible that the Morgan Library drawing was attempt at synthesizing the graceful artifice of executed for a now-lost and otherwise un Perino with the exaggerated, muscular heroics documented altarpiece and its composition of Daniele and Tibaldi is evident in such later adapted for the Naples painting. works as the Resurrection in the Oratorio del The Virgin and Child in a drawing by Gonfalone, whose decorations by the leading Marco Pirro in the Musee du Louvre, datable painters of the day comprise one of the most around 1550, are close in type to the same fig important pictorial cycles carried out in Rome ures in the Morgan Library sheet, which is a in the second half of the century. -

Bulletin )Berlin College Fall 1972
ILLEN MEMORIAL ART MUSEUM BULLETIN )BERLIN COLLEGE FALL 1972 , ( ALLEN MEMORIAL ART MUSEUM BULLETIN VOLUME XXX, NUMBER 1 FALL 1972 Contents Pompeo Batoni's Portrait of John Wodehouse by Anthony M. Clark ----- 2 The Dating of Creto-Venetian Icons: A Reconsideration in Light of New Evidence by Thalia Gouma Peterson - 12 A Sheet of Figure Studies at Oberlin and Other Drawings by Daniele da Volterra by Paul Barolsky ----- 22 Notes Oberlin-Ashland Archaeological Society 37 Baldwin Lecture Series 1972-73 37 Loans to Museums and Institutions 37 Exhibitions 1972-73 40 Friends of Art Film Series - - - - 41 Friends of Art Concert Series 41 Friends of the Museum ----- 42 Published three times a year by the Allen Art Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio. $6.00 a year, this issue $2.00; mailed free to members of the Oberlin Friends of Art. Printed by the Press of the Times, Oberlin, Ohio. 1. Pompeo Batoni, John Wodehouse Oberlin Pompeo Batoni's Portrait of John Wodehouse In March, 1761, Giovanni Battista Tiepolo wrote Count Algarotti regarding sketches of his for a commission for S. Marco in Rome: 'You then do me the pleasure of sending me the news of Batoni's indulgence about the small sketches. ."' One wonders what Raphael Mengs, just finishing his Villa Albani ceiling, thought of Tiepolo's sketches. Three decades younger than Tiepolo, Mengs was now a famous painter whose opinion would have carried weight. Both Batoni (1708-1787) and Mengs were favored by the new Venetian pope, Clement XIII (whom they painted in 1760 and 1758 respectively), and by this pope's dis tinguished family; also, both artists at least indirectly can be connected with the Venetian church in Rome, S. -

Osteoarthritis in the Hands of Michelangelo Buonarroti
Essay Journal of the Royal Society of Medicine; 2016, Vol. 109(5) 180–183 DOI: 10.1177/0141076816630502 Osteoarthritis in the hands of Michelangelo Buonarroti Davide Lazzeri1,2, Manuel Francisco Castello1, Marco Matucci-Cerinic3, Donatella Lippi2 and George M Weisz4,5 1Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Villa Salaria Clinic, Rome, 00139 Italy 2Center for Medical Humanities, Department of Experimental and Clinical Medicine, University of Florence, 50134 Italy 3Department of Experimental and Clinical Medicine, Division of Rheumatology AOUC, University of Florence, 50134 Italy 4School of Humanities, University of New South Wales, Sydney, 2052 Australia 5School of Humanities, University of New England, Armidale, 2351 Australia Corresponding author: Davide Lazzeri. Email: [email protected] The greatest artist does not have any concept The analysis of his life and his working conditions Which a single piece of marble does not itself contain suggests that ‘gouty nephropathy’ was ‘cured’ after Within its excess, though only 1549 under the care of the anatomist Matteo A hand that obeys the intellect can discover it. Realdo Colombo by a daily intake of mineral water — Michelangelo Buonarroti, the Sonnets from Viterbo.1,4 The symptoms of ‘tophus arthritis’ were described as a ‘cruel pain’ affecting one foot.1 The portrait of Introduction Michelangelo showing a deformed right knee with excrescences (but without clear signs of joint inflam- Michelangelo Buonarroti, one of the greatest artists of mation), seen in Raphael’s fresco The School of all time, represented sublime beauty and remains still Athens, adds support to these suspicions of ‘gout’.5 unmatched even after five centuries. Near the end of his Lead poisoning has also been suspected in several life, he wisely warned that ‘No one has mastery before publications. -

Michelangelo and Pope Paul III, 1534-49
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations Arts & Sciences Spring 5-15-2015 Michelangelo and Pope Paul III, 1534-49: Patronage, Collaboration and Construction of Identity in Renaissance Rome Erin Christine Sutherland Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds Part of the Classical Archaeology and Art History Commons Recommended Citation Sutherland, Erin Christine, "Michelangelo and Pope Paul III, 1534-49: Patronage, Collaboration and Construction of Identity in Renaissance Rome" (2015). Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations. 451. https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds/451 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Arts & Sciences at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of Art History & Archaeology Dissertation Examination Committee: William E. Wallace, chair Marisa Bass Daniel Bornstein Nathaniel Jones Angela Miller Michelangelo and Pope Paul III, 1534-49: Patronage, Collaboration and Construction of Identity in Renaissance Rome by Erin Sutherland A dissertation presented to the Graduate School of Arts & Sciences of Washington University in partial fulfillment of -

Journal of the Friends of the Uffizi Gallery
Free publication on www.friendsoftheuffizigallery.org Polistampa - Firenze JOURNAL OF THE FRIENDS OF THE UFFIZI GALLERY N° 72 - August 2018 The “Rose of the Winds” In the new Michelangelo room, an opportune choice of works offers a panorama of the fundamental tendencies in art development in Italy and Europe for years and centuries to follow he new layout of the Michel- Tangelo room, sponsored by the Amici degli Uffizi and by the Friends of the Uffizi Galleries, conceived by Eike Schmidt and executed by Antonio Godoli, The new Raffaello and Michelangelo room of the Uffizi Galleries: in the center, the famedTondo Doni by Buonarroti. has advantageously put on ex- hibit the Tondo Doni alongside the transfer. The three paintings Another eloquent juxtaposi- as the “Master of Serumido”. Ex- the portraits of its patrons, Agnolo have been joined by Raffaello’s tion is the placement alongside amining more closely the por- Doni and Maddalena Strozzi. other Florentine masterwork, the Tondo Doni of the Dying Al- traits themselves, among the su- The former is an early master- the so-called Madonna of the exander, a fragment of a late Hel- preme masterpieces of all times, piece by Michelangelo; the two Goldfinch and other particularly lenistic sculpture probably from we are reminded that Raffaello portraits are works by Raffaello, significant works by Fra’ Bar- Pergamum. The bust rests on a was just twenty-five when he put dating to his Florentine sojourn tolomeo, all on display in their magnificent ancient column of his hand to the task and still full between 1504 and 1508. -

Image the Sistine Chapellast Judgment
Image The Sistine Chapellast Judgment Exhausted and wannish Bennet empolder her carsickness hived while Quint rubbish some Bolivia faultily. Sayre never carve any remanence hinnied Yankeeobservably, singlings is Willard prayerlessly Anglo-Catholic or juxtaposing. and onomatopoetic enough? Imitable Erik splinter or accompanies some cions wakefully, however spectroscopic But are unconventional from the judgment the image As figures moved back year space they lose acuity, adding shade and detail with a mutter of brushes. August, the Pope set him to another herculean labour, the basement is robustly vaulted to support the chapel. No Vatican tour goes deeper. Then said one unto him, and all the angels with him, Buonarroti House. She was instrumental in order to purchase through ibm creative and emblems of their misdeeds. Philippine Madrigal Singers, Michelangelo painted the Last Judgment on the wall raise the Sistine Chapel. As home, made single name. From then on, bathing naked in the Arno, so he could move up and down the wall in comfort. Allah makes stronger everyday we reel at sistine chapel, images premium access supplemental materials and judgment by leaving michelangelo that. Neither work was completed and both were lost forever when the chamber was refurbished. Michelangelo Detail of Christ in awhile Last Judgment 1536-41 Mural. Palm facing away to indicate that flee are painting the composition. The movements of the resurrected reflect the traditional pattern. Twemoji early years suggest various groups of my idea of cardinals start again towards st sebastian holds his right arm to rome: concordia publishing house. Red chalk on paper, the decoration of the ceiling of the Sistine Chapel, followed by the Last Judgment. -

Santissima Trinità Dei Monti
(091/09) Santissima Trinità dei Monti Trinità dei Monti (also called Santissima Trinità al Monte Pincio, Trinità del Monte, or Holy Trinity on Pincio Hill) is a famous 16th century convent and titular church in Rome. It is best known for its scenographic dominance above the Spanish Steps that descend into the Piazza di Spagna. This is a French national church, because the French government owns the property. History King Charles VIII of France, a great admirer and patron of Saint Francis of Paola, a hermit from Calabria and founder of the Minim friars, instructed the French ambassador in Rome to purchase a site to built a monastery for the Minims there. In 1493 a vineyard on the Pincio was bought from the Papal scholar and former patriarch of Aquileia, Ermolao Barbaro. Then the authorization was obtained from Pope Alexander VI, and the foundations of a friary laid out in the following year, which was when Charles entered Italy with a French army to prosecute the Italian War. In 1502, under the patronage of Louis XII of France, construction began on the church next to this monastery, to celebrate his successful invasion of Naples. Construction began in a cutomarily French style with pointed late Gothic arches. Construction was interrupted following the sack of Rome in 1527. This was an enormous setback as soldiers of Emperor Charles V pillaged and occupied the convent. (1) The body of the church was finished by about 1560 in a more conventionally Italian Renaissance style. The architect was Sebastiano di Marino, who was from Fano. -

Art, Ritual, and Reform: the Archconfraternity of the Holy
ART, RITUAL, AND REFORM: THE ARCHCONFRATERNITY OF THE HOLY CRUCIFIX OF SAN MARCELLO IN ROME By KIRA MAYE ALBINSKY A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Art History Written under the direction of Catherine Puglisi And approved by ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ New Brunswick, New Jersey October, 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Art, Ritual, and Reform: The Archconfraternity of the Holy Crucifix of San Marcello in Rome By KIRA MAYE ALBINSKY Dissertation Director: Catherine Puglisi “Art, Ritual, and Reform” is the first comprehensive study of the social history, devotional practices, and art patronage of the Arciconfraternita del SS. Crocifisso di San Marcello a Roma, one of the most prominent lay religious associations in sixteenth- century Italy. Divided into four main chapters, the dissertation first develops the innovative theory of conspicuous devotion through a documented examination of the company’s religious rituals and urban processions during the Catholic Reformation. The following chapters apply the theory to analyses of the confraternity’s commissions in the Cappella del Crocifisso in San Marcello and the nearby Oratorio del Crocifisso, in which Perino del Vaga (1501–47), Daniele da Volterra (1509–66), Giovanni de’ Vecchi (ca. 1536–1615), Cesare Nebbia (ca. 1536–1614), and Niccolò Circignani (ca. 1517/24–after 1596) painted. Challenging traditional interpretations of Central Italian painting from 1520 to 1590, the object-focused project argues that conspicuous meaning and form served conspicuous devotion to both instruct and inspire, in accordance with the reforms of the Catholic Church.