Libri1 17763.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 Bilancio Di Esercizio 2006
FONDAZIONE DI TORINO BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 Bilancio di Esercizio 2006 FONDAZIONE DI TORINO BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 FONDAZIONE DI TORINO Sovrintendente Walter Vergnano Consiglio d’Amministrazione Presidente Sergio Chiamparino Sindaco della Città di Torino Vicepresidente Giovanni Zanetti Consiglieri Evelina Christillin Maria Luisa Cosso Elsa Fornero Maria Luisa Pacciani Vittorio Sette Walter Vergnano Sovrintendente Segretario Franco Ferrari Collegio dei Revisori dei Conti Presidente Nadia Ribaudo Revisori Paola Martinelli Luigi Puddu Società di revisione Pitagora Revisione S.r.l. ALBO DEI FONDATORI STATO ITALIANO AZIENDE METROPOLITANE DEL COMUNE DI TORINO Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino SpA Gruppo Torinese Trasporti SpA Società Metropolitana Acque Torino SpA Sostenitori della Fondazione associati all’Unione Industriale di Torino: Autostrada Torino Milano SpA, Carrozzeria Bertone SpA, Cartiere Burgo SpA, Carpano SpA, CSP SpA, Ergom Automotive SpA, Ferrero SpA, Luigi Lavazza SpA, Manifattura Tessile di Nole SpA, Martini & Rossi SpA, Newfren SpA, Pininfarina SpA, Prisma SpA, Sagat - Turin Airport, Gruppo Comital Saiag SpA, SKF Industrie SpA. ADERENTI ALLA FONDAZIONE CIET Srl Tenuta La Fiammenga Unioncamere Piemonte circoli e associazioni Lions Club Torino Regio PARTNERS SOSTENITORI Alcatel Alenia Space Montblanc BENEMERITI DELLA FONDAZIONE Vittorio Bertone Gianfranco Carbonato Francesca Cilluffo Pietro Fraire Gianluigi Frigerio Antonio Maria Marocco Sergio Merlo Max Pellegrini -

TORINO - 80 - 18/06/11 - Pag
Pagina Fisica: LASTAMPA - TORINO - 80 - 18/06/11 - Pag. Logica: LASTAMPA/CRONACA/29 - Autore: MASMAN - Ora di stampa: 17/06/11 21.24 T1 T2 PR CV LA STAMPA 80 Dove andiamo SABATO 18 GIUGNO 2011 U BRONSON eletto, il nuovo Pontefice entra in IL RAGAZZO CON LA .... 90 minuti. Uscito dal carcere, il guar- ··· Azione. Regia di Nicolas Win- crisi in quanto si ritiene inadatto al ··· Drammatico. Regia di Jean-Pier- diano notturno Alì si dedica alla sua ding Refn, con Tom Hardy e Kelly La classifica dei film più visti ruolo: interviene uno psicanalista. re e Luc Dardenne, con Jérémie Renier famiglia: durante uno scontro tra Adams. Durata: 92 minuti. La sto- LIBERA USCITA e Cécile De France. Durata: 87 minuti. polizia e manifestanti a Teheran la ria vera di Michael Gordon Peter- ·· Commedia. Regia di Bobby e Pe- Il dodicenne Cyril viene messo dal pa- moglie viene uccisa, lui si vendica. son, il detenuto più violento delle ter Farrelly, con Owen Wilson e Ja- dre in un centro di accoglienza per Produzione iraniana. carceri inglesi. son Sudeikis. Durata: 105 minuti. l’infanzia: durante una fuga, incontra TUTTI PER UNO I film CORPO CELESTE Per rivitalizzare i loro matrimoni, una parrucchiera che si prende cura ··· Drammatico. Regia di Romain ··· Drammatico. Regia di Alice due mogli concedono ai mariti una di lui. Dagli autoridi «Rosetta». Goupil, con Valeria Bruni Tedeschi e Rohrwacher, con Yle Vianello e settimana di totale libertà. Dai cine- RED Linda Doudaeva. Durata: 90 minuti. Mi- Salvatore Cantalupo. Durata: 98 asti di «Tutti pazzi per Mary». -

L'offerta Culturale Di Torino E I Progetti Avviati, Alla Conclusione Del Mandato Nel Giugno 2011. Arte Antica Il Museo Egizio In
L'offerta culturale di Torino e i progetti avviati, alla conclusione del mandato nel giugno 2011. Arte antica Il Museo Egizio in occasione delle Olimpiadi del 2006 è stato rinnovato nel suo statuario con l'intervento di Dante Ferretti. All'inizio del 2015 verrà inaugurato il nuovo Museo, raddoppiato nello spazio espositivo (progetto Aimaro Isola), arricchito di tutti i servizi di un moderno museo e riallestito dallo stesso Dante Ferretti. Sarà il museo di antichità egizie più suggestivo del mondo. La Galleria Sabauda, pinacoteca di arte antica ricca soprattutto di capolavori fiamminghi, si sta spostando dalla sede storica che si trovava ai piani superiori del Museo Egizio, alla manica nuova di Palazzo Reale. Anch'essa sarà ultimata per l'inizio del 2015. Il Polo Reale (una sorta di Ermitage) comprende in un unico percorso di visita il Museo di Archeologia (con una nuova ala dedicata alla Torino romana), la nuova Galleria Sabauda, il Palazzo Reale, l'Armeria Reale, la Biblioteca Reale (con l'autoritratto di Leonardo da Vinci e altri 12 suoi disegni), Palazzo Chiablese (dove vi saranno le biglietterie e i servizi per tutto il Polo), i Giardini Reali. Nello stesso sistema edilizio, al di là della Prefettura, si trova l'Archivio di Stato di eccezionale bellezza e ricchezza. Il Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama (edificio che testimonia 2000 anni di storia, con porta romana incorporata, castello medioevale dei D'Acaja, facciata barocca-neoclassica di Filippo Juvarra) contiene sezioni di arte gotica, rinascimentale, barocca, ampio spazio dedicato all'arte decorativa (soprattutto porcellane) e giardino medioevale. La città romana comprende la Porta Palatina (la meglio conservata al mondo) e il teatro romano. -

Download the Map of the Savoy Royal Residences of Piedmont
PASSPORT TO THE ROYAL RESIDENCES OF PIEMONTE • Collect the Stamps of all the Royal Palaces • Musei Reali (Palazzo Reale) Reggia di Venaria Palazzo Chiablese Castello della Mandria Palazzo Madama Castello di Rivoli Palazzo Carignano Palazzina di Caccia di Stupinigi Villa della Regina Castello di Agliè Castello del Valentino Castello di Govone Tenuta di Pollenzo Castello di Moncalieri (Agenzia di Pollenzo) “I wished for this moment with pleasure, this moment of a metamorphosis from logistician to traveler; the time of preparation Castello di Racconigi has ended, and finally it’s time to sleep in Torino tonight and start off tomorrow morning! ”. Enrico Brizzi, “The Route of the Kings. Journey on Foot Among the Savoy Residences” OYAL ONDERS By the Consortium of the Residences of the Royal House of Savoy In collaboration with R W The Residences of the Savoy in Piemonte residenzereali.it ENGLISH Royal Wonders The Residences of the Savoy in Piemonte Torino has a district of charming Royal Palaces and Castles that are also of noteworthy historical-artistic value, a real urban and architectural system that ideally frames the city: the so-called Crown of Delights, as it was once labeled in order to define the extraordinary 1 2 3 complex of court residences that arose around the capital between the 16th and 18th centuries as a leisure resort and, at the same time, centers of power and control of the territory by the Dukes and Kings of the House of Savoy. These were majestic buildings adorned with fabulous gardens and precious works of art which, together with the others scattered throughout Piemonte, competed for beauty and grandeur with the sumptuous European royal residences of the period. -
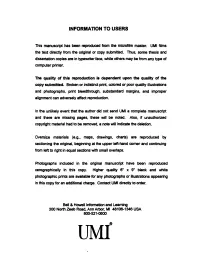
Operatic Reform in Turin
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter tece, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, If unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Bell & Howell Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 NOTE TO USERS This reproduction is the best copy available. UMI OPERATIC REFORM IN TURIN: ASPECTS OF PRODUCTION AND STYLISTIC CHANGE INTHEI760S DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Margaret Ruth Butler, MA. -

Piazza San Carlo
BOTTEGHE STORICHE CHIESE E CAPPELLE PALAZZI ED EDIFICI STORICI ToTo TORINO TOUR FOR ALL ARCHITECTURE PLACES SITI ARCHEOLOGICI MONUMENTI IL QUADRILATEROARCHITETTURA URBANA POINT OF INTEREST 1 PIAZZA CASTELLO Torino Tour for All begins in the very heart of the city, piazza Castello, which spans about 40 thousand square meters. It is bordered to the northeast by piazzetta Reale and it merges four of the main downtown roads: via Garibaldi (a pedestrian street), via Po, via Roma and via Pietro Micca. During the Savoy reign, and then in the post-Unification period, Piazza Castello was the center of the Piedmontese State. It is surrounded on three sides by monumental porches, built in different times. In the mid XIX century, the west arcades were nicknamed Arcades of the Fair, because of the market housed during Carnival. On Piazza Castello there are several historical buildings, starting from via Garibaldi and proceed- ing clockwise: Palace of the Regional Council, Church of San Lorenzo, Royal Palace, Royal Library and Armory, State Archives, Government Palace (now the Prefecture Palace), Royal The- atre and the Galleria dell’Industria Subalpina (Subalpine Gallery of Industry). At the center of the square there is Palazzo Madama. Ascanio Vitozzi, architect of the Duke of Savoy Carlo Emanuele I, designed piazza Castello start- ing from 1587. The square was born to frame in a neat space the existing Senate and to accom- modate the Novo Palazzo Grande, today’s Royal Palace. Despite the architectural interventions of 1612 and 1773, piazza Castello maintains its configuration in three areas: the oldest, whose structure dates back to Roman times, on the side of Via Garibaldi, the area connecting Piazza Castello to the river through Via Po and the area of the Piazzetta Reale which was once divided from the square by a brick wall. -

City Centre - Centre Ville - Centro Ciudad - Stadtzentrum Musei - Museums - Musees - Museos - Museen
MUSEI • MUSEUMS • MUSEES • MUSEOS • MUSEEN TORINO CENTRO CITTÀ - CITY CENTRE - CENTRE VILLE - CENTRO CIUDAD - STADTZENTRUM MUSEI - MUSEUMS - MUSEES - MUSEOS - MUSEEN 11 2 25 Appartamenti e Tombe Reali di Casa Savoia Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti 1 16 36 9 7 Basilica di Superga Via Pietro Giuria 15 • D5 km 4,7 Via Accademia Albertina 8• D2 Strada Basilica di Superga 75 • F2 Km 9,5 Fruit Museum - Musée du Fruit Picture Gallery - Pinacothèque - Pinacoteca - Pinakothek 8 Royal Tombs - Tombes Royales Museo de la Fruta - Obstmuseum Tumbas Reales - Königliche Gräber 37 Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli” 17 Museo della Radio e della Televisione Via Nizza 230/int. 103 - Lingotto• E5 km 7,2 3 Via Giuseppe Verdi 16 Picture Gallery - Pinacothèque - Pinacoteca - Pinakothek 2 Borgo e Rocca Medievale • E2 Viale Virgilio 107 - Parco del Valentino• E5 Km 3,7 Museum of radio and television - Musée de la radio et de la télévision 7 Medieval village - Village médiéval Museo de la radio y de la televisión - Radio- und Fernsehmuseum 38 Spazio “La Stampa” Ciudad medieval - Mittelalterliches Dorf Via Lugaro 21 • D5 km 4 8 18 Museo della Sindone Story of the evolution of the La Stampa newspaper Via San Domenico 28 Exposition qui raconte l’évolution du journal La Stampa 14 3 Camera - Centro Italiano per la Fotografia • B2 Via delle Rosine 18 • E3 Museum of the Holy Shroud - Musée du Saint Suaire Historia de la evolución del periódico La Stampa 12 Temporary exhibitions - Expositions temporaires Museo de la Sabana Santa - Museum des Hl. -

Strage Sotto Casa Di Sharon: 11 Morti Gerusalemme, Poliziotto Palestinese Si Fa Esplodere Su Un Bus
l'Unità + € 3,50 libro "Fatti e personaggi": tot. € 4,50 l'Unità + € 4,90 libro "Corvo Rosso": tot. € 5,90 l'Unità + € 4,90 libro "Ebraismo": tot. € 5,90 l'Unità + € 4,90 libro "L'Islam": tot. € 5,90 ARRETRATI EURO 2,00 anno 81 n.29 venerdì 30 gennaio 2004 euro 1,00 l'Unità + € 3,50 libro "Meditate che questo è stato": tot. € 4,50 www.unita.it SPEDIZ. IN ABBON. POST. 45\% l'Unità + € 2,20 rivista "No Limits": tot. € 3,20 ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 – FILIALE DI ROMA l'Unità + € 4,90 vhs "Jona che visse nella balena": tot. € 5,90 Cultura di governo. «Berlusconi ha ricchissimo. Possiede la squadra di nuova generazione. Dedicherò ad esso trovato finalmente un sosia calcio di Bucarest e dice: “Mi dichiaro la mia vita come finora l’ho dedicata in Romania. È un certo Gigi Becali, comandante supremo del partito della al pallone”». Le Monde, 28 gennaio Comincia lo smembramento d’Italia La Thyssen-Krupp taglia 900 posti Riforme, Bossi vuole trasferire il Senato a Milano sotto il suo diretto controllo Terni, chiudono Dice: oppure la Lega farà azioni dirompenti sul territorio. L’Ulivo: sarà scontro le Acciaierie Persino Fisichella parla di «progetti avventati che generano conflitto istituzionale» Luana Benini La città si ribella Governo Il Paese spaccato in due dalla neve TERNI Blocchi stradali, scioperi, as- oggi è stato proclamato uno scio- ROMA L’ultimo ricatto della Lega: il semblee: Terni si mobilita a difesa pero ad oltranza. Una delegazio- Senato della Repubblica a Milano. -
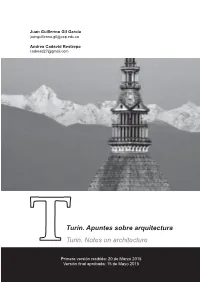
Texto Completo (Pdf)
Juan Guillermo Gil García [email protected] Andrea Cadavid Restrepo [email protected] Turín. Apuntes sobre arquitectura Turin. Notes on architecture Primera versión recibida: 20 de Marzo 2015 Versión final aprobada: 15 de Mayo 2015 Resumen Este artículo hace referencia a la evolución urbana y arquitectura representativa de la ciudad de Turín en el norte de Italia, ampliamente reconocida como un excelente laboratorio para entender el periodo barroco. La ciudad ha sido objeto de múltiples impresiones por parte de reconocidas personalidades, entre ellas las del filósofo y escritor alemán Federico Nietzsche, quién vivió sus últimos años de lucidez en esta ciudad. A la luz de sus descripciones, se desarrolla el hilo conductor de la investigación, resaltando la afinidad espiritual que los seres humanos tienen con el carácter de la ciudad, para entender finalmente que la identidad humana presupone la identidad del lugar y representa una extensión de los lugares y las 46 cosas. Palabras claves Turín, Historia de la arquitectura, barroco, Nietzsche. Abstract: This article is intended to refer to urban development and architecture representative of the city of Turin in northern Italy, widely recognized as an excellent laboratory for understanding the Baroque period. The city has been the subject of multiple prints by renowned personalities, including writer and German philosopher Friedrich Nietzsche, who spent his last years of lucidity in this city. In light of his descriptions, the theme of the research is conducted, highlighting the spiritual affinity that humans have with the character of the city, to finally understand that human identity presupposes the identity of the place and represents an extension of the places and things. -

Download Document
General Council Term of Office 2016-2019 End-of-Tenure and 2019 Report Text approved by the General Council on 20/04/2020 Contents Preface: Letter from the General Council 3 Institutional activity 2016-2019 37 Research and public health International affairs programme Historical and legal profile of FCSP 6 Art, cultural heritage and cultural activities Cultural innovation Social policy Housing programme 2016-2019: data on institutional activity ZeroSei programme Philanthropy and Local Communities undertaken in the four-year period, and 2019 “Social Report” 11 Major system-building projects 63 Inclusion in practice: MOI – a response to the migration emergency FCSP 2016-2019: Public health as a value-generator: progress towards the Turin Health Park reorganisation and processes 26 Injecting dynamism into cultural heritage: the Residences of the House of Savoy Becoming a HUB: operational effects “Riconnessioni”: the digital education model Evolution of the multiplier vectors: At the service of a cohesive, enterprising ecosystem of territorial innovation the High-Impact Innovation Department The metropolitan environment and ecosystem The Planning, Studies and Assessment Department for the growth of social enterprise FCSP: a stand-alone entity and a Group Boosting competitiveness in Turin’s higher education system More than just method: a sustainable new angle on traditional goals Communicating strategically The Administration function: The contribution of the Council’s subject-specific committees 71 evolution of the organisational set-up Applicants -

Milano Design Week Per Una Settimana La Città Si Trasforma E Diventa La Capitale Mondiale Dell’Arredo Con Le Idee Più Interessanti Di Archistar E Designer
I sensi del viaggio VIAGGI Da Torino a Venezia alla scoperta degli eventi più importanti PERSONAGGI L’attore Elio Germano La musica dei Negrita Il ristorante di Cracco Milano Design Week Per una settimana la città si trasforma e diventa la capitale mondiale dell’arredo con le idee più interessanti di archistar e designer SOMMARIO MILANO DESIGN WEEK I sensi del viaggio In copertina in senso orario: chandelier Henge, sedie Cassina, vasi Hermès VIAGGI (foto A. Samson), tavolo Da Torino a Venezia alla scoperta degli eventi più importanti PERSONAGGI Cappellini, tavolo Natuzzi, L’attore Elio Germano La musica dei Negrita Il ristorante di Cracco sedie Kartell, installazione di Elena Salmistraro per Timberland, tavoli Riva 18 Milano Design Week 1920, divano Seletti. Per una settimana la città si trasforma e diventa la capitale mondiale dell’arredo con le idee più interessanti di archistar e designer 11 OPINIONE DI GIANNI RIOTTA Quando saranno pronte le intelligenze artifi ciali? 13 OPINIONE DI FABIANA GIACOMOTTI Virgil Abloh tra arte e anticonformismo 15 OPINIONE DI ALESSANDRO BORGHESE Destinazione o destino? Dove 25 PLOMPMOZES SNØHETTA conduce il vostro viaggio? 16 EDITORIALE DI PAOLO POSTERARO Aprile dolce dormire? No, c’è tanto da scoprire 18 COVER STORY DI MILENA ARDESANI Creatività senza limiti 25 DAL MONDO News Appuntamenti 40 39 VIAGGIARE NEI 5 SENSI ITALOTRENO.IT APRILE 2018 _ 5 SOMMARIO VISTA 70 FORMULA E 40 DI ANDREA CORDOVANI TORINO-VENEZIA Una corsa elettrizzante DI CRISTINA GRINER Fermate d’autore 74 MUSICA 48 DI DARIO MORCIANO BERGAMO -
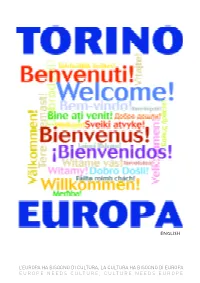
PROGRAMMA INGLESE Agg Testi 22-09-2014 16:10 Pagina 1
PROGRAMMA INGLESE agg testi 22-09-2014 16:10 Pagina 1 ENGLISH L’EUROPA HA BISOGNO DI CULTURA, LA CULTURA HA BISOGNO DI EUROPA E U R O P E N E E D S C U LT U R E , C U LT U R E N E E D S E U R O P E PROGRAMMA INGLESE agg testi 22-09-2014 16:10 Pagina 2 PROGRAMMA INGLESE agg testi 22-09-2014 16:10 Pagina 3 EUROPEAN WEEK OF CULTURE 20th - 28th September 2014 PROGRAMMA INGLESE agg testi 22-09-2014 16:10 Pagina 4 PROGRAMMA INGLESE agg testi 22-09-2014 16:10 Pagina 5 Welcome Europe! he meeting of EU Culture Ministers which will be held in Torino on September 23- 24 is the most significant achievement of the important role culture plays in shaping Tour city’s identity and life. The role of capital - first of the House of Savoy, then of Italy - allowed Torino to develop a strong cultural tradition, well testified by remarcable Royal residences of baroque architecture. Nevertheless, something new has happened in the last 15 years: Torino - for more than 100 years an industrial and manufacturing city - has undergone a huge transformation. Without losing its industrial profile, the city has grown and has acquired new knowledge and understanding. Today Torino is home to many national and international research centres, it is a university pole par excellence, a cultural capital offering a wide range of events in all fields. Moreover, thanks to our strong commitment to developing cultural investment, Torino is now an important tourist destination.