Collezione-Premoltiplicazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Retail Wine List
RETAIL WINE LIST Dear Friends, Guests & Wine Lovers: If you’re looking for a silver lining during these challenging times, well here it is! All wines on our extensive wine list are now available for takeout at retail prices! That means you save 50% on average, and a great bottle of wine makes a perfect pairing for your la Spiga meal at home. But, how to choose from so many?? Our awesome wine steward & sommelier, Dominic DeFilippo, is here to help! You may contact him in the following ways: T: 206.323.8881 (la Spiga)* C: 206.618.5667 (call or text)* E: [email protected] * Tues-Sat, 3pm to 6pm “anni e bicchieri d i vino non si contano ma i ” age and glasses of wine should never be counted Vini Frizzanti e Spumanti Ferrari Trento DOC Brut NV 28 Chardonnay Franciacorta 1701 Brut NV (Biodynamic, Organic) 30 Chardonnay, Pinot Nero, Lombardia Gianluca Viberti Casina Bric 460 Sparkling Rose Brut 27 Nebbiolo, Piemonte Contratto Millesimato Extra Brut ‘12 35 Pinot Nero, Chardonnay (Bottle Fermented, Natural Fermentation), Piedmont Palinieri “Sant’Agata” Lambrusco Sorbara ’18 17 Lambrusco Sorbara Quaresimo Lambrusco (Frizzante) NV 18 Lambrusco (Biodynamically farmed in Emilia Romagna!) Vini Spumanti Dolci (Sweet) Spinetta Moscato d’Asti (.375) 2017 16 Moscato Marenco Brachetto d’Acqui (.375) 2017 16 Brachetto Vini Bianchi ALTO ALDIGE Abazzia Novacella ‘17 22 Kerner Terlano Terlaner ‘17 30 Pinot Bianco, Sauvignon Blanc, Chardonnay Terlano Vorberg Riserva ‘17 46 Pinot Bianco “d ire pane al pane e vino al vino ” speak bread to bread and wine to wine -
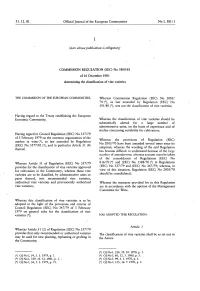
Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31
31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -

Piattaforma Ampelografica Denominazioni E Tipologie Vini ( Codice 9 Caratteri ) Vendemmia 2014
Piattaforma Ampelografica Denominazioni e Tipologie Vini ( Codice 9 caratteri ) Vendemmia 2014 Codice Codice Perc min Perc max Perc min Perc max Base Regione Descrizione tipologia Descrizione varietà Gruppo tipologia varietà singola singola gruppo gruppo ampelografica VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 160 NEBBIOLO N. 70 100 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 304 CORNALLIN Rs. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 073 DOLCETTO N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 089 FUMIN N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 351 GAMARET N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 091 GAMAY N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 306 MAYOLET Rs. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 146 MERLOT N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 169 NEYRET N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 186 PETIT ROUGE N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 195 PINOT NERO N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 312 PRIE ROUGE Rs. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 231 SYRAH N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 265 VIEN DE NUS N. 0 30 Prima VALLE D'AOSTA B227B9992 VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET 356 VUILLERMIN N. -

Mirabelle Wine List 10.10.20
“cheers to love” 12518 BURBANK BLVD. VALLEY VILLAGE, CA 91607 / 818-927-4241 R O S É & S P A R K L i N G CERASUOLO D’ABRUZZO ROSE AGRIVERDE “SOLÀREA” – PUGLIA, IT ‘18 12/45 MOURVEDRE ROSE TERCERO - SANTA BARBARA COUNTY, CA ‘19 14/52 gamay semi sweet sparkling rose BALIVET “BUGEY CERDON” - FÁCHE BUGEY, FR NV 16/60 FRANCIACORTA IL PENDIO “IL CONTESTATORE” PAS DOSE – LOMBARDY, IT ’16 18/68 W H i T E PORTUGUESE WHITE BLEND ADEGA REGIONAL COLARES – LISBOA, PORTUGAL ’16 1 2 / 45 AlIGOTE JEAN FOURNIER “CHAMP FOREY” – BOURGOGNE, FR ‘14 14/52 SAUVIGNON BLANc FRANÇOIS CHIDAINE - TOURAINE – LOIRE VALLEY, FR ‘19 15/56 CHARDONNAy MATTHIASSON– “LINDA VISTA VINEYARD” - NAPA VALLEY, CA ’16 17/65 R E D LAGREIN/TEROLDEGO/MERLOT CESCONI “MORATEL” – TRENTINO-ALTO-ADIGE, IT ’12 13/48 PINOT NOIR PRESQU’ILE – SANTA MARIA VALLEY, CA ‘16 17/64 GRENACHE/CARIGNAN DOMAINE GARDIÉS “TAUTAVEL” – ROUSSILLON, FR ‘11 14/52 PRIMITIVO/RISERVA FATALONE – PUGLIA, IT ‘17 18/68 B i E R E S in can Nitr0 pale ale OLIVER BREWING CO. “PEOPLE POWER” BALTIMORE, OK 6% – 16OZ CAN 8 FLANDERS OUD BRUIN BROUWERS VERZET BELGIUM 6% – 12OZ BOTTLE 15 WIT TEMESCAL BREWING BELGIAN STYLE WHEAT OAKLAND, CA 5.2% – 16OZ CAN 8 IPA GHOST TOWN BREWING CO. “FRIENDS W/SOCIAL DISTANCES” OAKLAND, CA 7.2% – 16OZ CAN 9 SAISON PRAIRIE ARTISAN ALE KREBS, OK 8.2% – 16OZ BOTTLE 12 Saison UPRIGHT BREWING “SAISON VERT” PORTLAND, OR 4.75% – 25OZ BOTTLE 25 STOUT MIDNIGHT SUN BREWING CO. “BAR FLY” ANCHORAGE, AK 11.6% – 22OZ BOTTLE 35 - - - - - - - - - B i E R E S On Tap HELLES SCHÖNRAMER PETTING, GERMANY 5% - 12OZ 8 BELGIAN WHITE AVERY BREWERY “WHITE RASCAL” BOULDER, CO 5.6% – 12OZ 8 D E S S E R T W i N E S CHENIN BLANC 3OZ. -

Jaime Kaloustian Beverage Director
Jaime Kaloustian Beverage Director Meghan Warner Heather McAvoy William Thomas Pawel Kochanowski Beverage Team TABLE OF CONTENTS COCKTAILS, BEER, CIDER, 3 WINES BY THE GLASS 4 SHERRY BY THE GLASS 5 SPARKLING WINE 6 CHAMPAGNE 7 THE TERTIARY COLORS OF WINE 8 VINTAGE CALIFORNIA 9 WHITE WINES SAUVIGNON BLANC, CHENIN BLANC & AUSTRIAN WHITES 11 RIESLING 12 CHARDONNAY & CHABLIS 13 WHITE BURGUNDY 14 FRENCH WHITE VARIETALS 15 ITALIAN & SWISS WHITE VARIETALS 16 SWISS, GREEK, SLOVENIAN & AUSTRALIAN WHITES 17 SPANISH & PORTUGUESE WHITES 18 ASSORTED AMERICAN WHITES 19 RED WINES PINOT NOIR 20 RED BURGUNDY 21 FRENCH RED VARIETALS 23 RHONE VALLEY RED VARIETALS 24 CABERNET SAUVIGNON 26 BORDEAUX RED VARIETALS 27 LOIRE VALLEY RED VARIETALS 27 ITALIAN RED VARIETALS 29 SPANISH, PORTUGUESE RED VARIETALS 31 GREEK, CAUCASUS & AUSTRIAN RED VARIETALS 32 SOUTHERN HEMISPHERE RED VARIETALS 32 ASSORTED AMERICAN RED VARIETALS 33 HALF BOTTLES 34 LARGE FORMATS 35 SWEET & FORTIFIED 37 Page 2 COCKTAILS Continental Collins 16 gin, white banyuls, cocchi americano, pineau de charentes, tonic Your Orchard or Mine DSP CA 162 tangerine vodka, aqua di cedro, maraschino, bitter lemon soda Sin City tequila, pommeau, batavia arrack, dry curaçao, green apple salts Timber... bourbon, zirbenz pine, reisetbauer hazelnut, bergamot, lemon verbena Tiki Torture smith & cross rum, cardamaro, pineapple-sage, chuncho, egg white The Moody Pumpkin pumpkin cordial, laphroig scotch, moody tongue churro baltic porter BEER North Coast Brewing "PranQster" Belgian Ale, California 8 Finch's "Chimera" -

Danilo Thomain
Danilo Thomain Home of the second-highest winegrowing zone in the valley, the the Enfer d’Arvier is a splendorous amphitheater of steeply terraced vines overlooking the Dora Baltea/Doire Baltée river below. Covering a scant 5 ha, the majority of the Enfer d’Arvier’s output is via the local co-op, and with his single hectare in production, Danilo Thomain stands as the zone’s only independent bottler of wine. Amazingly, he is currently clearing and de-foresting another hectare’s worth of hillside above his current holdings in order to expand production, thereby reclaiming some of the long-unused but prime terrain whose viticultural records date back to the 13th century. The huge diurnal shifts between Enfer d’Arvier’s scorching days and chilly nights—“Enfer d’Arvier,” after all, means “The Hell of- Ar vier”— expresses itself in a palate tug-of-war between rapier-like acidity and thick, luscious fruit that vibrates with energy—and as a recently consumed 2008 attested, it can age beautifully. It seems like just the other day that, through a recommendation from his pal Ermes Pavese, we had yet another face of the Valle d’Aosta’s incomparable terroir revealed to us. These are the sorts of treasures we at Rosenthal live for—arresting wines made by fascinating people working in unique corners of the earth—and Thomain’s wines were an immediate success. Danilo produces only a few hundred cases of wine each vintage, and being able to purchase over half of it for the USA is a great privilege indeed. -

WINTER COCKTAILS WINTER Vino Picks
Original WOOD BURNING ITALIAN GRILL WINTER COCKTAILS Cocktails inspired by the mountains of Italy. ITALIAN GREYHOUND 12 Keep it light with this low ABV option. Punt E Mes, Grapefruit, Salt MONTE MUSINE 13 Warm yourself from those frigid temps. PAGANELLA 14 Antica Torino Amaro Della Sacra, hot peppermint tea, lemon Bask in the rejuvenating effects of this bright, herbaceous cooler. Ransom Old Tom Gin, Monkey 47 Gin, Cappelletti Pasubio, grapefruit, lemon CRISTALLO 14 FALCADE 15 A cranberry daiquiri with a whisper of fresh mountain air. A take on the popular vodka soda that's ready for the slopes. Chocolate Infused Tito's Vodka, Poli Vermouth Bianco, Kumquat, Privateer Rum Per Terra, Nardini amaro, cranberry, lime Lemon, Club Soda CRESTA DEL LEONE 15 FIBONACCI 16 Brave the bold flavors of this northern Italian summit. Russell's Reserve 6 Year Rye Whiskey, Ottoz Amaro Ebo Lebo, Santa Refreshing and complex, best enjoyed next to our fire. Maria al Monte, Cocchi Americano Tequila Ocho Plata, Luxardo Fernet, Pomegranate, Rosemary, Lime SCORLUZZO 14 MOTTARONE 16 A refreshing Alpine sour. Be sure to show us your stache! Head to the summit with this take on an old fashioned. Four Roses Bourbon, Braulio, honey, grapefruit, lemon, egg white Ocho Reposado Tequila, Del Maguey Mezcal Chichicapa, Tempus Fugit Kina l'Aero d'Or, Seville Orange WINTER vino picks bubbles spumanti REDS rossi FRANCIACORTA BRUT ROSE FLAMINGO 88 LEZER 2019 55 Monte Rossa / Lombardia / Chardonnay, Pinot Nero Foradori / Trentino-Alto Adige / Teroldego Celebrating? Toast the occasion with this Light, soft biodynamic wine that will do well with a chill. -
Retail Wine List
RETAIL WINE LIST Dear Friends, Guests & Wine Lovers: If you’re looking for a silver lining during these challenging times, well here it is! All wines on our extensive wine list are now available for takeout at retail prices! That means you save 50% on average, and a great bottle of wine makes a perfect pairing for your la Spiga meal at home. But, how to choose from so many?? Our awesome wine steward & sommelier, Dominic DeFilippo, is here to help! You may contact him in the following ways: T: 206.323.8881 (la Spiga)* C: 206.618.5667 (call or text)* E: [email protected] * Tues-Sat, 3pm to 6pm “anni e bicchieri d i vino non si contano ma i ” age and glasses of wine should never be counted Vini Frizzanti e Spumanti Bortolomiol “Prior” Prosecco Superiore ‘19 19 Glera, Veneto Contratto Millesimato Extra Brut ‘12 35 Pinot Nero, Chardonnay (Bottle Fermented, Natural Fermentation), Piedmont Ferrari Trento DOC Brut NV 28 Chardonnay Franciacorta 1701 Brut NV (Biodynamic, Organic) 30 Chardonnay, Pinot Nero, Lombardia Palinieri “Sant’Agata” Lambrusco Sorbara ’18 17 Lambrusco, Sorbara Rosa Luna Lambrusco ’19 19 Lambrusco, Emilia-Romagna Vini Spumanti Dolci (Sweet) Marenco Brachetto d’Acqui (.375) ‘17 16 Brachetto Spinetta Moscato d’Asti (.375) ‘17 16 Moscato Vini Bianchi ALTO ALDIGE Abazzia Novacella ‘18 24 Kerner Terlano Terlaner ‘17 30 Pinot Bianco, Sauvignon Blanc, Chardonnay Terlano Vorberg Riserva ‘17 46 Pinot Bianco FRIULI Damijan “Kaplja” (Orange) 45 Chardonnay, Friulano, Malvasia Istriana I Clivi Verduzzo ‘15 26 Verduzzo Ronchi di Cialla -

La Carta Dei Vini Dell'hotel Laghetto
LA CARTA DEI VINI DELL'HOTEL LAGHETTO MAISON VIGNERONNE "FRÈRES GROSJEAN" - Quart L'azienda vitivinicola "Grosjean" nasce nel 1969 ad opera di Dauphin Grosjean che iniziò ad imbottigliare il proprio vino per presentarlo alla "II Exposition des Vins du Val D'Aoste". Le tecniche colturali sono profondamente legate al rispetto dell'ambiente. Dal 1975 non vengono più utilizzati insetticidi e le concimazioni vengono effettuate esclusivamente con concimi organici. Mayolet DOC Anno 100% Mayolet 12% vol. 2013 € 19,00 Torrette DOC Anno 80% Petit Rouge - 20% Vien de Nus, Fumin e Cornalin 12,5% vol. 2013 € 18,00 Lt. 0,375 € 10,00 Torrette Supérieur DOC (Vigne Rovettaz) Anno 75% Petit Rouge - 10 % Cornalin - 10% Fumin - 5% Prëmetta 12,5% vol. 2012 € 24,00 Cornalin DOC (Vigne Rovettaz) Anno 100% Cornalin 12% vol. 2012 € 19,00 Prëmetta DOC Anno 100% Prëmetta 12,5% vol. 2012 € 20,00 Fumin DOC Anno 90% Fumin - 10% Petit Rouge 12,5% vol. 2010 € 25,00 Pinot Noir DOC Anno 100% Pinot Noir 13% vol. 2011 € 19,00 Pinot Noir DOC (Vigna Tzeriat) Anno 100% Pinot Noir 13,5% vol. 2011 € 25,00 Petit Arvine DOC (Vigne Rovettaz) Anno 100% Petit Arvine 13,5% vol. 2013 € 20,00 Lt. 0,375 € 11,00 Chardonnay DOC (Vigne Rovettaz) Anno € 19,00 100% Chardonnay 13% vol. 2013 2012 Gewürztraminer Anno 100 % Gewürztraminer 13% vol. € 21,00 2013 AZIENDA VITIVINICOLA "LO TRIOLET" - Introd L'Azienda vitivinicola Lo Triolet, specializzata nella produzione di premiati vini bianchi, si trova ad Introd. Marco Martin, tecnico in viticoltura, crea vini sapidi, freschi ed eleganti che esprimono l'essenza del terroir di montagna. -
Wine Spirits
WINE SPIRITS “il vino fa buon san gue ” literal: good wine makes good blood English equiv: an apple a day keeps the doctor away Vini Frizzanti e Spumanti Ferrari Trento DOC Brut NV 55 VAL D’ AOSTA Chardonnay Grosjean Vigne Rovettaz ‘16 62 Franciacorta 1701 Brut NV (Biodynamic, Organic) 60 Petite Arvine Chardonnay, Pinot Nero, Lombardia Chateau Feuillet Traminer ‘17 60 Gianluca Viberti Casina Bric 460 Gewurztraminer Sparkling Rose Brut 52 Nebbiolo, Piemonte PIEMONTE Contratto Millesimato Extra Brut ‘12 68 La Scolca Gavi Black Label ‘15 92 Pinot Nero, Chardonnay (Bottle Fermented, Cortese Natural Fermentation), Piedmont Vigneti Massa “Petit Derthona” ‘17 48 La Staffa “Mai Sentito!” (Frizzante) ’17 39 Timorasso Verdicchio (Certified Organic, Pet’Nat, Bottle Fermented) Marche VENETO Palinieri “Sant’Agata” Lambrusco Sorbara ’18 32 Suavia “Massifitti” ‘16 55 Lambrusco Sorbara Trebbiano di Soave Quaresimo Lambrusco (Frizzante) NV 36 Pieropan Soave Classico “Calvarino” ‘16 58 Lambrusco (Biodynamically farmed in Garganega Emilia Romagna!) EMILIA ROMAGNA Ancarani “Perlagioia” ‘16 42 Vini Spumanti Dolci (Sweet) Albana Ancarani “Famoso” ‘16 42 Spinetta Moscato d’Asti (.375) 2017 23 Famoso di Cesena Moscato Ca Dei Quattro Archi “Mezzelune” (Orange) 50 Marenco Brachetto d’Acqui (.375) 2017 23 Albana Brachetto MARCHE Vini Bianchi San Lorenzo “di Gino” Superiore ‘17 42 Verdicchio dei Castelli di Jesi ALTO ALDIGE CAMPANIA Abazzia Novacella ‘17 42 Benito Ferarra Terra d’Uva ‘17 45 Gruner Veltliner Ribolla Gialla Abazzia Novacella ‘17 42 Ciro Picariello BruEmm ‘17 45 Kerner Falanghina Terlano Terlaner ‘17 60 San Giovanni “Tresinus” ‘15 45 Pinot Bianco, Sauvignon Blanc, Chardonnay Fiano Terlano Vorberg Riserva ‘17 90 Pinot Bianco SICILIA Terlano Rarity 2005 250 Planeta “Eruzione” ‘16 68 Pinot Bianco Carricante, Riesling Tieffenbrunner “Feldmarschall” ‘15 75 CORSICA Müller Thurgau Dom. -

Vini Italiani
VINI ITALIANI By the glass By the bottle spumanti | SPARKLING spumanti | SPARKLING Prosecco NV, Serafni & Vidotto, Veneto 14 56 Franciacorta NV, Ca del’Bosco, Lombardia 29110 75 Trento DOC NV, Ferrari, Trentino-Alto Adige 16 64 Prosecco Superiore Col Fondo, Ca dei Zago 75 Veneto 29052 Franciacorta “Coupe” NV, Monte Rossa, Lombardia 18 72 Lunelli Riserva 2006, Ferrari, Trentino-Alto Adige 29059 130 Alta Langa Rosato 2012, Fontanafredda, Piemonte 20 80 Moscato d’Asti 2018, Il Pavone, Piemonte 12 48 bianchi | WHITES Pacherhof Riesling 2017, Trentino-Alto Adige 25832 80 bianchi | WHITES Monterotondo Gavi 2016, Villa Sparina 95 Friulano “Orsone” 2018, Bastianich, Friuli 12 48 Piemonte 10815 Roero Arneis “Pradalupo” 2018, Fontanafredda 18 72 Collio 2016, Borgo del Tiglio, Friuli 28837 95 Vespa Bianco 2016, Bastianich, Friuli 20 80 (Chardonnay, Sauvignon, Picolit) Paolo Bea, Arboreus 2012, Umbria 100 (Trebbiano Spoletino) 24809 Derthona “Timorasso” 2018, Borgogno, Piemonte 25 100 Benefizio 2018, Frescobaldi, To s ca na 11814 115 (Chardonnay) arancio | ORANGE Pinot Grigio Ramato, Attems, Friuli 14 56 Ca del Merlo Bianco 2018, Quintarelli, Veneto 27803 115 Ageno 2015, La Stoppa, Emilia-Romagna 12800 125 rosati | ROSÉS Nosiola 2017, Foradori, Trentino-Alto Adige 24851 145 Langhe Rosato “Solerose” 2019, Fontanafredda 14 56 Etna Bianco 2015, Benanti Pietramarina, Sicilia 23831 195 Piemonte (Nebbiolo) Rossj-Bass 2017, Gaja, Piemonte (Chardonnay) 10828 250 rossi | REDS Trebbiano 2015, Valentini, Abruzzo 15806 295 Chianti “Mama”, Certosa di Belriguardo, -

Salumeria- Cured Meats.Cured Cheeses.Meats and from Cheeses Italy from and Italy the and Usa
LLAA PIPIAZZAZZAA wine bbaarr epanded shapes -SALUMERIA- CURED MEATS.CURED CHEESES.MEATS AND FROM CHEESES ITALY FROM AND ITALY THE AND USA. THE US TAGLIERI | ON THE BOARD Served with housemade mostarda and amaretto honey ORDER AN OFF-MENU BOTTLE, TAGLIERE PICCOLO | 19 GET A SPREAD OF ITALIAN BITES! Chef’s selection of 3 meats and 3 cheeses LEAVE YOUR WORK DAY BEHIND AND TAKE A TRIP TAGLIERE GRANDE | 24 TO A VIBRANT SQUARE IN ITALY! Chef’s selection of 5 meats and 5 cheeses First, our expert sommelier will quench your thirst and select a special off-menu bottle of vino bianco or vino rosso for you. TAGLIERE RISERVA | 34 In the mood for something even more lively? Enjoy a traditional, large-format spritz to Harbison, Jasper Hill Farm, Casella’s Prosciutto, share with your amici! And of course, the perfect evening in an Italian square is not one Greensboro Bend, VT Hurleysville, NY without good, high quality food. Pasteurized cow milk aged 6-13 weeks American made, Italian methods With each bottle or spritz you order, enjoy a complimentary spread of Italian bites. Ask your server for today’s selection—let’s drink! Pecorino Calcagno, Negroni culatello di Sardegna, Italy zibello D.O.P, Cave aged for 1-2 years Parma, Emilia-Romagna, Italy Cured pork leg, aged for 12 months mozzarella BAR -Crudo di Mare- Served simply with extra virgin olive oil & sea salt Made fresh daily at our cheese counter. Raw Bar. Oysters. Clams. Bring some home after your meal — it’s BY CLASSICA | 11 just a few steps away! BARBARA LYNCH housemade fior di latte mozzarella LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP | 16 Oysters and fresh crudo AntichE bontà Buffalo mozzarella from campania Eataly’s rotating selection of local oysters is curated by Island Creek Oysters in Duxbury, MA.