Epoche Remote
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
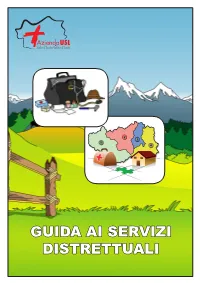
Guida Ai Servizi Distrettuali
GUIDA AI SERVIZI DISTRETTUALI 1. INTRODUZIONE I Distretti sono gli ambiti organizzativi territoriali per l’effettuazione di attività e l’erogazione di prestazioni di assisten- za sanitaria, di tutela e di promozione della salute, di prestazioni socio sanita- rie, di erogazioni dei servizi e delle prestazioni socio as- sistenziali, di integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali. IL DISTRETTO È COSTITUITO AL FINE DI GARANTIRE: • l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenzia- le mediante il necessario coordinamento tra medici di medi- cina generale, pediatri di libera scelta, servizi di continuità assistenziale notturna e festiva, medici specialistici ambula- toriali • Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pe- diatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, nonchè con i servizi specialistici ambulatoriali ed i presidi ospedalieri ed extra ospedalieri accreditati • l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione • l’assistenza specialistica ambulatoriale • l’attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze • l’attività consulenziale per la tutela della salute dell’infan- zia, della donna e della famiglia • l’attività ed i servizi rivolti ai disabili e agli anziani 3 • l’attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata • l’attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patolo- gie terminali Al fine di garantire le attività ed i servizi sopradescritti i Distretti fanno capo ad un Direttore coadiuvato dai coordina- tori dei seguenti profili professiona- li: amministrativi, infermieri, direttore fisioterapisti, logopedisti, assistenti sanitari, oste- triche. L’integrazione fra le attività svolte dagli operatori afferenti al Distretto con gli al- tri servizi sanitari e sociali, caratterizza l’attività distrettuale. -

CURRICULUM VITAE DI PARISIO FERRUCCIO Aggiornato All’ 12/10/2015
CURRICULUM VITAE DI PARISIO FERRUCCIO Aggiornato all’ 12/10/2015 INFORMAZIONI PERSONALI Nome e cognome Ferruccio PARISIO Data di nascita 06 luglio 1951 Qualifica Iscritto all’albo regionale dei Segretari della Valle d’Aosta Amministrazione Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La- Trinité, Gaby, Issime. Incarico attuale Titolare delle sedi di segreteria di Gressoney- Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby, Issime Numero telefonico dell’ufficio Gressoney-Saint-Jean 0125 355192 Gressoney-La-Trinité 0125 366137 Gaby 0125 345932 Issime 0125 344033 Numero di fax dell’ufficio Gressoney-Saint-Jean 0125 355673 Gressoney-La-Trinité 0125 366089 Gaby 0125 345078 Issime 0125 344116 E-Mail privata [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] E-Mail istituzionale certificata [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ESPERIENZA LAVORATIVA Titolo di studio Diploma di geometra conseguito nel 1971 ad Aosta con votazione 45/60; Laurea in Architettura conseguita nel 1980 a Torino con votazione 110 e lode. Altri titoli di studio e professionali Iscrizione all’Albo regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d’Aosta con deliberazione dell’Agenzia regionale dei segretari della Valle d’Aosta n. 5 del 05/02/2002. Esperienze professionali 1. Impiegato alla ditta “Olivetti” di Ivrea (TO) dal 1964 al 1976 2. Segretario della Comunità Montana “Valchiusella” (TO) dall’agosto del 1981 al gennaio 1983. 3. Segretario della Comunitàˆ Montana “Dora Baltea Canavesana” (TO) dal marzo del 1982 al giugno 1983. -

Il Saluto Del Sindaco
le notizie dall’amministrazione comunale i l s a l u t o d e l s i n d a c o ari concittadini, sono tra- scorsi quasi 5 anni da Cquando ho avuto la for- tuna e l’onore di essere stato eletto da Voi, Sindaco del pae- se nonché tra i più giovani del- la Valle d’Aosta. Conscio della carenza di esperienza politico amministrativa, non avendo pri- ma ricoperto alcun incarico in seno all’Amministrazione, con entusiasmo e serietà ho cerca- to di impegnarmi il più possibi- le per dare risposte alle Vostre esigenze. rappresentato una novità per trasporto pubblico, preveden- Ho voluto essere quanto mai il paese. Per i giovani ci siamo do più corse e la realizzazione più possibile vicino a Voi per impegnati affinché le scuole di nuove fermate in fraz. Se- ascoltare consigli ma anche primarie e dell’infanzia fosse- mon/Tsesanouva e Lezin e la critiche o lamentele, per cer- ro più decorose, accoglienti e dismissione del tratto Clapey/ care di capire quali fossero le sicure, perché essi possano Banchet. Ciò che accomuna i priorità da affrontare o i biso- utilizzare a breve finalmen- giovani, gli anziani e le famiglie gni da soddisfare. Ho cercato te l’area sportiva di Mésaney è la sensibilità, la volontà e la di essere quanto più tempesti- destinata al tennis, calcetto possibilità mostrata da que- vo nell’agire insieme alla mia e pallavolo, perché essi pos- sta giovane Amministrazione valida squadra di collaboratori, sano beneficiare nella stessa nell’adottare un “pacchetto che mi ha sempre sostenuto zona di un campo scuola per la anti crisi comunale”. -

Elenco Corsi E Specchi D'acqua Suddivisi Per
ALLEGATO N. 2 AL CALENDARIO ITTICO PER L’ANNO 2021 ELENCO CORSI E SPECCHI D’ACQUA SUDDIVISI PER GIURISDIZIONE FORESTALE GIURISDIZIONE FORESTALE DI ANTEY – SAINT – ANDRE LAGHI: . BLEU – VALTOURNENCHE . CHARREY – LA MAGDELEINE . CIGNANA – VALTOURNENCHE . CORTINA – VALTOURNENCHE . CROUX – LA MAGDELEINE . GOILLET – VALTOURNENCHE . LOD – ANTEY . LOTZ O LOZ – VALTOURNENCHE . LOU – CHAMOIS . TRAMAIL - VALTOURNENCHE TORRENTI: . CERVINO – VALTOURNENCHE . CHAMOIS – CHAMOIS . CHENEIL – VALTOURNENCHE . CIGNANA – VALTOURNENCHE . CLEYVA GROUSSA . EUILLA – VALTOURNENCHE . FONTANA PERRERES – VALTOURNENCHE . GLAIR – VALTOURNENCHE . GOLF – VALTOURNENCHE . LO DU TOR – TORGNON . LOSANCHE – VALTOURNENCHE . PETIT MONDE – TORGNON . PROMIOD - ANTEY . ROMBEROD – ANTEY GIURISDIZIONE FORESTALE DI AOSTA LAGHI: . ARBOLLE O COMBOE’ – CHARVENSOD . CHAMOLE’ – CHARVENSOD . DELLE FOGLIE – SARRE . FALLERE – SARRE . GELE’ - CHARVENSOD . MORTO – SARRE TORRENTI: . COMBOE’ – CHARVENSOD . ARPISSON – POLLEIN . BAGNERE – NUS/AOSTA . BUTHIER . CLUSELLA – SARRE . DORA BALTEA – SARRE/CHAMBAVE . FONTANE DI POLLEIN – POLLEIN . RU BAUDIN – CANALE IRRIGUO AOSTA . SORGIVE TSA DELLA COMBA - SARRE . VACHERIE O GRESSAN - GRESSAN GIURISDIZIONE FORESTALE DI ARVIER LAGHI: . BEAUREGARD – VALGRISENCHE . FOND – VALGRISENCHE . SAN GRATO – VALGRISENCHE . TZUILE – VERTOSAN - AVISE . ZOU (VASCA DI CARICO) – SAINT NICOLAS TORRENTI: . DORA BALTEA – LA SALLE/AYMAVILLES . DORA DI VALGRISENCHE . FOND – VALGRISENCHE . FONTANE DI PLANAVAL – VALGRISENCHE . GRAND’ALPE O COL DU MONT – VALGRISENCHE . GRAND’HAURY -

22E RENCONTRE VALDOTAINE
22e RENCONTRE VALDOTAINE Valgrisenche, le 1O aoút L997 Programme Matinée 10 h Accueil des parLicipants 10 h 3O Messe en l'église Saint-Grat célébrée par Don Pellissier, avec la parLicipation de la chorale de Valgrisenche lf h 3O Dépót de la gerbe au monument aux morts 11 h 45 Visite de I'exposition o Les cols d'antan o à la chapelle de Mondanges 13 h Déjeuner sous le chapiteau au lieu-dit Place de Beauregard Après-midi 15 h Inauguration de la paroi d'escalade (face Nord du barrage de Beauregard) et démonstration de free climbing Expositions: Les cols d'antan (Chapelle de Mondanges) La Vallée des Reines (Chef-lieu) Visite de la Coopérative "I.es Tisserands" (Chef-lieu) Visite de la Cave d'affinage de la Fontina (Chef-lieu) Tour du barrage Animation folklorique par les '"Trouveur Valdoten" 19 h Départ des autocars. HORATRE DES AUTOCARS Départ de Pont-Saint-Martin Départ de Gaby Départ de Saint-Rhémy-en-Bosses Pont-Saint-Martin 7h30 Gaby 7h Saint-Rhémy 8h15 Donnas 7h35 Issime Zh05 Bosses (croisement) th21 Bard 7}J40 Fontainemore 7};'l2 Saint-Oyen th26 Arnad 7h.47 Lillianes 7hL7 Etroubles 8h31 Verrès 7h53 Tour d'Héréraz 7h23 La Clusaz 8h36 Montjovet 8h00 Pont-Saint-Martin 7h36 Gignod 8h46 Champérioux 8h09 Donnas 7h4L Variney(croisement) 8h51 Saint-Vincent 8h14 Bard 7}:.45 Aoste CVilta Cometto) 8h59 Chàtillon 8h19 Arnad 7h51 Aoste (hópital) th02 Pontey 8h23 Verrès 7h56 Sarre th12 Chambave th27 Montjovet 8h03 Saint-Pierre th17 8h32 8h11 Villeneuve th20 ,Champagne Champérioux l.[us 8h36 Saint-Vincent 8h16 Arvier th25 Saint-Marcsl (pont) 8h40 -

Tabelle Scuola Infanzia
Tabella A ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA VALLE D’AOSTA ADEGUATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE E DI SOSTEGNO POSTI POSTI DI ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNI SOSTEGNO SAN FRANCESCO – AOSTA 13 2,5 scuole Aosta–Gianni Rodari; Aosta–Excenex; Aosta–Signayes ST-ROCH – AOSTA 14 0,5 scuole Aosta–Via Antica Vetreria; Aosta–Via Avondo; Aosta–Quartiere Dora LUIGI EINAUDI - AOSTA 12 0,5 scuole Aosta- C.Gex; Aosta-Porossan EMILE LEXERT - AOSTA 13 1 12 scuole Aosta–Quartiere Cogne; Aosta–S. Allende EUGENIA MARTINET - AOSTA 13 1 scuole Aosta–O. Marcoz; Aosta–Saint-Martin de Corléans VALDIGNE MONT-BLANC – MORGEX 19 0,5 scuole Courmayeur; La Salle–Derby; La Thuile; Morgex; Pré-Saint-Didier JEAN-BAPTISTE CERLOGNE – ST-PIERRE 29 2 scuole Aymavilles; Saint-Nicolas; Saint-Pierre; Sarre–"C. Blanc"; Sarre–"O. Bérard"; Sarre–"V. Bernin" MARIA IDA VIGLINO – VILLENEUVE 12 0,5 Arvier; Avise-Runaz; Cogne; Introd; Rhêmes-Notre-Dame-"Don Aristide Jean Alexis Blanchet"; Rhêmes-Saint-Georges; scuole Valgrisenche;Valsavarenche; Villeneuve Unité des Communes Valdôtaines GRAND COMBIN – GIGNOD 15 0,5 scuole Doues; Etroubles; Gignod; Oyace (Camille Vuillermin); Roisan; Valpelline Unité des Communes Valdôtaines MONT EMILIUS 1 – NUS 15 2 scuole Fénis; Nus; Saint-Marcel Unité des Communes Valdôtaines MONT EMILIUS 2 – QUART 21 1 scuole Brissogne; Quart–Chantignan; Quart–Villair; Saint-Christophe–Bret; Saint-Christophe–Pallein Unité des Communes Valdôtaines MONT EMILIUS 3 – CHARVENSOD 21 -

Tribunale Di AOSTA
copia gratuita numero 50 aprile 2020 www.tribunale.aosta.giustizia.it www.astalegale.net VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI Tribunale DI AOSTA quattro piani fuori terra di cui NUS (AO) - VIA telematica sincrona mista. Abitazioni e box due seminterrati e n. 5 terreni RIMEMBRANZA, 2 - G.E. Dott. P. De Paola. circostanti la suddetta APPARTAMENTO al piano Professionista Delegato MONTJOVET (AO) - villa. Valore di perizia Euro terreno composto da alla vendita e Custode FRAZIONE CHOSALEY, 7 222.145,00. Prezzo base soggiorno con angolo Giudiziario Dott. Giovanni - Fabbricato con accesso Euro 50.982,29. Offerta cottura, tre camere, Favre tel. 0165238328. Rif. tramite strada privata, minima: Euro 38.236,72. disimpegno, bagno e RGE 57/2018 AA686124 suddiviso in tre subalterni Vendita senza incanto portico; con annessa PONTBOSET (AO) - uno di civile abitazione e due 08/05/20 ore 09:30. Vendita cantina al piano interrato FRAZIONE CAPOLUOGO, in corso di costruzione con con modalità telematica oltre terreno pertinenziale. SNC - QUOTE IMMOBILIARI destinazione rurale. Valore sincrona mista. Per maggiori Valore di perizia Euro DI TERRENI AGRICOLI E DI di perizia Euro 159.000,00. informazioni relative alla 97.666,80. Prezzo base Euro FABBRICATI (2 alloggi, 2 box, gara telematica consultare Prezzo base Euro 74.715,10. Offerta minima: 11 depositi e 2 collabenti) il sito www.spazioaste. 121.635,00. Offerta minima: Euro 56.036,33. Vendita e mobilio. Valore di perizia it. G.E. Dott. P. De Paola. Euro 91.226,25. Vendita senza incanto 29/04/20 ore Euro 55.720,00. Prezzo Professionista Delegato senza incanto 29/04/20 ore 09:00. -

Table S1. List of the Monitored Municipalities in Aosta Valley in 2015–2019
Supplementary Table S1. List of the monitored municipalities in Aosta Valley in 2015–2019. 2015 2016 2017 2018 2019 No. No. No. No. No. Municipality Altitude Altitude Altitude Altitude Altitude Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- (m asl) (m asl) (m asl) (m asl) (m asl) baited traps baited traps baited traps baited traps baited traps Allein 1 1310 1 1 1310 1 1 1310 1 1 1310 1 Antey - Saint - Andre 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 Aosta 3 878 - 1287 42 6 878 - 1535 45 7 932 - 1535 28 7 932 - 1535 28 7 932 - 1535 28 Arnad 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 Arvier 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 Avise 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 Aymavilles 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 Brusson 1 1127 1 1 1127 1 1 1127 1 1 1127 1 Challand - Saint - Anselme 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 Challand - Saint - Victor 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 Chambave 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 Champdepraz 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 Charvensod 1 690 1 1 690 1 1 690 1 1 690 1 Chatillon 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 Donnas 1 580 1 1 580 1 1 580 1 1 580 1 Doues 1 1125 1 1 1125 1 1 1125 1 1 1125 1 Emarese 3 911 - 1288 3 3 911 - 1288 3 4 911 - 1288 4 4 911 - 1288 4 Etroubles 1 1325 1 1 1325 1 1 1325 1 Fenis 1 1031 1 2 1031 - 1085 2 2 1031 - 1085 2 2 1031 - 1085 -

1006 Verbale Di Deliberazione Adottata Nell'adunanza in Data 18 Luglio 2014 LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'aosta Partecipano
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL DIRIGENTE ROGANTE Augusto ROLLANDIN Massimo BALESTRA Gouvernement régional Giunta regionale Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 luglio 2014 ________________________________________________________________________________________________ In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo REFERTO DI PUBBLICAZIONE piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1, Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi. LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA Aosta, lì IL DIRIGENTE Partecipano alla trattazione della presente deliberazione : Massimo BALESTRA Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN ________________________________________________________________________________________________ e gli Assessori Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Mauro BACCEGA Luca BIANCHI Antonio FOSSON Pierluigi MARQUIS Ego PERRON Emily RINI Renzo TESTOLIN Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA E' adottata la seguente deliberazione: N° 1006 OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE, A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI, DI AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 3 GENNAIO 2006, N. 3. FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE RISORSE PRESENTI NEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE PRESSO LA FINAOSTA S.P.A. DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L.R. 7/2006. LA GIUNTA REGIONALE vista la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, concernente “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia”, ed in particolare l’articolo 5, relativo alle iniziative ammesse alle agevolazioni finanziarie, e gli articoli 11, 12 e 13, relativi ai procedimenti istruttori; vista la legge regionale 16 marzo 2006, n. -

09-Cyclotour-Fietsroutes.Pdf
PONT-SAINT-MARTIN , CICLOTOUR 01 Pont-Saint-Martin – Gressoney-La-Trinité Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Pont-Saint-Martin (Piazza IV Novembre) Arrival: Gressoney-La-Trinité (End of road - Staffal) Difference in level: 1473 m Length 38,2 Km Duration going there: 2h10 The Val de Gressoney is the first you meet as you enter Val d’Aosta if you are coming from the Po Valley. The Valley starts at Pont-Saint-Martin and is wedged into a narrow corridor which then opens out in the sight of Monte Rosa, a spectacular mountain with 28 peaks above 4,000 metres and which is the natural boundary with Switzerland. Places you go through on the route: - Pont-Saint-Martin (345 m) - Lillianes 6.1 km (650 m) - Fontainemore 9.1 km (785 m) - Issime 12 km (950 m) - Gaby 17.4 (1,045 m) - Gressoney-Saint-Jean 25.2 km (1,420 m) - Gressoney-La-Trinité 33.3 km (1,640 m) - Stafal 38.2 km (1,800 m) Route included in a stage of the Giro d'Italia in 1995 (Briançon/Gressoney). Stage won by Ouchakov (UCR) VERRÈS , CICLOTOUR 02 Verrès – Saint-Jacques (Ayas) Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Verrès (Roundabout on the SS26 road) Arrival: Saint-Jaques (Ayas, end of road) Difference in level: 1301 m Length 31,6 Km Duration going there: 2h08 From Verrès you make your way upwards along the wide, sunny Valle d'Ayas which climbs 32 km alongside the mountain river of Evançon. The first town you come to is Challand-Saint-Victor where you can visit the remains of Villa Castle from the 10th century. -

Châteaux De La Vallée D'aoste
CHÂTEAUX DE LA VALLÉE D AOSTE A journey through’ history, art and nature The castles From the twelfth century, the local of the lords constructed fortified buildings for defensive purposes, such as the castles Aosta Valley: of Graines, Châtel-Argent and Cly, which perfectly exemplify the oldest style a thrilling journey of castle architecture. through time However, from the fourteenth century onwards, the architectural features serving to defensive purposes were superseded by monolithic structures, such as those of the castles of Ussel and Verrès, which were then gradually embellished with decorative features, as can be observed at the famous A significant and rich cultural heritage Fénis Castle among others. made up of castles, strongholds The stylistic evolution of the fortressin and historic buildings welcomes to a fine manor house is evident in the those visiting the Aosta Valley castles of Aymavilles and Issogne, whereas or travelling through. the abodes of Sarre and Savoy Castle of Indeed, the many castles scattered Gressoney-Saint-Jean are testimonies to along the region’s central valley the presence of the Savoy dynasty in the are of outstanding Aosta Valley and the artistic taste in vogue beauty and cultural interest. in that court. Built in strategic places to defend ancient lands, these castles In the summer, the magic of this places with their variety of styles is even greater as the castles become and architectural features are spectacular scenery for emotionally a valuable testimony to the history charged musical events. Guests are treated of the Aosta Valley. to refined and exclusive evenings as the events feature artists of national and international caliber. -

Aosta Brissogne Charvensod Fénis Gressan Jovençan Nus •St
Sant’Orso fair Sankt Orso-Messe Matterhorn Tourist Aosta Mont Blanc Office Brissogne Aosta roman and Charvensod medieval town Monte Rosa Tourismusbüro Aosta römische und Fénis mittelalterliche Stadt Astronomic observatory Gressan Astronomische Observatorium Aosta Jovençan P.zza Chanoux, 2 Nus • St-Barthélemy C E R V I N O 11100 Aosta Tel (+39) 0165 236627 Pila M O N T E Fax (+39) 0165 34657 A N C O Breuil-Cervinia R O Pollein B I Col / Tunnel du S E A [email protected] T Tunnel du Grand-Saint-Bernard N Quart O Mont-Blanc M Valtournenche Gressoney Pila e Saint-Christophe ll La Trinité a St-Rhémy-en-Bosses étroubles Seasonal opening D f. f. Saint-Marcel Ayas • Courmayeur Valpelline Saisonbedingt geöffnet SPA Sarre 11020 Gressan (Ao) a Gressoney-St-Jean L Pré-Saint-Didier St-Barthélemy PI AOSTA Tel. (+39) 0165 521008 ITA Sarre Châtillon Brusson L [email protected] RISA La Thuile i Col du Fénis St-Vincent D Petit-Saint-Bernard Pila C AVI T IMPIANTI N O • M L Verrès E D O Issogne C Cogne R A Valgrisenche P Bard Office Régional Champorcher Valsavarenche du Tourisme Rhêmes-Notre-Dame O DIS P A A AR Pont-St-Martin Ufficio Regionale R N P CO RA NAZIONALE G del Turismo Torino turistici operatori consorzi • Milano V.le Federico Chabod, 15 Genova G 11100 Aosta R A O Spas N P A R A D I S Therme 360° view over the whole chain of the Alps Gran Paradiso 360° Aussicht auf die gesamte Alpenkette Fénis (1), Issogne (2), Verrès (3), www.lovevda.it Traverse of Sarre (4) castles and Mont Blanc Bard Fortress (5) Überquerung des Schlösser Fénis (1), Issogne