Aonio Paleario E La Riforma Religiosa in Italia: Cap
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Catalogo Astegiustizia Maggio2
TUTTE LE SCHEDE DELLE VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI CON DATE, ORARI, DISPOSIZIONI GENERALI, DESCRIZIONI COMPLETE, ORDINANZE, PERIZIE, FOTO, FILMATI SU: WWW. ASTEGIUSTIZIA.IT VENDITE IN SALA SABATO 5 MAGGIO 2018 INIZIO mattina dalle ore 10:00 - pomeriggio dalle ore 15:00 Arezzo via Ferraris 136 Esposizione dei lotti Mercoledi 2 - Giovedi 3 - Venerdi 4 Maggio ore 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 AVVISO LE GARE SU INTERNET IN CONTEMPORANEA: è possibile partecipare anche tramite la "Gara in contemporanea", ovvero una gara che mette in competizione gli utenti iscritti preventivamente sul sito di gare online www.spazioaste.it e gli astanti personalmente presenti in sal a. Per seguire in diretta audio/video la tornata di aste sarà sufficiente collegarsi alla pagina "AsteGiustizia.it" su Facebook oppure sulla Homepage WWW.ASTEGIUSTIZIA.IT PER CHI PARTECIPA DA COMPUTER SCADENZA ISCRIZIONI con bonifico mercoledì 2 Maggio alle 18.00 collegandosi sul sito SPAZIOASTE.it SCADENZA ISCRIZIONI con carta di credito sabato 5 Maggio alle 10.00 lotti mattina | ore 14.00 lotti pomeriggio PER PARTECIPARE DALLA SALA NON È RICHIESTA NESSUNA ISCRIZIONE PREVENTIVA. ELENCO LOTTI IN GARA Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo 1 2 3 4 5 6 Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 60,00 € 0,00 Rif. 11) Madia da pane Rif. 19) Tavolo in ferro Rif. A) Coppia di alari in Rif. -

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato
MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

Valdichianasenese AUTENTICA PER NATURA
UN MONDO DI IDEE ORIGINALI PER VIAGGIARE SAPORI AUTENTICI OLIO, VINO CHIANINA E PECORINO PAESAGGI A TU PER TU CON LA NATURA SUPPLEMENTO AL NUMERO LUG-AGO 2020 BENESSERE TOTALE SALUS PER AQUAM STORIE DI BORGHI COMUNI FUORI DAL COMUNE Bellezza infinita Valdichiana Senese IN COLLABORAZIONE CON SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 1 SUPPLEMENTO AL NUMERO 4 - ANNO II - LUG-AGO 2020 Valdichiana Senese Explore LA COVER DI QUESTO NUMERO Colline ricamate da curve e cipressi, il verde e l’oro di olivi e campi di grano, AUTENTICA architetture che rimandano PER NATURA all’antica vocazione rurale: 5 Una galassia di sapori un’immagine “iconic” della Valdichiana Senese, Nobili vini e prodotti veraci quintessenza del buon 7 Immersi nella natura vivere toscano tra storia e Ognuno al proprio ritmo storie, benessere e armonia. Un invito ad 8 Rigenerare le mente attraversarla on the road, e il corpo in bici o a piedi. O come volete, ad ognuno la propria scoperta. Di sé e di NOVE COMUNI un territorio straordinario FUORI DAL COMUNE 13 Cetona Visioni incantate 14 Chianciano Terme SCARICA Eccellenza del benessere 15 Chiusi L’EDIZIONE Scoperta continua DIGITALE 16 Montepulciano Sublime totale 17 San Casciano dei Bagni Immergersi nella bellezza 18 Sarteano Quintessenza di Toscana 19 Sinalunga Tuffo nell’arte 20 Torrita di Siena Una storia, mille storie 21 Trequanda Gemma rara GUIDA AL VIAGGIO 22 Dritte, consigli e segnalazioni IN COLLABORAZIONE CON 2 SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 3 RIGENERARSI | RITROVARSI | RISCOPRIRE L’ARMONIA A sinistra: vista sulle colline della Valdichiana Senese In basso: vacche della pregiata razza Chianina Nelle pagine seguenti: il pozzo dei Grifi e dei Leoni nella piazza Grande di Montepulciano, un’escursione in bici tra filari di sangiovese VALDICHIANASenese AUTENTICA PER NATURA INSEGUITE LA BELLEZZA DEI PAESAGGI DEI BORGHI CHE RACCONTANO, DELL’ARTE CHE HA PRESO ISPIRAZIONE DALLA NATURA, RENDENDOLA IMMORTALE epetita juvant, recita l’adagio latino. -

Campionato Eccellenza A
ATTIVITA’ CALCIO UISP SIENA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 Comunicato 3 del 18/10/2016 PROMOZIONE GIR. A EDIL SARDEGNA COLLIGIANA - MONTALLESE N.D.I.C. HELLAS TORRITA - CASTELNUOVO SCALO 0 - 0 VIRTUS CHIANCIANO 1945 - GRACCIANO 2 - 0 CASTELLINA IN CHIANTI - RADDESE 0 - 0 SALCHETO - SINALUNGA 0 - 0 POLISP. RIGOMAGNO - CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE 2 - 1 Disciplina Ammoniti: Federico Bisti (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE); Duccio Fontana (CASTELLINA IN CHIANTI); Davide Sorace, Nicola Lachi, Nfally Colley, Yunus Gittteh (CASTELNUOVO SCALO); Andrea Bianchini, Guido Roggi, Federico Ciolfi (HELLAS TORRITA); Riccardo Donzellini, Stefan Andrei Sabin, Alberto Farsetti, Gioele Mazzetti (POLISP. RIGOMAGNO); Luca Ruscelli (RADDESE); Michele Rosignoli, Marco Falvo (SALCHETO); Carlo Massai, Michael Medico (SINALUNGA); Valdson Cerqueria Da Silva (VIRTUS CHIANCIANO 1945). Diffide: Gaetano Bellavia (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE); Richard Arthur (GRACCIANO). Una giornata: Andrea Malacarne ART. 128 R.D. (SALCHETO). Sanzioni squadre: POLISP. RIGOMAGNO (€ 10,00 ART. 102 R.D.). Classifica Punti Gio Vin Par Per Gol: Fat Sub C.D. 1 - RADDESE 4 2 1 1 0 3 1 1 2 - HELLAS TORRITA 4 2 1 1 0 2 0 8 3 - MONTALLESE 3 1 1 0 0 3 2 6 4 - POLISP. RIGOMAGNO 3 2 1 0 1 4 4 13 5 - VIRTUS CHIANCIANO 1945 3 2 1 0 1 3 3 1 6 - CAFFE' CENTRALE M.NO STAZ. 3 2 1 0 1 3 3 7 7 - SINALUNGA 2 2 0 2 0 1 1 3 8 - CASTELLINA IN CHIANTI 2 2 0 2 0 1 1 5 9 - CASTELNUOVO SCALO 2 2 0 2 0 0 0 4 10 - EDIL SARDEGNA COLLIGIANA 1 1 0 1 0 0 0 2 11 - SALCHETO 1 2 0 1 1 1 2 9 12 - GRACCIANO 0 2 0 0 2 0 4 4 Marcatori 3 reti: FANTI PIETRO (VIRTUS CHIANCIANO 1945); 2 reti: GUEYE PAPA OMAR (POLISP. -
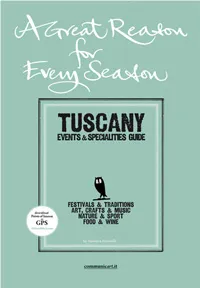
Preview Eng 2012.Pdf
Copyright © 2011 by Communicart.it – Firenze Printed by : Industria Grafica Pistolesi – Ed Il Leccio srl. Via della Resistenza, 117- Loc.Badesse Monteriggioni (Siena) Author: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) Concept Design: Arch. Nicola Natalizio Cover Calligraphy: Betty Soldi Editing Team Veronica Ficcarelli, Bess Melendez , Nina Brown, Rachel Mascetta Translation: Bess Melendez, Nina Brown , Rachel Mascetta Photographs: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) with the unique contribution of Rachel Mascetta & Dave Yoder Printed in February 2012 by Industria Grafica Pistolesi – Siena map of Tuscany __ 6 __ __ 7 __ Remembering Santa Lucia, One of the most magical places in Tuscany. For me, and for my friends from all over the world - a perfect place. “E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il lungo corso dei fiumi, e l’immensità dell’Oceano, ed il volgere degli astri... e si dimenticano di se medesimi” (Men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty billows of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, and pass themselves by) Sant’Agostino This book is dedicated to Mochy , my dog the best everything ever had in my life for over 17 years __ 8 __ __ 9 __ __ HOW TO CONSULT THE GUIDE __ Content Introduction Dedicated sections on Spring, Summer, Fall & Winter Events: Celebrations & Traditions; Art, Crafts & Music; Food & Wine; Nature & Sport Tuscan Specialties from the Producers’ Point of View: Tradition, Handicraft, -

REGISTRO Persone Giuridiche .Pdf
NUM. CODICE CODICE COD. FISC. DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO RAPPR. LEGALE REGISTRO COMUNE PROVINCIA RAPPR.LEGALE Ist. Interdiocesano per il sostentanento del clero di Siena-Colle di Val d'Elsa- Via di Città n. 146 Belli Fabio e BLLFNC45C09I726U 92003400527 052032 052 Montalcino e Abbazia territoriale di Siena Nencini Pietro NNCPTR64L31C847W 1 Monteoliveto Maggiore Via Pesanella n. 68 Fondazione Alimondo Ciampi Onlus 94051520487 052023 Ciampi Daniele CMPDNL55T14859L Radda in Chianti " 2 Fraz. Contignano - Mons. Icilio Parr. S. Maria Assunta 052040 " RSSCLI28S25H790W 3 Radicofani Rossi Via San Michele n. Don Sensano Parr. S. Maria della Stella 11 Chianciano 052009 " Carlo 4 Terme Giovannino Ist.Diocesano per il sostentamento del Via Fiorenzuola clero della Diocesi di Montepulciano 704650522 vecchia n. 2 052015 " Marchi Mario 5 Chiusi Montepulciano Via Berardenga n. 29 Villa Chigi - Assoc. Nazion. Città del vino 702220526 052006 Pioli Giampaolo PLIGPL48M17G687W Castelnuovo " 6 Berardenga Via Banchi di Sotto Mancini Fondaz. Monte dei Paschi di Siena 92035830526 052032 n. 34 Siena " Gabriello 7 Via di Città n. 89 Mancini Accademia musicale Chigiana 68580521 052032 PLIGPL48M17G687W 8 Siena " Gabriello Mons. Arcidiocesi di Siena , Colle di val d'Elsa Piazza Duomo n. 6 80009780521 052032 Buoncristiano BNCNTN43T20C527R e Montalcino" Siena " 9 Antonio c.f. Arcidiocesi Loc. Piana - Mons. Rosi Parr. S. Innocenzo a Piana 052003 RSOCLD55B15F676Q 10 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Via Soccini n. 151 Don Poddighe Parrocchia Santi Pietro e Paoli 052003 11 80009780521 Buonconvento " Gianfranco c.f. Arcidiocesi loc. Bibbiano - Mons. Rosi Parrocchia S. Lorenzo Martire 052003 RSOCLD55B15F676Q 12 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Loc Ponte d'Arbia - Mons. -

Studio Di Fattibilità Della Metropolitana Leggera Di Superficie Riferita Al Territorio Dello Schema Metropolitano Dell'area S
LdP Associati · Università di Siena Studio di fattibilità della metropolitana leggera di superfi cie riferita al territorio dello Schema Metropolitano dell’area Senese per le tratte: Siena - Monteroni d’Arbia e Siena - Asciano Comune di Siena Studio di fattibilità della metropolitana leggera di superfi cie riferita al territorio dello Schema Metropolitano dell’area Senese per le tratte: Siena - Monteroni d’Arbia e Siena - Asciano LdP Associati · architettura · urbanistica Antonio Mugnai Anna Calocchi Federica Turini Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali Stefano Maggi giugno 2006 Introduzione 5 Il contesto 9 Le ferrovie senesi 9 I tracciati ferroviari a sud 12 I lavori in corso di completamento sulle ferrovie senesi 16 Il rilancio delle reti su ferro 19 Alcune esperienze in Europa 20 Alcune esperienze in Italia 23 Le normative di riferimento per tranvie e ferrovie 29 Ipotesi di una metropolitana di superfi cie nelle tratte a sud di Siena 33 Defi nizione del potenziale bacino di utenza 33 Defi nizione delle tratte di esercizio 41 Individuazione delle fermate 44 Interventi sulle infrastrutture 51 Caratteristiche tecniche del vettore 53 Il servizio 59 Valutazioni economiche 69 Costi dell’intervento proposto e ipotesi gestionale 69 Valutazione degli indici del valore 76 Conclusioni 83 Appendice 87 4 Introduzione Sulla spinta della nuova “rivoluzione ferroviaria” rappresentata dall’alta velocità e sul modello delle realizzazioni estere di rilancio dei treni, anche in Italia sono in corso in diverse zone progetti per un recupero, adeguato ai tempi, della ferrovia e per la realizzazione di tramvie. I mezzi di trasporto guidato – essendo liberi dalla congestione del traffi co stradale – sembrano infatti gli unici in grado di dare una svolta alla mobilità a scala territoriale, da mezzo secolo lasciata in condizioni di pianifi cazione carente o del tutto assente, privilegiando il trasporto privato e causando guasti diffi cili da riparare. -

Comunicato Promozione Gir. A
ATTIVITA’ CALCIO UISP SIENA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 Comunicato 8 del 22/11/2016 PROMOZIONE GIR. A VIRTUS CHIANCIANO 1945 - CASTELLINA IN CHIANTI N.D HELLAS TORRITA - SALCHETO 2 - 0 EDIL SARDEGNA COLLIGIANA - POLISP. RIGOMAGNO 1 - 1 CASTELNUOVO SCALO - CAFFE' CENTRALE MONT.NO STAZ. 2 - 2 SINALUNGA - GRACCIANO 1 - 1 MONTALLESE - RADDESE 3 - 2 Disciplina Ammoniti: Giorgio Rocchi, Tommaso Fanari (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZ .); Ivo Rapetti, Omar Elshami (EDIL SARDEGNA COLLIGIANA); Gianluigi Sangermano (GRACCIANO); Nicolas Rossi (HELLAS TORRITA); Francesco Colombo (MONTALLESE); Fabio Roncucci (POLISP. RIGOMAGNO); Riccardo Butini, Matteo Sandrelli (RADDESE); Edoardo Galli (SALCHETO). Diffide : Brunelio Branca (CASTELNUOVO SCALO); Francesco Giacomazzo (EDIL SARDEGNA COLLIGIANA); Marco Graziani, Simone Di Pinto (GRACCIANO); Bernardo Graziani (HELLAS TORRITA). Una giornata: Luca Meuzzi ART. 127 R.D., Davide La Spisa ART. 127 R.D. (GRACCIANO); Manuel Marelli ART. 127 R.D. (MONTALLESE). Due giornate: Federico Bisti ART. 136 R.D. (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZ.); Davide Sorace ART. 136 R.D. (CASTELNUOVO SCALO); Santana Gabriel Leyba ART. 136 R.D. (GRACCIANO); Daniele Rappuoli ART. 136 R.D. (SINALUNGA). Classifica Punti Gio Vin Par Per Gol: Fat Sub C.D. 1 - MONTALLESE 16 7 5 1 1 22 11 29 2 - RADDESE 14 7 4 2 1 12 7 13 3 - EDIL SARDEGNA COLLIGIANA 12 7 3 3 1 8 9 27 4 - CASTELNUOVO SCALO 12 7 3 3 1 12 9 65 5 - POLISP. RIGOMAGNO 11 7 3 2 2 14 10 48 6 - SINALUNGA 10 7 2 4 1 5 5 27 7 - HELLAS TORRITA 10 7 3 1 3 9 8 28 8 - CAFFE' CENTRALE M.NO STAZ. -

Mese Di Marzo
STAGIONE CICLISTICA 2018 PROGRAMMA VALDICHIANA - VAL TIBERINA - TRASIMENO AMIATA CHIANTI - VAL D’ARNO - VAL D’ORCIA - CRETE SENESI RITROVO DI PARTENZA: CICLI MANCINI PARTENZA ANTICIPATA DI 30 MINUTI PREVIO ACCORDO È RICHIESTO L’USO DEL CASCO E IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA È RICHIESTO IL RISPETTO DELL’AMBIENTE: NON GETTARE CARTE, TUBOLARI, CAMERE D’ARIA O ALTRI RIFIUTI PER STRADA. STAGIONE CICLISTICA 2018 MARZO Sabato 03/03 ore 9:00 TAPPA N. 1 Palazzuolo - Badia a Ruoti Km. 95 Partenza, Castellina, La Croce, Monte San Savino, Palazzuolo, Badia a Ruoti, San Pancrazio, Monte San Savino, Pieve Vecchia, Croce di Lucignano, Arrivo Domenica 04/03 ore 9:00 La Foce A/R Sabato 10/03 ore 09.00 TAPPA N° 2 Chianciano Km. 83 Partenza, Oppiello, Chianacce, Montallese, Chianciano, Sant’Albino, Montepulciano, Poggio Colombi, Montefollonico, Madonnino dei Monti, Trequanda, Collalto, San Gimignanello, Rigomagno Stazione, Sinalunga, Arrivo. Domenica 11/03 ore 9:00 Puntabella Sabato 17/03 ore 09.00 TAPPA n° 3 Civitella-San Pancrazio Km 93 Partenza, Castellina, La Croce, M.te S.Savino, Badia al Pino, Civitella Val di Chiana, San Pancrazio, M.te S.Savino, Pieve Vecchia, La Croce, Arrivo. Domenica 18/03 ore 9:00 Castellina, La Croce, Lucignano basso, Rigomagno, Rapolano, Colonna di Grillo, Palazzolo, Monte S. Savino, La Croce, Arrivo. Sabato 24/03 ore 09.00 TAPPA n° 4 Verso la Cassia Km. 90 Partenza, Trequanda, Collalto, Asciano, Pecorile, San Giovanni d’Asso, La Toma, San Quirico, Pienza, Poggio Colombi, Montefollonico, Torrita di Siena, Arrivo. Domenica 25/03 ore 9:00 Montanare A/R Sabato 31/03 ore 9:00 TAPPA N. -

Si Fa Repubblica.Pdf
«Et neuna cosa, Quanto sia minima, può havere comminciamento o fine senza Sapere, senza Potere et senza con Amor volere» Fra Dionisio da Rigomagno XIII sec. Associazione Pro Loco Rigomagno «E ALLORA SI FA REPUBBLICA PER CONTO NOSTRO» Storia di Rigomagno, tra mito e leggenda, a 715 anni dalla fondazione testi: Ariano Guastaldi disegni: Giovanni Beduschi, Marco Fusi, Ariano Guastaldi Edizioni Luì Edizioni Luì Via G. Galilei, 38 - Chiusi (Siena) Stampato in Italia - Printed in Italy nello stabilimento Friulstampa Majano © 2007 Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione anche parziale di testi e disegni senza la preventiva autorizzazione degli autori [Dice fra Celso: “in ogni caso – e a prescindere – non sta bene copiare”] Premessa Nel progetto iniziale di questo libro non era prevista alcuna forma di prefazione. Lasciare libero il lettore di capire i nostri intendimenti, passo dopo passo, con lo scorrere dei capitoli, ci era sembrato il modo migliore, ed anche l’unico, per as- saporare il racconto. Concedere cioè il gusto della scoperta era, per noi, un fat- to positivo: un elemento qualificante. Però, a lavoro praticamente terminato, il dubbio della incompletezza si è fatto improvvisamente avanti, turbando le nostre notti con angosciose domande alle quali non riuscivamo a dare le giuste risposte, ad iniziare da quella più generale del chi ce lo avesse fatto fare. Nel frattempo una serie di inciampi avevano minato l’entusiasmo di alcuni ed i presupposti non facevano presagire niente di buono. Colti da una improvvisa mania distruttiva, siamo stati fermati appena in tempo (per fortuna o per disgrazia, dipende dai punti di vista) da cestinare il tutto, da un interessamento per così dire “esterno”. -

Asphalt, Dirt Road Type of Bicycle
CRETE - The Magic of Monte Sante Marie PERCORSO N° 1 Type of road: asphalt, dirt road Type of bicycle: MTB, hybrid For who it is: cycletourist, racer Point of departure and arrival: Asciano Length: 29.48 Elevation gain: 440 Difficulty: high Notes:This itinerary develops over the distance of 30 km., 17 of which are dirt and the rest being paved. It's not very long but the elevation gain isn't to be under estimated. In particular, the beautiful dirt road between Asciano and Monte Sante Marie has a couple of stretches which are pretty challenging. In the case of rain the stretch of road between Torre a Castello and Mucigliani could present real problems in that it's not covered in gravel but rather is of a clay base and becomes extremely slippery when wet. Description:From the center of Asciano you will leave in the direction of the cemetary which you can reach traversing the Ponte del Garbo bridge over the Ombrone river. Once at the cemetary you will proceed on the beautiful dirt road which, in a series of climbs and descents, comes to the "borgo" of Monte Sante Marie, about 7 km. From here the terrain becomes a little easier until reaching Torre a Castello (5 km) where the asphalt ends and you'll turn left, passing in front of a cheese producer called "La Fonte" which, by the way, sells a very good pecorino cheese. Follow the S.P. 8 downhill for 1 km. until reaching the dirt road that will be on your left, the path is marked with white and red paint and is identified with " number 501 Torre a Castello-Mucgliani". -

Itinerari 2018: I Borghi Di Sinalunga Dall’Affresco Al Paesaggio
ITINERARI 2018: I BORGHI DI SINALUNGA DALL’AFFRESCO AL PAESAGGIO SINALUNGA, SCROFIANO, FARNETELLA, RIGOMAGNO, BETTOLLE, LA FRATTA, L’AMOROSA I borghi di Sinalunga sono tutti presenti nel Palazzo Pubblico di Siena nell’affresco di Lippo Vanni che ritrae la Battaglia della Valdichiana, del 1363, tra l’esercito bretone del Cappello (compagnia di ventura assoldata dai �iorentini) e l’esercito di Siena, che risultò vincitore dello scontro, durato dall’alba al tramonto del 7 ottobre. Per Info e Prenotazioni: Ufficio Turistico di Sinalunga 333 8166793 [email protected] Organizzato da Ufficio Turistico - Associazione Pro Loco Sinalunga Programma 1° ne settimana del mese 2° ne settimana del mese 3° ne settimana del mese 4° ne settimana del mese SINALUNGA SCROFIANO FARNETELLA E RIGOMAGNO BETTOLLE, LA FRATTA L’AMOROSA Sabato dalle 9 alle 13 Sabato o Domenica dalle 9 alle 13 Sabato o Domenica dalle 9 alle 13 Punto di ritrovo: Piazza della Stazione, 31 Punto di ritrovo: Parcheggio fuori porta Punto di ritrovo: Farnetella, davanti al Castello Sabato o Domenica dalle 9 alle 13 Punto di ritrovo: Bettolle, Parcheggio Autostazione Il TOUR comprende: Il TOUR comprende: Il TOUR comprende: Chiesa di S. Pietro Ad Mensulas Chiesa della Compagnia e Museo Chiesa della Compagnia Il TOUR comprende: Collegiata Visita alla Fattoria storica Villa Puccio Collegiata di San Biagio e Museo Chiesa di San Giovanni Museo della Misericordia Il Borgo Santuario della Madonna del Il Borgo Il Borgo Rifugio DEGUSTAZIONE libera presso Bar: DEGUSTAZIONE libera