Si Fa Repubblica.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Catalogo Astegiustizia Maggio2
TUTTE LE SCHEDE DELLE VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI CON DATE, ORARI, DISPOSIZIONI GENERALI, DESCRIZIONI COMPLETE, ORDINANZE, PERIZIE, FOTO, FILMATI SU: WWW. ASTEGIUSTIZIA.IT VENDITE IN SALA SABATO 5 MAGGIO 2018 INIZIO mattina dalle ore 10:00 - pomeriggio dalle ore 15:00 Arezzo via Ferraris 136 Esposizione dei lotti Mercoledi 2 - Giovedi 3 - Venerdi 4 Maggio ore 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 AVVISO LE GARE SU INTERNET IN CONTEMPORANEA: è possibile partecipare anche tramite la "Gara in contemporanea", ovvero una gara che mette in competizione gli utenti iscritti preventivamente sul sito di gare online www.spazioaste.it e gli astanti personalmente presenti in sal a. Per seguire in diretta audio/video la tornata di aste sarà sufficiente collegarsi alla pagina "AsteGiustizia.it" su Facebook oppure sulla Homepage WWW.ASTEGIUSTIZIA.IT PER CHI PARTECIPA DA COMPUTER SCADENZA ISCRIZIONI con bonifico mercoledì 2 Maggio alle 18.00 collegandosi sul sito SPAZIOASTE.it SCADENZA ISCRIZIONI con carta di credito sabato 5 Maggio alle 10.00 lotti mattina | ore 14.00 lotti pomeriggio PER PARTECIPARE DALLA SALA NON È RICHIESTA NESSUNA ISCRIZIONE PREVENTIVA. ELENCO LOTTI IN GARA Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo Lotto c/o IVG Arezzo 1 2 3 4 5 6 Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base Prezzo Base € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 60,00 € 0,00 Rif. 11) Madia da pane Rif. 19) Tavolo in ferro Rif. A) Coppia di alari in Rif. -

Relazione Generale
SEDE ISTITUZIONALE : c/o Comune di Montepulciano SEDE AMMINISTRATIVA : Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena) ℡ 0578/269300 0578/268082 www.unionecomuni.valdichiana.si.it Reperibilità h24 ai numeri 800 913 648 o 320 4345803 Codice Fiscale 90020700523 Partita Iva. : 01254060526 Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di San Comune di Comune di Comune di Comune di Cetona Chianciano Terme Chiusi Montepulciano Casciano Bagni Sarteano Sinalunga Torrita di Siena Trequanda PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VOLUME 1 RELAZIONE GENERALE REVISIONE 2014 AREA TECNICA : Servizi Tecnici Associati – Centro Intercomunale di Protezione Civile – CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione dei Comuni Valdichiana Senese – Indice 1 ELENCO ELABORATI DEL PIANO....................................................................................................................... 2 2 INTRODUZIONE..................................................................................................................................................... 3 3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO ........................................................................................... 5 3.1 Suddivisione amministrativa .......................................................................................................................... 5 3.2 Estensione territoriale – popolazione residente........................................................................................... 8 3.3 Inquadramento Geologico ............................................................................................................................. -

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato
MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

I. Indice Cronologico Delle Filze II
I. Indice cronologico delle filze II. Indice dei mittenti III. Indice dei destinatari IV. Indice toponomastico V. Repertorio dei documenti In neretto il numero della filza, in tondo il numero della carte. In parentesi e in corsivo sono segnate le varianti riscontrate nei documenti. In corpo minore si danno indicazioni essenziali atte ad una migliore identificazione e riferite, in generale, all’arco cronologico nel quale la voce stessa figura in questo volume. Per imperatori, papi, regnanti su stati sovrani e loro consorti , il richiamo è al nome di battesimo. Per le donne il richiamo è al cognome da nubile, quando conosciuto. Nel Repertorio dei documenti diversi, il richiamo è al termine concettualmente più vicino ai contenuti espressi dalla voce come questa figura nel testo dell’Inventario. In ogni categoria di indici è stato fatto il più ampio uso di rinvii onde facilitare il reperimento delle voci. Al termine dei rispettivi indici sono stati segnalati lettere e documenti privi di mittente, di destinatario, di riferimento toponomastico e cronologico. La voce Cosimo I, nell’indice dei destinatari, porta la dizione passim. I luoghi di destinazione non sono contemplati. I. INDICE CRONOLOGICO DELLE FILZE 1545 Febbraio 443 1547 Settembre 442 1557 Gennaio 439 1564 Gennaio 442 1584 Dicembre 436 1552 Marzo 438 Agosto 433 Dicembre 438 1553 Gennaio 438 ; 442 Febbraio 442 Marzo 438 Giugno 442 Settembre 438 Dicembre 438 1554 Gennaio 438 ; 439 ; 440 ; 442 ; 443 Febbraio 438 ; 439 ; 440 ; 442 ; 443 Marzo 433 ; 436 ; 438 ; 441 ; 442 ; 443 ; 444 ; -

Elenco Delle Scuole Della Provincia Di Siena
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana UFFICIO XVIII° Ambito Territoriale della Provincia di SIENA Piazza Amendola 29, 53100 SIENA Tel. 0577/2531 Fax 0577/253239 ELENCO SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SIENA Anno Scolastico 2013/2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "CECCO ANGIOLIERI" Codice meccanografico: SIIC81600P CODICE FISCALE 80005600525 Dirigente scolastico: Guasparri Paolo Indirizzo: VIALE AVIGNONE 10 SIENA Telefono 0577 44102 FAX 0577 44102 e-mail: [email protected] certificata: [email protected] SIAA81601G VIA AVIGNONE VIA AVIGNONE 1 SIENA 0577 292317 SIEE81601R BALDASSARRE PERUZZI VIALE AVIGNONE 1 SIENA 0577 44970 SIMM81601Q CECCO ANGIOLIERI VIA AVIGNONE N. 10 SIENA 0577 44102 ISTITUTO COMPRENSIVO "JACOPO DELLA QUERCIA" Codice meccanografico: SIIC82400N CODICE FISCALE 92661470529 Dirigente scolastico: Regola Lucia Indirizzo: VIA ROMA 65 SIENA Telefono 0577 289017 FAX 0577 46990 e-mail: [email protected] certificata: [email protected] SIAA82401E BUCCIANO-ISOLA D'ARBIA ST.DA CASSIA SUD N. 364 SIENA 0577 292319 SIEE82401Q GIOVANNI DUPRE' VIA ROMA 61 SIENA 0577 279017 SIMM82401P FRAZ. TAVERNE D'ARBIA LOC. PRESCIANO SIENA 0577 364856 ISTITUTO COMPRENSIVO "PIER ANDREA MATTIOLI" Codice meccanografico: SIIC82500D CODICE FISCALE 80008670525 Dirigente scolastico: Napoli Giuseppa Indirizzo: VIA NAZARIO SAURO N. 3 SIENA Telefono 0577 48080 FAX 0577 42981 e-mail: [email protected] certificata: [email protected] SIAA82501A CASTAGNO SIENA 0577 292312 SIAA82503C RAVACCIANO VIA L. DEL VECCHIETTA 30 SIENA SIEE82501G GIOVANNI PASCOLI VIA N.SAURO 1 SIENA 0577 48080 SIEE82502L SCUOLA OSPEDALIERA C/O POLICLINICO LE SCOTTE SIENA 0577 331552 SIEE82503N SIMONE MARTINI VIA DUCCIO BONINSEGNA 40 SIENA 0577 40398 SIEE82504P ACHILLE SCLAVO PIAZZA LIBERTA - FORTEZZA MEDICEA SIENA 0577 280816 SIEE82505Q COLLEVERDE STRADA OSSERVANZA SIENA 0577 332424 SIMM82501E P.A. -

Valdichianasenese AUTENTICA PER NATURA
UN MONDO DI IDEE ORIGINALI PER VIAGGIARE SAPORI AUTENTICI OLIO, VINO CHIANINA E PECORINO PAESAGGI A TU PER TU CON LA NATURA SUPPLEMENTO AL NUMERO LUG-AGO 2020 BENESSERE TOTALE SALUS PER AQUAM STORIE DI BORGHI COMUNI FUORI DAL COMUNE Bellezza infinita Valdichiana Senese IN COLLABORAZIONE CON SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 1 SUPPLEMENTO AL NUMERO 4 - ANNO II - LUG-AGO 2020 Valdichiana Senese Explore LA COVER DI QUESTO NUMERO Colline ricamate da curve e cipressi, il verde e l’oro di olivi e campi di grano, AUTENTICA architetture che rimandano PER NATURA all’antica vocazione rurale: 5 Una galassia di sapori un’immagine “iconic” della Valdichiana Senese, Nobili vini e prodotti veraci quintessenza del buon 7 Immersi nella natura vivere toscano tra storia e Ognuno al proprio ritmo storie, benessere e armonia. Un invito ad 8 Rigenerare le mente attraversarla on the road, e il corpo in bici o a piedi. O come volete, ad ognuno la propria scoperta. Di sé e di NOVE COMUNI un territorio straordinario FUORI DAL COMUNE 13 Cetona Visioni incantate 14 Chianciano Terme SCARICA Eccellenza del benessere 15 Chiusi L’EDIZIONE Scoperta continua DIGITALE 16 Montepulciano Sublime totale 17 San Casciano dei Bagni Immergersi nella bellezza 18 Sarteano Quintessenza di Toscana 19 Sinalunga Tuffo nell’arte 20 Torrita di Siena Una storia, mille storie 21 Trequanda Gemma rara GUIDA AL VIAGGIO 22 Dritte, consigli e segnalazioni IN COLLABORAZIONE CON 2 SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 SUPPLEMENTO luglio-agosto 2020 3 RIGENERARSI | RITROVARSI | RISCOPRIRE L’ARMONIA A sinistra: vista sulle colline della Valdichiana Senese In basso: vacche della pregiata razza Chianina Nelle pagine seguenti: il pozzo dei Grifi e dei Leoni nella piazza Grande di Montepulciano, un’escursione in bici tra filari di sangiovese VALDICHIANASenese AUTENTICA PER NATURA INSEGUITE LA BELLEZZA DEI PAESAGGI DEI BORGHI CHE RACCONTANO, DELL’ARTE CHE HA PRESO ISPIRAZIONE DALLA NATURA, RENDENDOLA IMMORTALE epetita juvant, recita l’adagio latino. -

Campionato Eccellenza A
ATTIVITA’ CALCIO UISP SIENA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 Comunicato 3 del 18/10/2016 PROMOZIONE GIR. A EDIL SARDEGNA COLLIGIANA - MONTALLESE N.D.I.C. HELLAS TORRITA - CASTELNUOVO SCALO 0 - 0 VIRTUS CHIANCIANO 1945 - GRACCIANO 2 - 0 CASTELLINA IN CHIANTI - RADDESE 0 - 0 SALCHETO - SINALUNGA 0 - 0 POLISP. RIGOMAGNO - CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE 2 - 1 Disciplina Ammoniti: Federico Bisti (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE); Duccio Fontana (CASTELLINA IN CHIANTI); Davide Sorace, Nicola Lachi, Nfally Colley, Yunus Gittteh (CASTELNUOVO SCALO); Andrea Bianchini, Guido Roggi, Federico Ciolfi (HELLAS TORRITA); Riccardo Donzellini, Stefan Andrei Sabin, Alberto Farsetti, Gioele Mazzetti (POLISP. RIGOMAGNO); Luca Ruscelli (RADDESE); Michele Rosignoli, Marco Falvo (SALCHETO); Carlo Massai, Michael Medico (SINALUNGA); Valdson Cerqueria Da Silva (VIRTUS CHIANCIANO 1945). Diffide: Gaetano Bellavia (CAFFE' CENTRALE M.NO STAZIONE); Richard Arthur (GRACCIANO). Una giornata: Andrea Malacarne ART. 128 R.D. (SALCHETO). Sanzioni squadre: POLISP. RIGOMAGNO (€ 10,00 ART. 102 R.D.). Classifica Punti Gio Vin Par Per Gol: Fat Sub C.D. 1 - RADDESE 4 2 1 1 0 3 1 1 2 - HELLAS TORRITA 4 2 1 1 0 2 0 8 3 - MONTALLESE 3 1 1 0 0 3 2 6 4 - POLISP. RIGOMAGNO 3 2 1 0 1 4 4 13 5 - VIRTUS CHIANCIANO 1945 3 2 1 0 1 3 3 1 6 - CAFFE' CENTRALE M.NO STAZ. 3 2 1 0 1 3 3 7 7 - SINALUNGA 2 2 0 2 0 1 1 3 8 - CASTELLINA IN CHIANTI 2 2 0 2 0 1 1 5 9 - CASTELNUOVO SCALO 2 2 0 2 0 0 0 4 10 - EDIL SARDEGNA COLLIGIANA 1 1 0 1 0 0 0 2 11 - SALCHETO 1 2 0 1 1 1 2 9 12 - GRACCIANO 0 2 0 0 2 0 4 4 Marcatori 3 reti: FANTI PIETRO (VIRTUS CHIANCIANO 1945); 2 reti: GUEYE PAPA OMAR (POLISP. -

Curriculum Vitae Paolo Giliarini
Agosto 1996 n.494 Dal Marzo 1998 al Dicembre2000 Assunzione con contratto individuale speciale di lavoro a tempo determinato e parziale (ai sensi dell’art.51, comma 5bis Legge 142/90 come aggiunto dall’art.6, comma 4 della Legge 127/97) Rep.987 in data 12/03/1998 per l’espletamento delle funzioni di area direttiva VIII^ q.f. “Funzionario-Architetto” presso il Servizio Opere e Lavori Pubblici del Comune di Sinalunga. Dal Marzo 1998 al Dicembre 2000 Nomina con provvedimento del Sindaco protempore Prot. 3515 del 16/03/1998 a Responsabile del Servizio Opere e Lavori Pubblici del Comune di Sinalunga, in applicazione della Legge 15/05/1997 n.127 Maggio 1999 Designazione con provvedimento del Sindaco protempore Prot. n.8331 del 28/05/1999 a tecnico componente del Nucleo di Valutazione Cave ai sensi dell’art.26, comma 2 della L.R.3/11/1998 n.78 in relazione a: “Progetti per l’apertura di cave di prestito in loc. Podere (Comune di Asciano) e in loc. Casata (Comune di Sinalunga) per i lavori di adeguamento a 4 corsie della S.G.C. E/78 Due Mari, tratto Armaiolo-Rigomagno-Bettolle, III Lotto. Dal Gennaio 2001 al Settembre 2007 Nomina in qualità di Funzionario Cat. D3 –assunto a contratto speciale a tempo determinato-, a Responsabile della Posizione Organizzativa relativa al Settore F “Attività di Progettazione” del Comune di Sinalunga. Nello stesso periodo nomina a Sostituto ai Titolari Responsabili della Posizione Organizzativa relativa al Settore H “Attività Urbanistica e Pianificazione del Territorio” e della Posizione Organizzativa relativa al Settore G “Attività Tecnico Manutentiva e di Gestione del Patrimonio” del Comune di Sinalunga. -
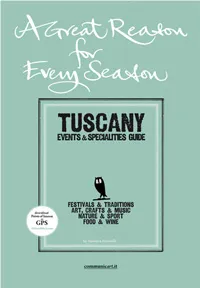
Preview Eng 2012.Pdf
Copyright © 2011 by Communicart.it – Firenze Printed by : Industria Grafica Pistolesi – Ed Il Leccio srl. Via della Resistenza, 117- Loc.Badesse Monteriggioni (Siena) Author: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) Concept Design: Arch. Nicola Natalizio Cover Calligraphy: Betty Soldi Editing Team Veronica Ficcarelli, Bess Melendez , Nina Brown, Rachel Mascetta Translation: Bess Melendez, Nina Brown , Rachel Mascetta Photographs: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) with the unique contribution of Rachel Mascetta & Dave Yoder Printed in February 2012 by Industria Grafica Pistolesi – Siena map of Tuscany __ 6 __ __ 7 __ Remembering Santa Lucia, One of the most magical places in Tuscany. For me, and for my friends from all over the world - a perfect place. “E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il lungo corso dei fiumi, e l’immensità dell’Oceano, ed il volgere degli astri... e si dimenticano di se medesimi” (Men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty billows of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, and pass themselves by) Sant’Agostino This book is dedicated to Mochy , my dog the best everything ever had in my life for over 17 years __ 8 __ __ 9 __ __ HOW TO CONSULT THE GUIDE __ Content Introduction Dedicated sections on Spring, Summer, Fall & Winter Events: Celebrations & Traditions; Art, Crafts & Music; Food & Wine; Nature & Sport Tuscan Specialties from the Producers’ Point of View: Tradition, Handicraft, -

Il-R. Archivio Di Stato
IL- R. ARCHIVIO DI STATO N EL SETTEiliBRE DEL 1862. MONUMENTA GERMANIAE HL3TORiCA Bibliothek AVVERTIUENTO. I documenti ehe appartennero al governo ed alle varie magi strature ed Istituti della citta di Siena, cosi dei tempi piu antichi allorche si resse a Comune, come dei successivi~ quando perdu ta Ia propria autonomia venne a formar parte del Principato To scano, rimasero fino a questi ultimi giorni riposti , e quasi di &persi negli Archiv! di var1 pubblici Uffizi. II maggior numero pero, e se si vuole quelli di piu rilievo, ebbero un lor proprio Archivio, il Diplomatico, detto anche delle Riformagioni, alluo gato nel Palazzo del Comune e sottoposto nel 1856 alla nuova Soprintendenza Generale degli Archiv! delle nostre provincie. Avevansi in quegli Archivi Indici, quali meglio, quali peggio com-. pilati, quali piu quali meno compiuti; ma era massimo inconve niente ehe le memorie Senesi difettassero di un buon assetto ma teriale e ehe giacendosi cosl divise fossero ben lungi dal rap presentarci la intiera amministrazione deUa Repubblica e del suc cessivo Governo. La Soprintendenza Generale degli Archiv! Toscani s' ap plaudira sempre d' aver procurato alla citta di Siena il benefi zio di un Archivio di Stato ritraente l' idea del fiorentino; e que· sta nuova fondazione ( contemporanea a quella di Lucca ) ebbe principio pel decreto del 17 Novembre 1858. A cagione dei molti documenti, ehe, come dicemmo, si dovevano insieme rac cogliere, fu mestieri abbandonare I' antica sede del Diplomatico, ond' e ehe il nuovo Archivio si costitul. al terzo pianö del palazzo ,_ Governativo , gia Piccolomini , cospicuo edifizio inalzato dai nipoti di Pio II. -

REGISTRO Persone Giuridiche .Pdf
NUM. CODICE CODICE COD. FISC. DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO RAPPR. LEGALE REGISTRO COMUNE PROVINCIA RAPPR.LEGALE Ist. Interdiocesano per il sostentanento del clero di Siena-Colle di Val d'Elsa- Via di Città n. 146 Belli Fabio e BLLFNC45C09I726U 92003400527 052032 052 Montalcino e Abbazia territoriale di Siena Nencini Pietro NNCPTR64L31C847W 1 Monteoliveto Maggiore Via Pesanella n. 68 Fondazione Alimondo Ciampi Onlus 94051520487 052023 Ciampi Daniele CMPDNL55T14859L Radda in Chianti " 2 Fraz. Contignano - Mons. Icilio Parr. S. Maria Assunta 052040 " RSSCLI28S25H790W 3 Radicofani Rossi Via San Michele n. Don Sensano Parr. S. Maria della Stella 11 Chianciano 052009 " Carlo 4 Terme Giovannino Ist.Diocesano per il sostentamento del Via Fiorenzuola clero della Diocesi di Montepulciano 704650522 vecchia n. 2 052015 " Marchi Mario 5 Chiusi Montepulciano Via Berardenga n. 29 Villa Chigi - Assoc. Nazion. Città del vino 702220526 052006 Pioli Giampaolo PLIGPL48M17G687W Castelnuovo " 6 Berardenga Via Banchi di Sotto Mancini Fondaz. Monte dei Paschi di Siena 92035830526 052032 n. 34 Siena " Gabriello 7 Via di Città n. 89 Mancini Accademia musicale Chigiana 68580521 052032 PLIGPL48M17G687W 8 Siena " Gabriello Mons. Arcidiocesi di Siena , Colle di val d'Elsa Piazza Duomo n. 6 80009780521 052032 Buoncristiano BNCNTN43T20C527R e Montalcino" Siena " 9 Antonio c.f. Arcidiocesi Loc. Piana - Mons. Rosi Parr. S. Innocenzo a Piana 052003 RSOCLD55B15F676Q 10 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Via Soccini n. 151 Don Poddighe Parrocchia Santi Pietro e Paoli 052003 11 80009780521 Buonconvento " Gianfranco c.f. Arcidiocesi loc. Bibbiano - Mons. Rosi Parrocchia S. Lorenzo Martire 052003 RSOCLD55B15F676Q 12 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Loc Ponte d'Arbia - Mons. -

I Miei Ascendenti - Documenti, Testimonianze E Curiosita'
I MIEI ASCENDENTI - DOCUMENTI, TESTIMONIANZE E CURIOSITA' - Dopo anni di ricerche, ho voluto metter anche su carta le notizie più interessanti e curiose che sono riuscito a "scovare" intorno ai miei diretti progenitori, raccogliendole in due parti. Per rendere più comprensibile la lettura di questa dispensa, ho spesso indicato la provenienza dei quattro rami dai quali discendo: Papei, Casini, Frati e Giannelli, ossia le famiglie dei miei nonni. Gli argomenti trattati sono molteplici e l'indice che segue non osserva un ordine ben preciso, non essendo dettato in alcun modo dalla cronologia degli eventi. HOC EST – VIVERE BIS VITA POSSE PRIORE FRUI Saper vivere con piacere il passato, è vivere due volte Marziale (Bibilis-Spagna 40 d.C. - Roma 104 d.C.) Epigrammi, X, 23, 6-7 1 INDICE DEI CAPITOLI - prima parte - pag. 4 - ASCENDENTI PER QUARTI pag. 13 - GENITORI, NONNI E BISNONNI IN POSA pag. 15 - ALCUNE OSSERVAZIONI SUI COGNOMI pag. 20 - IL BATTESIMO PIU' REMOTO pag. 25 - GLI ANTENATI E IL PALIO pag. 28 - GIOVAN BATTISTA MAFFANI MAESTRO DI SCHERMA pag. 29 - LE PROFESSIONI pag. 32 - OSTI E BETTOLIERI pag. 36 - DRAMMATICA RISSA ALL'OSTERIA DELLE VOLTE pag. 37 - GIUSEPPE PECCI PRESENTE AI TUMULTI DEL 1815 pag. 38 - L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PETTINI pag. 40 - MORTO O VIVO ? pag. 41 - INDIGENTI E MISERABILI DELLA CITTA' NEL 1816 pag. 42 - UN DISEREDATO pag. 44 - IL CARATTERACCIO DI PIETRO MAGGIORANI pag. 47 - LA SERIE DI REATI COMMESSI DA GIACOMO FIASCHI pag. 51 - QUALCHE GUAIO PER ANTONIO BELLONI pag. 53 - FILIPPO MELONI TROVATO ARMATO FINO AI DENTI pag. 53 - VICISSITUDINI NELLE FAMIGLIE CARLUCCI pag.