Nuova Serie (1968)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9789004272989.Pdf
Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) Brill’s Studies in Intellectual History General Editor Han van Ruler (Erasmus University Rotterdam) Founded by Arjo Vanderjagt Editorial Board C.S. Celenza ( Johns Hopkins University, Baltimore) M. Colish (Yale University) J.I. Israel (Institute for Advanced Study, Princeton) A. Koba (University of Tokyo) M. Mugnai (Scuola Normale Superiore, Pisa) W. Otten (University of Chicago) VOLUME 237 The titles published in this series are listed at brill.com/bsih Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) Classicist, Hebraist, Enlightenment Radical in Disguise By Ulrich Groetsch LEIDEN | BOSTON Cover illustration and frontispiece: Portrait of Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) by Gerloff Hiddinga, 1749. Private collection. Photo by Sascha Fuis, Cologne 2004. Courtesy of Hinrich Sieveking, Munich. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Groetsch, Ulrich. Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) : classicist, hebraist, enlightenment radical in disguise / by Ulrich Groetsch. pages cm. — (Brill’s studies in intellectual history, ISSN 0920-8607 ; VOLUME 237) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-27299-6 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-27298-9 (e-book) 1. Reimarus, Hermann Samuel, 1694–1768. I. Title. B2699.R44G76 2015 193—dc23 2014048585 This publication has been typeset in the multilingual ‘Brill’ typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 0920-8607 isbn 978-90-04-27299-6 (hardback) isbn 978-90-04-27298-9 (e-book) Copyright 2015 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. -

Palazzo Querini Stampalia Portego
Palazzo Querini Stampalia Museum Portego entrance Giovanni Mythology Bellini room room The earliest documents concerning the construction of the palace are from 1513-14 and point to Nicolò Querini as commissioner of the works. Grandson Francesco continued the works of enlargement and restoration in various stages throughout the first half of the century. From this period archival documents note nothing of importance until the acquisitions of the following century: in 1614 the building which is now the east wing of the palace and in 1653 part of the house between the canal and the church in Campo Santa Maria Formosa. The last radical transformation of Ca’ Querini was between 1789 and 1797 for the occasion of the marriage in 1790 between Alvise, son of Zuanne, and Maria Teresa Lippomano. In addition to the elevation of the third floor, completed after 1795, there was a large scale restructuring of the interiors with the reduction of the length of the portego and the evolution of the decorative scheme on which worked Jacopo Guarana, Davide Rossi, ornamentalist Giuseppe Bernardino Bison, gilder Domenico Sartori and brothers and stucco workers Giuseppe and Pietro Castelli. The museum is presented in such a way as to recall a patrician residence of the eighteenth century with the display of all of the collections of the family: furnishings, porcelain, sculpture, fabrics, chandeliers, globes, as well as paintings, in order to bring to life the spaces once truly inhabited by the Querini. A rich theatre where every detail plays an important role, from the fabrics in some rooms woven according to original patterns, to the curtains and the pelmets which adorn the windows to the original chandeliers. -

Otiziario Bibliografico Periodico Della Giunta Regionale Del Veneto 32
otiziario Bibliografico periodico della Giunta regionale del Veneto 32 a n. 32 - settembre 1999 - sped. in abb. postale art. 2 comma 20/c Legge 662/96 - taxe perçue - tassa riscossa - Filiale di Padov Notiziario Bibliografico n. 32, settembre 1999 I N D I C E periodico quadrimestrale d’informazione bibliografica a cura della Giunta regionale del Veneto Comitato promotore Giancarlo Galan (presidente della Giunta regiona- le), Angelo Tabaro (dirigente regionale Cultura, Informazione e Flussi migratori) Comitato di redazione Claudio Bellinati (direttore dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare di Padova), Massimo Canella (dirigente regionale Servizio Attività Editoriali), 5 Chiara Finesso, Bianca Lanfranchi Strina (sovrin- Collane editoriali e interventi regionali (Massimo Canella) tendente ai Beni archivistici del Veneto), Anelio Pellizzon, † Silvio Tramontin, Marino Zorzi (diretto- Fondi antichi nelle biblioteche della regione (Marino Zorzi) 14 re della Biblioteca Nazionale Marciana) Gli archivi parrocchiali veneziani (Francesca Cavazzana Romanelli) 16 Direttore responsabile Anelio Pellizzon Responsabile di redazione Chiara Finesso Segreteria di redazione RECENSIONI E SEGNALAZIONI Giovanna Battiston, Susanna Falchero Collaboratori alla redazione di questo numero Opere generali Giovanna Battiston, Marco Bevilacqua, Sonia Celeghin, Fiorino Collizzolli, Marilia Ciampi A. Cataldi Palau, Gian Francesco d’Asola e la tipografia aldina (Simonetta Pelusi)28 Righetti, Jolanda Dalla Vecchia, Susanna Falche- Aldus Manutius and Renaissance Culture, ed. by D.S. Zeidberg (Simonetta Pelusi)28 ro, Luigina Fontana, Andrea Fosco, Elio Franzin, Gabriella Imperatori, Giovanni P. Luisetto, Massi- M. Miato, L’Accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan (Simonetta Pelusi)28 mo Galtarossa, Barbara Giaccaglia, Cinzio Gibin, L. Augliera, Libri politica religione nel Levante del Seicento (Simonetta Pelusi)29 Vasco Gondola, Paola Martini, Cecilia Passarin, Simonetta Pelusi, Ferdinando Perissinotto, Franco Verso il Polifilo, a cura di D. -

Onore E Decoro Delle Muse Bresciane»1 La Letteratura Bresciana Del Settecento Nei Contributi Critici
CRISTINA CAPPELLETTI «Onore e decoro delle muse bresciane»1 La letteratura bresciana del Settecento nei contributi critici Un bilancio sui contributi critici dedicati alla letteratura bresciana de- gli ultimi quarant’anni dovrebbe presentare il «complessivo degli aspetti favorevoli e sfavorevoli di un’attività, il positivo e il negativo di un’espe- rienza», attenendosi al significato che il termine ha in ambito economi- co. In senso più lato, un bilancio dovrebbe proporsi di «determinare [...] quanto è fatto e quanto resta da fare; valutare qualità e difetti, vantaggi e svantaggi»2; e, riportandoci al caso presente, individuare quali autori o generi siano stati più o meno trattati, e proporre – ove possibile – spunti per ricerche future. Per ovviare alla noia che potrebbe ingenerare un mero elenco, o qua- si, di titoli, pur tenendo fede al resoconto delle entrate e delle uscite, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio di un allegato con le cosiddette pezze giustificative; nello specifico, di demandare a un Allegato di bilan- cio la bibliografia dei contributi critici degli ultimi quattro decenni, per riservare al testo un consuntivo più “conversevole”, volto a individuare alcuni aspetti peculiari della letteratura bresciana del XVIII secolo, met- tendo in rilievo se e in quale misura la critica si sia occupata di essi. Considerando l’ambiente culturale bresciano settecentesco, già a suo tempo bene delineato dal contributo di Elisabetta Selmi3, ciò che emerge da subito è come lo status di provincia della terraferma veneta abbia po- chi riscontri in ambito letterario, almeno nella seconda metà del secolo. Nei primi cinquant’anni del Settecento, infatti, si guarda all’erudizione veneziana come a un modello da imitare, e Apostolo Zeno e Angelo Calo- gerà, animatori della cultura nella Serenissima di quegl’anni, sono assunti anche da Giammaria Mazzuchelli quali numi tutelari, al cui vaglio sotto- porre le proprie opere e le proprie iniziative. -

Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia Shaun London Blanchard Marquette University
Marquette University e-Publications@Marquette Dissertations (2009 -) Dissertations, Theses, and Professional Projects Eighteenth-Century Forerunners of Vatican II: Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia Shaun London Blanchard Marquette University Recommended Citation Blanchard, Shaun London, "Eighteenth-Century Forerunners of Vatican II: Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia" (2018). Dissertations (2009 -). 774. https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/774 EIGHTEENTH-CENTURY FORERUNNERS OF VATICAN II: EARLY MODERN CATHOLIC REFORM AND THE SYNOD OF PISTOIA by Shaun L. Blanchard, B.A., MSt. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School, Marquette University, in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy Milwaukee, Wisconsin May 2018 ABSTRACT EIGHTEENTH-CENTURY FORERUNNERS OF VATICAN II: EARLY MODERN CATHOLIC REFORM AND THE SYNOD OF PISTOIA Shaun L. Blanchard Marquette University, 2018 This dissertation sheds further light on the nature of church reform and the roots of the Second Vatican Council (1962–65) through a study of eighteenth-century Catholic reformers who anticipated Vatican II. The most striking of these examples is the Synod of Pistoia (1786), the high-water mark of “late Jansenism.” Most of the reforms of the Synod were harshly condemned by Pope Pius VI in the Bull Auctorem fidei (1794), and late Jansenism was totally discredited in the increasingly ultramontane nineteenth-century Catholic Church. Nevertheless, many of the reforms implicit or explicit in the Pistoian agenda – such as an exaltation of the role of bishops, an emphasis on infallibility as a gift to the entire church, religious liberty, a simpler and more comprehensible liturgy that incorporates the vernacular, and the encouragement of lay Bible reading and Christocentric devotions – were officially promulgated at Vatican II. -
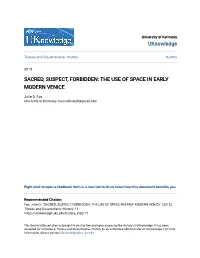
The Use of Space in Early Modern Venice
University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--History History 2013 SACRED, SUSPECT, FORBIDDEN: THE USE OF SPACE IN EARLY MODERN VENICE Julie D. Fox University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Fox, Julie D., "SACRED, SUSPECT, FORBIDDEN: THE USE OF SPACE IN EARLY MODERN VENICE" (2013). Theses and Dissertations--History. 11. https://uknowledge.uky.edu/history_etds/11 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the History at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--History by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained and attached hereto needed written permission statements(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine). I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the non-exclusive license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I agree that the document mentioned above may be made available immediately for worldwide access unless a preapproved embargo applies. I retain all other ownership rights to the copyright of my work. -

La Scuola Di Melchiorre Cesarotti Nel Quadro Del Primo Romanticismo Europeo Claudio Chiancone
La scuola di Melchiorre Cesarotti nel quadro del primo romanticismo europeo Claudio Chiancone To cite this version: Claudio Chiancone. La scuola di Melchiorre Cesarotti nel quadro del primo romanticismo europeo. Literature. Université Stendhal - Grenoble III; Università degli studi di Padova, 2010. Italian. NNT : 2010GRENL031. tel-00957220 HAL Id: tel-00957220 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957220 Submitted on 14 Mar 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Claudio Chiancone LA SCUOLA DI MELCHIORRE CESAROTTI NEL QUADRO DEL PRIMO ROMANTICISMO EUROPEO tesi di dottorato discussa pubblicamente il 2 dicembre 2010 a Grenoble **** Université Stendhal - Grenoble 3 Università degli Studi di Padova Relatori: Prof. Enzo Neppi, Université Stendhal - Grenoble 3 Prof. Guido Baldassarri, Università degli Studi di Padova 2 INDICE Presentazione p. 11 Introduzione p. 23 Parte Prima. Melchiorre Cesarotti. Storia di un magistero 1.1 Il Seminario di Padova. La formazione. La ribellione p. 37 1.2 Il soggiorno a Venezia. Il contatto con l’Europa p. 59 1.3 La cattedra. Il confronto p. 81 1.4 Un laboratorio di traduzioni. La prima generazione di allievi p. 99 1.5 La “famiglia” cesarottiana. -

Daniele Barbaro
DANIELE BARBARO 1514 - 70 DANIELE BARBARO 1514-70 Letteratura, scienza e arti nella Venezia del Rinascimento DANIELE BARBARO Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana 10 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016 1514 - 70 LETTERATURA, SCIENZA E ARTI NELLA VENEZIA DEL RINASCIMENTO a cura di Susy Marcon e Laura Moretti © 2015 Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia © 2015 Antiga Edizioni Crocetta del Montello (TV) [email protected] ISBN 978-88-97784-87-6 L’esposizione e il catalogo fanno parte Francesco Borella Servizi tecnici INTERNATIONAL NETWORK Executive Board Agostino De Rosa (Università IUAV delle attività promosse nell’ambito Giulia Filippini Marcello Brusegan Daniele Barbaro (1514-70): Frédérique Lemerle (Centre d’Études di Venezia) dell’International Network Sara Dissette Dino De Marchi In and Beyond the Text Supérieures de la Renaissance, Tours) Giovanni Maria Fara (Università Daniele Barbaro (1514-70): xPlants Mario Destà 01/02/2014-31/01/2016 Susy Marcon (Biblioteca Nazionale Ca’ Foscari, Venezia) In and Beyond the Text Luca Zoccarato Cinzia Rossi Funded by The Leverhulme Trust Marciana, Venezia) Daniele Gessi (Università degli Studi e sono stati realizzati con il contributo di Martino Limido Laura Veronese Laura Moretti (University of St Andrews) di Udine) The Leverhulme Trust. Luca Flisi Vasco Zara (UMR “ARTeHIS” 6298 - Jasenka Gudelj (Sveucˇilišta u Zagrebu) Université de Bourgogne) Katherine Isard (Visiting Scholar, University Apparati digitali CATALOGO A CURA DI of Cambridge) Targetdue s.r.l. Susy Marcon Advisors Sara Mansutti (Università -
How Reimarus Read His Bible
Chapter 5 How Reimarus Read His Bible In July 1744, Reimarus sent a long-awaited response to his benefactor Angelo Maria Querini in Rome. Ever since September 1736, the two men had main- tained an intensive correspondence. From Reimarus’s point of view, Querini’s help had been vital for the success of his Cassius Dio edition, which was well under way, but still far from completion.1 Most importantly, the cardinal pro- vided him with collations from two Dio manuscripts from the Vatican Library2 and helped advertise his project to scholarly circles across the Alps.3 Such pub- licity was essential for the young German scholar, whose meager publication record up to that point had barely made him visible in the larger Respublica literaria. But the exchange was not only to Reimarus’s advantage. Having been trained by one of the greatest bibliographers of his time, Reimarus was able to provide Querini with all sorts of scholarly materials. Among his main assets was the scholarly legacy of his father-in-law Fabricius and the latter’s mag- nificent library, whose auction catalogue Reimarus was compiling.4 This task had put Reimarus at an important intersection in the world of learning and made him an attractive correspondent even to scholarly heavyweights such as Querini. Though Querini was by no means a stranger to scholars throughout Europe,5 Reimarus was still able to do his part to publicize the latter’s work, 1 The first volume appeared in 1750. For greater detail on this subject, see chapter 4 above. 2 See VQS. -

Quiriniana Gennaio 2011 Speciale Querini.Pub
Gennaio 2011 Quiriniana Speciale Libri, riviste, multimediali: esposizioni in Queriniana Querini Biblioteca civica Queriniana 260 anni di utilità pubblica Mostra e testi a cura di Riccardo Bartoletti *** Con la collaborazione di Ennio Ferraglio, Maddalena Piotti, Gianmaria Porrini, Stefano Grigolato Le ragioni di una mostra Nell’anno appena conclusosi Brescia ha dove- rosamente celebrato il bicentenario del Teatro Grande, tanto ammirato da Stendhal che lodò l’edificio bresciano per la sua graziosità. Non si devono tralasciare tuttavia altri due importanti anniversari ricorsi nel 2010, meno menzionati: uno sempre attinente al Teatro Grande, ma che si riferisce alla Sala del Ri- dotto, nel duecentocinquantesimo anno di costruzione; l’altro ricorda i 260 anni di vita pubblica della Biblioteca Queriniana. En- trambi gli eventi riguardano due edifici sette- centeschi, capisaldi della cultura cittadina: il primo nacque come sede dell’importante Acca- demia degli Erranti, mentre la Biblioteca Queriniana divenne l’istituzione della cultura per eccellenza, sia per la fruizione pubblica delle sale sia per la vastità e l’esaustività del- le pubblicazioni in essa raccolte. La mostra intende appunto ricordare l’impor- tante ruolo che la Biblioteca Queriniana sta ininterrottamente fornendo da oltre due secoli e mezzo e la benemerita figura che la istituì: Angelo Maria Querini, cardinale della romana Curia e vescovo della città di Brescia dal 1727 al 1755. Pagina 2 Quiriniana La Queriniana, definita con toni un po’ irrispettosi da pa- Fig. 1: Antonio Marchetti (?), Tavola A. Primo Disegno del pa Benedetto XIV la “biblioteca ambulante”, nacque in età Ponte . Disegno a penna, acquerellato (in Luigi Avogadro, illuministica, concepita in un’ottica di estrema novità, in Notizie intorno alla origine, al dominio e al governo della Libreria Queriniana (Bq Ms. -

Reimarus, the Cardinal, and the Remaking of Cassius Dio's Roman
Chapter 4 Reimarus, the Cardinal, and the Remaking of Cassius Dio’s Roman History In December 1746, a notably exasperated Reimarus wrote a disgruntled letter to his longtime correspondent and benefactor Cardinal Angelo Maria Querini,1 archbishop of Brescia and head of the Vatican Library (Fig. 7). Querini had just informed him that Nicolaus Carminius Falco (1681–1759),2 who was then archbishop of Naples, was planning to publish his new edition of Cassius Dio’s Roman History—a project, Reimarus thought, that Falco had long abandoned: I admit that nothing has caught me more by surprise than that after twenty-two years of silence this famous man sets out to fulfill his promise [. .]. Surely for the last three years now, if I am not mistaken, you have not only publicly announced my Dio project, but you have even pre- sented yourself thus far as a great supporter of it, if I may not even say eulogist of this cause: why did [Falco] not approach you? Why did he not revive [in public] the nearly already extinguished and buried awareness about his work? Why did he at least not according to the law of postlim- iny indicate that he wanted to reclaim his right?3 * An earlier version of this chapter has been published under the same title in Martin Mulsow, ed., Between Philology and Radical Enlightenment: Hermann Samuel Reimarus (1694–1768). Leiden and New York: Brill, 2011: 103–57. 1 On Querini, see Alfred Breithaupt, De Cardinalis Quirini vita et operibus (Paris, 1889); Gino Benzoni, ed., Cultura, religione e politica nell’età di Angelo Maria Querini (Brescia, 1980); Ennio Ferraglio and Daniele Montanari, eds., Angelo Maria Querini a Corfù: mondo greco e latino al tramonto dell’antico regime (Brescia, 2005). -

Ian Thomson Phd Thesis Vol 2
ABC495A 9= B85 ;965# A38>;2@A89?# 2=4 54C32B9>=2; 23895D5<5=B >6 7C2@9=> 42 D5@>=2 !(*.+$(+-'" !D>;% 99" 9EQ BLRPURQ 2 BLIUMU AWFPMVVIH JRT VLI 4IKTII RJ ?L4 EV VLI CQMXITUMV[ RJ AV% 2QHTIYU (/-/ 6WOO PIVEHEVE JRT VLMU MVIP MU EXEMOEFOI MQ @IUIETGL1AV2QHTIYU06WOOBIZV EV0 LVVS0&&TIUIETGL$TISRUMVRT[%UV$EQHTIYU%EG%WN& ?OIEUI WUI VLMU MHIQVMJMIT VR GMVI RT OMQN VR VLMU MVIP0 LVVS0&&LHO%LEQHOI%QIV&('')*&)/-, BLMU MVIP MU STRVIGVIH F[ RTMKMQEO GRS[TMKLV STUDIES IN THE LIFE, SCHOLARSHIP, AND EDUCATIONALACUIEVE IT OF GUARINO DA VERONA (i374-146o) by y, . Ian Thomson ,. -r Submitted June 1968 for the degree of Doctor of Philosophy in the University of St. Andrwe V týý.: ý ti, ý ýcýýýý S ', iý üý, 1 301 TRAI. SIiISSI0IN, AID TEXT OF Tf1E LLTTERS OF GUARINO Many hunani. atn collected and edited their own letters$ Guarino, however, did not, possibly because the leisure necessary for making copies of everything he wrote, or the affluence which would have enabled him to employ an amanuensis to do so, was for most of his life denied to him" Only in the, case of letters 7,25,27,47,51+, 861,862,864, and 892, which formed part of the collection known as Chrysolorina, is he known to have nmaoced any, The vast majority have. therefore been transmitted either fortuitously or through recipients who preserved then. As an example of how this happened, there coons to have been a collection of Guarino's letters made by his pupil, Loonello d'Este, for in an entry dated 22nd starch 1437 in Archivio di Stato di Modena Ie3.