Sparami Al Petto!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

And Bernardo Bertolucci's 1900
The “Betrayed Resistance” in Valentino Orsini’s Corbari (1970) and Bernardo Bertolucci’s 1900 (1976) Dominic Gavin The connections between Italian film and history have been the object of renewed attention in recent years. A number of studies have provided re-readings of Italian cinema, especially from the perspective of public memory. Charting the interrelations of cinema, the public use of history, and historiography, these studies include reevaluations of the cinema of the Resistance, the war film, the Holocaust and the Fascist dictatorship.1 The ongoing debates over Resistance memory in particular—the “never-ending liberation,” in the words of one historian—have provided a motive for reconsidering popular cultural productions as vehicles of collective perceptions of the past.2 If Italian film studies came relatively late to the issues of cinema and public memory, this approach has now become mainstream.3 In this essay, I am concerned with films on the Resistance during the 1970s. These belong to a wider grouping of contemporary cinematic productions that deal with the Fascist dictatorship and antifascism. These films raise a series of critical questions. How did the general film field contribute to the wider processing of historical memory, and how did it relate to political violence in Italy?4 To what extent did the work of Italian filmmakers participate in the “new discourse” of international cinema in the 1970s concerning the treatment of Nazism and the occupation,5 or to what extent were filmmakers engaged in reaffirming populist -
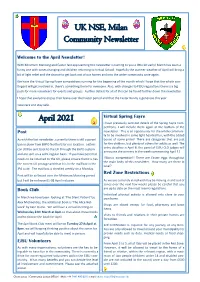
Virtual Spring Fayre Red Zone Restrictions Book Club EJSU
Welcome to the April Newsletter! With Minimum Manning and Easter fast approaching this newsletter is coming to you a little bit early! March has been a funny one with zones changing and children returning to Virtual School. Hopefully the warmer weather of April will bring a bit of light relief and the chance to get back out of our homes and into the wider community once again. We have the Virtual Spring Fayre competitions running for the beginning of the month which I hope that the whole con- tingent will get involved in, there’s something there for everyone. Also, with changes to EJSU regulations there is a big push for more volunteers for events and groups. Further details for all of this can be found further down the newsletter. I hope that everyone enjoys their leave over the Easter period and that the Easter Bunny is generous this year Take care and stay safe. Virtual Spring Fayre I have previously sent out details of the Spring Fayre Com- petitions, I will include them again at the bottom of the Post newsletter. This is an opportunity for the whole communi- ty to be involved in some light hearted fun, with the added As with the last newsletter, currently there is still a parcel bonus of some prizes! There are categories that are just ban in place from BFPO Northolt for our location. Letters for the children, but plenty of others for adults as well. The entry deadline is April 8, the panel of EJSU CLO judges will can still be sent back to the UK through the BFPO system announce the winners in the week commencing April 12. -

Amendola: Mobilitazione Unitaria E Vigilanza Dimassa Perche Gli Organi
s dI n ANNO XIX / NUOVA SERIE / N. 12 pcital< '* e"° grupp« '"o •"»"""1 bis/70•) ic Luntdi 22 mtrzo 1971 / Lire 80 (.rr.tr.ti L. IM) Tito in Italia: Casa: il governo nuove prospettive nei chiamato al rispetto rapporti jugo-italiani degli impegni (A PAGINA 12) ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO (A PAGINA 2) A Bologna una possente dimostrazione antifascista ha concluso il Congresso nazionale dei partigiani CENTOMILA IN PIAZZA CONTRO LA REAZIONE Amendola: mobilitazione unitaria e vigilanza dimassa perche gli organi dello Stato facciano il loro dovere Un grande corteo riafferma gii ideali della Resistenza e li collega ai compiti presenti - Numerosissimi i giovani nella fiumana di popolo - I discorsi di Vecchi, vice-presi- dente del Consiglio regionale, e del senatore Arialdo Banfi: il governo colpisca senza esitazione i responsabili e i mandan*' dei piani eversivi - Le richieste dell'ANPI SEQUESTRATE NUOVE LISTE DI NOMI SU CUI CONTAVANO I SEDIZIOSI DALL'INVIATO BOLOGNA, 21 marzo Con una grande, appassionante, indimenticabile manifestazione popolare si e con cluso questa mattina a Bologna il VII Congresso nazionale dell'ANPI. Non meno di Borghese centomila cittadini hanno sfilato per oltre due ore per le vie del centro per riaffer* mare la decisa volonta di sbarrare la strada al fascismo, sotto qualsiasi forma esso .si manifesti. Preceduti dai gonfaloni delle citta-martiri di Marzabotto e di Boves e e in Grecio? da quello del Comune di Bologna, medaglia d'oro della Resistenza, il corteo dei centomiUi si e poi portato in piazza Maggiore, dove hanno parlato i compagni Banfl, ROMA, 21 marzo vice presidente dell'ANPI, e Giorgio Amendola. -

Dall'internazionale a Fischia Il Vento a Niguarda.Pdf Definitivo.Pdf
Collana Il Cormorano 37 1 TUTTI I DIRITTI RISERVATI ĈIUJ RAJTOJ REZERVITAJ 2011 ISBN 978-88-96028-61-2 © Edizioni Eva Via Annunziata Lunga 29 I 86079 Venafro (IS) Tel. e fax 0865.90.99.50 www.edizionieva.com [email protected] 2 Antonio Masi Dall’Internazionale a Fischia il vento a Niguarda L’insurrezione popolare del 24 aprile e l’impegno per la Costituzione Collaborazione e ricerche di Michele Michelino Introduzione di Roberto Cenati EDIZIONI EVA 3 Ringraziamenti Gli autori ringraziano Antonio Pizzinato, Presidente dell’ANPI della Regione Lombardia per i preziosi consigli e la cortese attenzione con cui ha seguito l’evolversi di questa ricerca; Roberto Cenati e Dante Reggi per la collaborazione in sede di ricerca negli archivi dell’ANPI. Gli Autori non dimenticano il sostegno morale di Renato Vercesi, Sa- muele Brivio, Enzo Piazza e Franco Tucci del Comitato di Sezione Martiri Niguardesi. Un grazie particolare al Presidente della sezione Alberto Codevilla, al vice Angelo Longhi e al tesoriere Silvio Rigoldi, impegnati concreta- mente nella pubblicazione di questo volume. ANTONIO MASI [email protected] MICHELE MICHELINO [email protected] 4 Prefazione Antonio Masi, nato e cresciuto a Venafro ma trasferito a Milano, nel quartiere Niguarda, da quasi cinquarant’anni ormai, ha – possia- mo dire – due patrie. Quando torna a Venafro, sembra non aver mai lasciato il Molise: conosce tutti e lo conoscono tutti, si integra ed è integrato, ma quando è a Niguarda è niguardese piú dei niguardesi di nascita. Due mondi che gli appartengono e dove si trova, nell’uno e nell’altro, a suo agio. -

La Nuova Liberazione
41° CONGRESSO del Partito radicale ROMA 5|7luglio 2019 Auditorium Antonianum Viale Manzoni 1 Testata fondata da Marco Pannella Autorizzazione del Tribunale di Roma Stampa: Word Print srl | Roma Direttore responsabile: Aurelio Candido n. 11673 del 13 luglio 1967 mensile | numero 2 | febbraio-maggio 2019 Alzare tutte le bandiere, rilanciare tutte le lotte ra pochi giorni, tutti gli iscritti al Partito Radicale illiberali ingiuste inefficaci, delle leggi elettorali. Senza tempi non sospetti, ci si è sempre detto che conduciamo potranno partecipare al 41° Congresso: potranno queste riforme non c’è sviluppo politico, di giustizia lotte di avanguardia, ma che tali sono solo per coloro che intervenire, presentare documenti, candidarsi sociale ed anche economico. detengono il potere o aspirano a detenerlo, impegnati F alle massime responsabilità, giudicare e scegliere Ma anche alcuni successi per nulla scontati, l’essere come forsennati a consumare i beni esistenti, senza come e chi dovrà coordinare le attività del Partito. riusciti a tenere il Congresso nel carcere di Rebibbia e le occuparsi di cosa accadrà o potrà accadere portando Sarà ancora un Congresso di transizione, nel senso che conclusioni ottenute in quelle condizioni; l’essere riusciti avanti forsennate politiche di depauperamento dei beni dovremo riflettere non solo su quel che il Partito è stato ed a raccogliere oltre tremila iscritti nel 2017 e nel 2018 con pubblici. Le questioni economico-finanziarie, la povertà, è, ma soprattutto su quel che dovrà essere. il conseguente grande successo di poter convocare lo stato di perenne sottosviluppo e non più solo nel terzo Dovremo innanzitutto capire se nell’attuale contesto ci questo 41° Congresso. -

Cartelli Fine Della Guerra
La ne della guerra Le vie della salvezza verso la Svizzera I percorsi partigiani tra i due laghi A Paths to freedom towards Switzerland B Partisan routes between the two lakes San Siro, località Santa Maria Rezzonico Claino con Osteno. Il capitano Ricci e la prima Resistenza San Siro, Santa Maria Rezzonico Hamlet Claino con Osteno. Captain Ricci and the early Resistance Cremia Porlezza. Il controllo fascista e la guerriglia partigiana Cremia Porlezza. Fascist control and partisan guerrilla Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. Le prime bande fra Porlezza e Galbiga Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. The first armed bands between Porlezza and Galbiga San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Gli sfollamenti sul Lario San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Lake Como evacuations San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. Le residenze di ministri e gerarchi della RSI San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. The Residences of ministers and fascist leaders of the RSI Cavargna Lenno, Monte Galbiga. La prima azione partigiana in centro lago Cavargna Lenno, Monte Galbiga. The first partisan action in the Center Lake region Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Abbazia dell'Acquafredda. La Resistenza civile del clero Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Acquafredda Abbey. Civil Resistance of the clergy Cavargna, Passo di San Lucio e Monte Garzirola Lenno. L'attività del Comitato di Liberazione Nazionale Cavargna, San Lucio Pass and Mount Garzirola Lenno. The activities of the National Liberation Committee Gravedona ed Uniti, Passo di San Iorio Ossuccio, località Boffalora. Crocevia e base partigiana Gravedona ed Uniti, San Iorio Pass Ossuccio, Boffalora Hamlet. Crossroads and partisan headquarters Mezzegra, confine con Lenno. -

The Italian Resistance in Piedmont: Motives and Aspirations
DOI: 10.7763/IPEDR. 2012. V51. 18 The Italian Resistance in Piedmont: Motives and Aspirations + Michael C. Kelly School of Humanities and Social Sciences, Nazarbayev University Abstract. At the end of May, 1945, the forces of the Italian Resistance were in a seemingly impregnable position of power: they had emerged victoriously from an eighteen-month-long armed struggle against the German occupying army and Fascist Republic of Salò; they had liberated the major towns and cities of northern Italy before the arrival of the victorious Allied troops; they had installed Committees of National Liberation (CLN) throughout the north which controlled civil administration and the management of the major industrial enterprises; and their leaders had been installed in power to head a government of national unity under the leadership of the Action Party's (PdA) FerruccioParri.Yet how had this seemingly victorious movement begun? What type of Italians had joined the forces of the Resistance, and equally importantly why? What had motivated the participants in what was an essentially minority, northern Italian phenomenon, and what did they want to achieve? This paper will examine the diverse motives for joining the Resistance struggle during 1943-45, as well as examining the political aspirations of the participants. Through a series of interviews, ex-partisans from the Garibaldi, Justice and Liberty, Matteotti and Autonomi Brigades give fascinating - and varied - responses to these questions. Keywords: Italian Resistance, Partisan Warfare, Guerrilla Warfare, Italian Anti-Fascism. 1. Introduction Italy!! The belpaese – the beautiful country. The imagination runs wild. Images of the rolling hills of Tuscany, the classical cities of Venice, Florence, and the eternal city itself – Rome – come to mind. -

Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VERTICE MINISTRI EUROPEI VENEZIA 17 GIUGNO 2008 RASSEGNA STAMPA STAMPA LOCALE Adige Arena Barisera Ciociaria Oggi-Latina Oggi – Oggi Castelli Corriere Adriatico Corriere del Giorno Corriere del Veneto Corriere Romagna Eco di Bergamo Gazzetta di Lecce Gazzetta di Modena Gazzetta di Parma Gazzetta di Reggio Giornale di Brescia Il Tirreno L’Unione Sarda La Gazzetta di Bari La Nuova Ferrara La Nuova Venezia La Sicilia Mattino di Padova Messaggero Veneto Nuova venezia Nuovo Molise Nuovo Quotidiano Lecce Nuovo Quotidiano Puglia Prealpina Puglia Puglia Oggi Quotidiano di Bari Quotidiano Foggia Repubblica Bari Tribuna di Treviso TV LOCALI E NETWORK 7 Gold Antenna 3 Canale Italia Telechiara Telepadova Televenezia Radio Area Radio veneto 1 FREE PRESS E Polis QUOTIDIANI NAZIONALI Avvenire Corriere della Sera Gazzetta del Sud IL Corriere del Mezzogiorno Il Gazzettino Il Mattino Il Messaggero Il Secolo XIX Il Sole 24 ore Il Tempo Italia Oggi La Discussione La Gazzetta del Mezzogiorno La Padania La Repubblica La Stampa Liberazione Libero Libero Mercato Nazione – Carlino -Giorno Ventiquattrominuti TV E RADIO NAZIONALI Rai Uno Rai Due Rai Tre Rainews24 Italia Uno Canale 5 Rete 4 La7 Sky tg24 Radio Uno Radio Due Radio 24 PERIODICI L’Espresso QUOTIDIANI E PERIODICI 6 GIUGNO ¾ Il Tempo, pag.15: “Ancora proteste contro il gasolio, Zaia: «non bloccate i porti»” ¾ Quotidiano di Foggia, pag. 1: “Pesca e caro-gasolio, una superalleanza per ‘smuovere? Bruxelles” 7 GIUGNO ¾ Il Gazzettino, pag. 13: “Zaia: «A Venezia vertice europeo sulla pesca» ¾ Corriere del Veneto – edizione di Venezia e Mestre – pag. 16. “Pesca, ci sarà un vertice europeo” ¾ Il Sole 24 ore, pag. -

La “Repubblica” Dell'ossola
La “repubblica” dell’Ossola Paolo Bologna La “repubblica” dell’Ossola è certamente la più nota e pesante rastrellamento condotto da numerose truppe prestigiosa delle 18 “zone libere” partigiane che ebbe- tedesche e fasciste nel comprensorio montano della Val ro vita tra estate e autunno 1944 in piena occupazione Grande avesse inferto un duro colpo alle formazioni ivi tedesca1. L’esperienza ossolana prese l’avvio con la resa insediate, la “Valdossola” di Dionigi Superti e le meno dei presidi nazifascisti2 alle forze partigiane, conclusa numerose “Giovane Italia” e “Cesare Battisti”. Su poco nel tardo pomeriggio del 9 settembre 1944 al Crop- meno di 500 partigiani impegnati dagli attaccanti, qua- po di Trontano all’immediata periferia di Domodosso- si 300 erano caduti in combattimento o nelle allucinan- la. La trattativa tra ufficiali partigiani (delle formazio- ti fucilazioni (quasi sempre precedute, in questa e in al- ni “Valdossola” e “Valtoce”), tedeschi e della Milizia fa- tre occasioni, da sevizie inferte ai prigionieri) seguite al scista, fu abilmente mediata dai parroci di Masera, don rastrellamento. In dieci giorni, dal 17 al 27 giugno e in Severino Baldoni, e di Domodossola don Luigi Pellan- nove località diverse i fucilati furono circa un centinaio da. Questi seppero ben rappresentare alla delegazione tra cui, il giorno 20, le quarantadue vittime di Fondo- tedesco-fascista la convenienza di venire a un rapido ac- toce. Un 43° prigioniero compreso fra i morituri, il di- cordo con le due formazioni “autonome”, considerate ciottenne Carlo Suzzi di Busto Arsizio riuscì a salvar- moderate, approfittando dell’assenza dei più temibili si benché ferito, uscendo nottetempo dall’ammasso dei “garibaldini”. -

Il Fondo ANPI Della Biblioteca Corticella
Il Fondo ANPI della Biblioteca Corticella Via Gorki 14 Corticella ( Bologna) Tel. 051 700972 [email protected] N.Inv.: CN D 13325 ANPI 261 LAV *Pacem in terris : l'enciclica della liberazione / Raniero La Valle. - San Domenico, Fiesole : Cultura della pace, 1987 N.Inv.: CN D 13477 ANPI 320 LAV La *voce della Resistenza : *antologia del 1. decennio di "Patria indipendente" 1952-1961 / introduzione di Lucio Cecchini. - Roma : a cura del Comitato nazionale dell'ANPI, stampa 1981 N.Inv.: CN D 13335 ANPI 324 COM I *comunisti e la società italiana / a cura di Ettore A. Albertoni, Berta Berti, Sergio Mariani ; [scritti di Amendola ... et al.]. - [S.l. : s.n.], 1962 N.Inv.: CN D 13396 ANPI 324 GAL *Storia del Partito comunista italiano / Giorgio Galli. - Milano : Schwarz, 1958. N.Inv.: CN D 13481 ANPI 324 NED *Faenza e Rimini sotto la dittatura : contributo alla storia dell'antifascismo e della Resistenza repubblicana 1919-1945 / Bruno Nediani ; prefazione di Oddo Biasini. - [S.l.] N.Inv.: CN D 13323 ANPI 324 RIN *Rinascita : 1947. - Roma : Editori Riuniti, stampa 1976. N.Inv.: CN D 13324 ANPI 324 RIN *Rinascita : 1944-1945. - Roma : Editori Riuniti, 1974. N.Inv.: CN D 13385 ANPI 324 ROB *Trent'anni di lotte dei comunisti italiani : 1921-1951 / Paolo Robotti, Giovanni Germanetto. - Roma : Edizioni di cultura sociale, 1952 N.Inv.: CN D 13375 ANPI 324 SEC L'*azione svolta dal partito comunista in Italia durante il fascismo, 1926- 1932 : ricordi, documenti inediti e testimonianze / Pietro Secchia. - Milano : Feltrinelli, 1970 N.Inv.: CN D 13327 ANPI 324 SET L'*uomo qualunque : 1944-1948 / Sandro Setta. -

Elettorato Studenti
Elezioni per il rinnovo del CNSU - 14 e 15 Maggio 2019 Elettorato - Studenti iscritti a CdL, CdLM, CdLS, Laurea a CU, v.o. e n.o. COGNOME NOME Data Nascita ABASCIÀ MAURIZIO 27/08/1997 ABATANTUONO ANTONIO 17/12/1998 ABATE ALESSIA 27/06/1993 ABATE ERICA 11/08/1992 ABATE MARCO 06/07/1998 ABATE SIMONE 03/03/1999 ABBADESSA MARIALAURA 21/01/1995 ABBAS MOTANA 19/08/1990 ABBATE CINZIA 19/02/1998 ABBATECOLA VITO NICOLA 07/09/1999 ABBATEMATTEO ROBERTA 18/03/1995 ABBATERUSSO SONIA 16/11/1985 ABBATESCIANNI PAOLA GIULIA 17/06/1998 ABBATI CHIARA 25/11/1994 ABBENANTE ANDREA PASQUALE 29/04/1989 ABBENANTE VINCENZO ANTONIO 04/06/1997 ABBONDANDOLO NUNZIO 06/03/1997 ABBONDANZA DOMENICA 22/05/1997 ABBONDANZA MARTINA 01/09/1994 ABBONIZIO DALILA 07/09/1994 ABBONIZIO DONATELLA 09/08/1996 ABBONIZIO ERIKA 14/07/1995 ABBONIZIO FEDERICO 07/08/1997 ABBONIZIO FRANCESCO 30/12/1999 ABBONIZIO MONICA 16/02/1998 ABBONIZIO PAMELA 16/08/1997 ABBONIZIO VERONICA 13/04/1997 ABBRACCIAVENTO ANNALISA 04/07/1998 ABBRACCIAVENTO VALERIA 30/01/1998 ABBRUZZESE ANTONELLA 31/08/1999 ABDALLAH RANA HUSAM MASOUD 18/04/1992 ABDUL SATER ALI 11/09/1990 ABENANTE ANTONIO 12/06/1994 ABISSINO ANNA 16/05/1980 ABISSINO DIEGO 03/11/1981 ABITANTE ROSA 03/06/1987 ABIUSO LAURA 11/08/1997 ABIUSO SOFIA 13/10/1993 ABRUGIATI MIRIANA 17/01/2000 ABRUGIATO ELENA 11/05/1997 ABRUGIATO SIMONA 25/10/1995 ABRUSCI NICOLE 18/06/1995 ABRUZZESE ANDREA 28/01/2000 ABRUZZESE ANGELA 07/05/1998 ABRUZZESE CRISTINA 12/07/1997 ABRUZZESE MICHELANGELO 22/09/1996 ABRUZZESE VINCENZO 01/11/1995 ABU AHMAD MIRIAM 24/12/1999 ABU EID MIRIAM 16/09/1994 ABU JABER ISLAM 10/01/1996 ABUKHRIS SAMIRA 14/05/1996 ABUNDO DANIELE 13/10/1995 Pagina 1 di 454 Elezioni per il rinnovo del CNSU - 14 e 15 Maggio 2019 Elettorato - Studenti iscritti a CdL, CdLM, CdLS, Laurea a CU, v.o. -

The Electric Cityof Como Awaits
INSIDE: The Gardens at Villa Carlotta 2 What to See in Bellagio 5 m o c . Where to Stay on Lake Como 6 r k c i l f , n e Visiting Gravedona 8 g n i r m u o u c . b r n k a c i v l f n i , n w i l d d e u a M Lake Como at night a i l u SPECIAL REPORT: LAKE COMO J Bellagio Two Lake Como dream of ® Villages etyon d Ethex ciptyl oof Crome o, the lake itself is Italy’s deepest (though not its biggest: nearby LBake Garda has that honor, followed by Lake Maggiore ) and is often Volume 13, Issue 10 www.dreamofitaly.com December 2014/January 2015 referred to as Italy’s prettiest. With ITA LY its truly stunning scenery and historical significance, including World War II history in the village The Electric City of Como Awaits of Dongo (see sidebar), where Mussolini and other fascist ministers taly is preparing to welcome from Como directly to the Expo is were captured on April 27, 1945, record numbers of visitors in expected to open soon. opportunities for a variety of I 2015 when Milan hosts the outdoor pursuits also abound. Universal Exposition for six months, The “New City” from May through October. There are gorgeous villas built More than 20 million people Culturally and historically, between 1500 and 1800 that are are expected (eight million Como is large enough to open to the public; lush gardens that from outside the European boast plenty of interest, thrive even in the winter months Union) and many of them though it retains a very due to a unique eco-climate; will travel beyond relaxed feel.