Nuova Serie (1978)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Acollection of Correspondence
© 2012 Capuchin Friars of Australia. All Rights Reserved. A COLLECTION OF CORRESPONDENCE Some Letters … and other things, from Sixteenth Century Italy in their original languages Bernardo, ben potea bastarvi averne Co’l dolce dir, ch’a voi natura infonde, Qui dove ‘l re de’ fiume ha più chiare onde, Acceso i cori a le sante opre eterne; Ché se pur sono in voi pure l’interne Voglie, e la vita al destin corrisponde, Non uom di frale carne e d’ossa immonde, Ma sète un voi de le schiere sperne. Or le finte apparenze, e ‘l ballo, e ‘l suono, Chiesti dal tempo e da l’antica usanza, A che così da voi vietate sono? Non fôra santità,capdox fôra arroganza Tôrre il libero arbitrio, il maggior dono Che Dio ne diè ne la primera stanza.1 Compiled by Paul Hanbridge Fourth edition, formerly “A Sixteenth Century Carteggio” Rome, 2007, 2008, Dec 2009 1 “Bernardo, it should be enough for you / With that sweet speech infused in you by Nature, / To light our hearts to high eternal works, / Here where the King of Rivers flows most clearly. / Since your own inner wishes are sincere, / And your own life reflects a pure intent, / You’re ra- ther an inhabitant of heaven. /As to these masquerades, dances, and music, /Sanctioned by time and by ancient custom - /Why do you now forbid them in your sermons? /Holiness it is not, but arrogance to take away free will, the highest gift/ Which God bestowed on us from the begin- ning.” Tullia d’Aragona (c. -
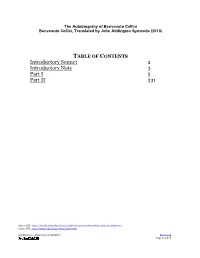
ARTH206-The Autobiography of Benvenuto
The Autobiograhy of Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini, Translated by John Addington Symonds (2010) TABLE OF CONTENTS Introductory Sonnet 2 Introductory Note 3 Part I 5 Part II 331 Source URL: http://ebooks.adelaide.edu.au/c/cellini/benvenuto/autobiography/complete.html Saylor URL: http://www.saylor.org/courses/arth206/ Attributed to: [University of Adelaide] Saylor.org Page 1 of 571 INTRODUCTORY SONNET THIS tale of my sore-troubled life I write, To thank the God of nature, who conveyed My soul to me, and with such care hath stayed That divers noble deeds I’ve brought to light. ’Twas He subdued my cruel fortune’s spite: Life glory virtue measureless hath made Such grace worth beauty be through me displayed That few can rival, none surpass me quite. Only it grieves me when I understand What precious time in vanity I’ve spent- The wind it beareth man’s frail thoughts away. Yet, since remorse avails not, I’m content, As erst I came, WELCOME to go one day, Here in the Flower of this fair Tuscan land. Source URL: http://ebooks.adelaide.edu.au/c/cellini/benvenuto/autobiography/complete.html Saylor URL: http://www.saylor.org/courses/arth206/ Attributed to: [University of Adelaide] Saylor.org Page 2 of 571 INTRODUCTORY NOTE AMONG the vast number of men who have thought fit to write down the history of their own lives, three or four have achieved masterpieces which stand out preeminently: Saint Augustine in his “Confessions,” Samuel Pepys in his “Diary,” Rousseau in his “Confessions.” It is among these extraordinary documents, and unsurpassed by any of them, that the autobiography of Benvenuto Cellini takes its place. -

I Vescovi Di Brescia
I VESCOVI DI BRESCIA RICERCA BIBLIOGRAFICA A CmDI CHZARA MONTLM E OIhNEWLO VALETII ATENE0 DI BRESCIA ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI MCMLXXXVII Il volume è pubblicato con il concorso della Cassa di Risparmio delle Provincie Lornbarde, che ha inteso così ricordare il Presidente dell'Ateneo di Brescia, Senatore Albino Donati, già suo Consigliere di Amministra- zione. I VESCOVI DI BRESCIA RICERCA BIBLIOGRAFICA A CURA DI CHIARA MONTINI E ORNELLO VALEITi ATENE0 DI BRESCIA ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI McMLxxxvII SUPPLEMENTO AI COMMENTAR1 DELL'ATENEO DI BRESCIA PER L'ANNO 1987 Direttore responsabile: Ugo Vaglia Autorizzazione del Tribunale di Brescia N. 64 in data 21 gennaio 1953 - Tipo-Lito Fratelli GeroZdi - Brescia - 1987 Premessa L'ecclesiologia del Concilio Vaticano I1 ha determinato senza dub- bio un ricco e intenso progresso delle scienze storico-religiose in am- bito europeo e, particolarmente, italiano. Gli orizzonti della storiografia religiosa si sono ampiamente dila- tati e, al contempo, hanno sensibilmente affinato il metodo euristi- co, alimentando nuovi e rilevanti campi di indagine. Particolarmente significativa l'attenzione storiografica accordata da- gli studiosi italiani, sulla scorta di illustri e rigorosi precorrimenti d'oltralpe, alla dimensione locale, territorialmente definita e circo- scritta, della vita religiosa ed ecclesiale nella sua articolazione e complessità. La diocesi quindi e il suo pastore, costituircono sem- pre piu il soggetto storico della ricerca e dell'indagine archivistica e documentaria in genere. Archivi e biblioteche civiche e di stato, archivi parrocchiali e vescovili, di ordini e congregazioni religiose, di sodalizi pii e di confraternite, capitolari e diocesani, di seminarì e di istituzioni laicali cattoliche, rappresentano i luoghi pih idonei per una esplorazione archivistica e una consultazione bibliografica pertinente e proficua. -

Negotiating the Sacred: Spirituality and Reform in the Age of Enlightenment in the Republic of Venice Simonetta Marin University of Miami, [email protected]
University of Miami Scholarly Repository Open Access Dissertations Electronic Theses and Dissertations 2014-04-29 Negotiating the Sacred: Spirituality and Reform in the Age of Enlightenment in the Republic of Venice Simonetta Marin University of Miami, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations Recommended Citation Marin, Simonetta, "Negotiating the Sacred: Spirituality and Reform in the Age of Enlightenment in the Republic of Venice" (2014). Open Access Dissertations. 1190. https://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/1190 This Embargoed is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at Scholarly Repository. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of Scholarly Repository. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF MIAMI NEGOTIATING THE SACRED: SPIRITUALITY AND REFORM IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT IN THE REPUBLIC OF VENICE By Simonetta Marin A DISSERTATION Submitted to the Faculty of the University of Miami in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Coral Gables, Florida May 2014 ©2014 Simonetta Marin All Rights Reserved UNIVERSITY OF MIAMI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy NEGOTIATING THE SACRED: SPIRITUALITY AND REFORM IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT IN THE REPUBLIC OF VENICE Simonetta Marin Approved: ________________ _________________ Guido Ruggiero, Ph.D. Mary Lindemann, Ph.D. Professor and Chair Professor of History _________________ _________________ Steve Stein, Ph.D. Hugh Thomas, Ph.D. Professor of History Professor of History _________________ _________________ Laura Giannetti, Ph.D. -

Scrolls Camerino 1240-1822
Archivio di Stato di Macerata – Sezione di Camerino SCROLLS FROM THE MUNICIPALITY PERGAMENE DEL COMUNE DI OF CAMERINO 1240-1822 CAMERINO 1240-1822 January 27, 1240 1240 gennaio 27 A1- Special privilege of cardinal Sinibaldus A1- Privilegio del cardinale Sinibaldo Fliscus, Papal legate in the March, about the Fieschi, legato della Marca, sulla jurisdiction over the Municipality of Camerino. giurisdizione del Comune di Camerino. (Authentication of the copy is missing) (L'autenticazione della copia manca nella pergamena) August 5, 1256 1256 agosto 5 A2- Rinaldo from Cingoli, judge of the A2- Rinaldo da Cingoli, giudice del Comune Municipality of Camerino under mayor di Camerino per il podestà Rinaldo da Rinaldo from Brunforte, orders the town Brunforte, ordina che il sindaco del Comune attorney to pay 47 “ravennati e anconetane” medesimo paghi 47 libre e mezzo ravennati e libras [pounds from Ravenna and Ancona, anconetane [d’ora in avanti abbr. in libre rav. following abbr. rav. and anc. libras] and a half e anc.] a Federico di Alberico, ricevente a to Frederick son of Alberico, who cashes in on nome dello zio Migliorato di Diotisalvi. behalf of his uncle Migliorato son of In Camerino, nel palazzo dei figli di Berardo Diotisalvi. di Venuto. Camerino, Berardo-di-Venuto’s-sons’ Palace. Notary Paganello son of Benvenuto. Paganello di Benvenuto, notaio. August 5, 1256 1256 agosto 5 A3- On behalf of Jacob son of Benvenuto, A3- Paganello di Giovanni promette a Paganello son of John guarantees the payment Federico di Alberico, ricevente per Migliorato of 47 rav. and anc. libras and a half to di Diotisalvi suo zio, che curerà il Frederick son of Alberico, who cashes in on mantenimento della promessa fattagli da behalf of his uncle Migliorato son of Jacopo di Benvenuto, consistente nel Diotisalvi. -

The Harvard Classics Eboxed
^ARVAR HEFIV£-FOOT rOF BOOKS ,UTOB;OGRAPHy BENVt NUTO CELLINI ^Owcsos^trw::: -W^.ik.-'i-i'v^, QgmB OB Ok ila i r THE HARVARD CLASSICS The Five-Foot Shelf of Books i I Perseus with Head of the slain Medusa By Benvenuto Cellini From the bronze statue in the Natiotid Muieum, Florence I THE HARVARD CLASSICS EDITED BY CHARLES W. ELIOT, LL.D. The Autobiography of Benvenuto Cellini TRANSLATED BY JOHN ADDINGTON SYMONDS W/VA Introduction and 'Notes Yolume 31 P. F. Collier & Son Corporation NEW YORK Copyright, 1910 By p. F. Collier & Son manufactured in u. s. a. THE AUTOBIOGRAPHY OF BENVENUTO CELLINI This tale of my sore-troubled life I write, To THANK THE GoD OF NATURE, WHO CONVEYED My SOUL TO ME, AND WITH SUCH CARE HATH STAYED That divers noble deeds I've brought to light. 'TwAS He subdued my cruel fortune's spite: Life glory virtue measureless hath made Such grace worth beauty be through me displayed That few can rival, none surpass me quite. Only it grieves me when I understand What precious time in vanity I've spent— The wind it beareth man's frail thoughts away. Yet, since remorse avails not, I'm content. As ERST I came, welcome to go one day. Here in the Flower of this fair Tuscan land. INTRODUCTORY NOTE Among the vast number of men who have thought fit to write down the history of their own lives, three or four have achieved masterpieces which stand out preeminent: Saint Augustine in his "Confessions," Samuel Pepys in his "Diary," Rousseau in his "Confessions." It is among these extraordinary documents, and unsurpassed by any of them, that the autobiography of Benvenuto Cellini takes its place. -

9. Livio Antonielli (A Cura Di), Le Polizie Informali (2010)
STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO Studi a cura di Livio Antonielli 9 Le polizie informali [Seminario di Studi, Messina, 28-29 novembre 2003] a cura di Livio Antonielli Rubbettino © 2010 - Rubbettino Editore 88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201 www.rubbettino.it Livio Antonielli Introduzione e… altro Riesco solo ora, con grave ritardo, a dare alle stampe gli Atti dell’in- contro di studi tenutosi a Messina, nello splendido scenario di Villa Pa- ce, il 28 e 29 novembre 2003, sotto il titolo Le polizie informali. Ragioni di finanziamento, ma non solo, hanno frenato la pubblicazione: ma non è su questo che merita soffermarsi. Quello delle polizie informali era il sesto di una serie di incontri scien- tifici da me organizzati su temi relativi al controllo del territorio, declina- to da diverse prospettive, dal militare alle carceri, dai corpi paramilitari alle polizie d’antico regime. In quella occasione io stesso avevo presentato un mio contributo, dal titolo Nuove vesti per antichi contenuti: ambiguità nel controllo dell’ordine pubblico (il caso dello Stato di Milano), e a questo intervento fanno riferimento, nelle pagine del volume dedicate alla di- scussione, coloro che mi citano. In quell’occasione avevo cercato, attra- verso l’analisi di alcuni casi particolari, di chiarire cosa intendessi con la dizione, davvero piuttosto ambigua, di «polizia in formale». Rileggendo però ora, a distanza di tempo, i contributi dei partecipanti all’incontro, nonché i testi della discussione, mi sono reso conto che il problema di co- sa si dovesse intendere per «polizia informale» se lo sono posti, in manie- ra esplicita, gran parte dei partecipanti all’incontro.