Dizionario Di Chiaveranese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
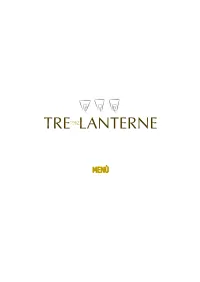
MD-Document-620Dc7b6-3B7e-4F61-Ba8e
MENÙ Fondato da Annita Vecchierelli e Vincenzo Nozza nel 1962, il ristorante Tre lanterne rappresenta da sempre un punto di riferimento per la buona cucina italiana nel territorio della bassa pianura bergamasca. Nel tempo il ristorante Tre lanterne è divenuto anche pizzeria, con le sue ormai famose schiacciate, proposte in più di ottanta diverse farciture. Espressione di una tradizione del gusto, i piatti conservano ancora oggi la semplicità e la genuinità di una cucina familiare, dove la qualità è assicurata dalla passione per il “buon mangiare” e per il “buon bere”. Hamburgheria Hamburger di carne Classic burger € 12,00 150g macinata scelta, cipolla caramellata, maionese, salsa pomodoro e mozzarella Sfizioso burger € 12,00 150g macinata scelta, foglia di spinacino, crema di formaggio tartufato e philadelphia Gallinaccio burger € 12,00 150g macinata scelta, insalata iceberg, mozzarella, uovo fritto, bacon e maionese Hamburger vegetariani Bufalo burger € 12,00 burger di verdure grigliate, mozzarella di bufala, rucola e maionese Ligure burger € 12,00 burger di verdure grigliate, philadelphia, pesto e pomodori secchi Tutti i nostri hamburger sono serviti con patatine fritte, ketchup e maionese Antipasti Tagliere di salumi lombardo con scamorza alla brace e polenta € 10,00 (salame bergamasco, pancetta steccata, fiocco di crudo, lonzino, mortadella del Berlinghetto) Culatello di Parma con bufala e gnocco fritto € 13,00 Tartare di fassona con vinegrette al tartufo e € 13,00 insalatina di carciofi Uovo fritto con asparagi e bacon croccante € -

I Nostri Primi Piatti I Nostri Risotti
I NOSTRI PRIMI PIATTI I NOSTRI RISOTTI Risotto con Zucchine e pistilli di Zafferano al naturale Risotto con asparagi mantecato con Raspadura lodigiana Risotto con carciofi stufati, salsiccia e zafferano Risotto con radicchio di Treviso e scamorza leggermente affumicata Risotto con ragu d’anatra e piccole verdure Risotto con fiori di zucca Risotto con vellutata di zucca e pepe rosa Risotto con vellutata di zucca e polpa di granchio reale profumata al timo Risotto con fantasia di ortaggi profumato al basilico Risotto con funghi Porcini Risotto con spinacini novelli e provola dolce Risotto con salmone affumicato e germogli di valeriana Risotto con funghi e salsiccia Risotto con scampi ed asparagi in crema di scampi Risotto con gamberi e zucchine Risotto al nero di seppia con ragu di seppie Risotto allo champagne e rosmarino Risotto alla mousse di peperone dolce e gamberi o taleggio Risotto con capesante e zucchine Risotto ai frutti di mare LE NOSTRE PASTE RIPIENE Crespelle con funghi Porcini Crespelle con radicchio e ricotta stagionata Crespelle con taleggio e bronoise di zucchine Crespelle con prosciutto e formaggio Crespelle con carciofi Crespelle con ricotta e gorgonzola Ravioli con radicchio e speck Ravioli agli asparagi Ravioli al branzino in guazzetti di cozze Ravioli d’oca con burro versato piccole verdure e grana padano Ravioli di zucca Tortellone al formaggio e noci Ravioloni al nero di seppie ripieni al salmone in sugo di salmone e maggiorana Lasagnette con funghi Porcini Lasagnette con ragu leggero Lasagnette con asparagi e Raspadura -

| Hai Lala at Tata Ta Mo Na Atau
|HAI LALA AT TATAUS009883690B2 TA MO NA ATAU HUT (12 ) United States Patent ( 10 ) Patent No. : US 9 , 883 ,690 B2 Weinberg - Sehayek et al. (45 ) Date of Patent: * Feb . 6 , 2018 (54 ) READY - TO - EAT FRESH SPAGHETTI -LIKE (56 ) References Cited FISH PRODUCTS , METHODS OF MANUFACTURE THEREOF U . S . PATENT DOCUMENTS 4 , 704 , 291 A * 11/ 1987 Nagasaki A23L 17 / 70 (71 ) Applicant: GRADIENT AQUACULTURE 426 /513 ( 72 ) Inventors : Noam Weinberg -Sehayek , Shenzhen 4 ,806 , 378 A 2 /1989 Ueno et al. ( CN ) ; Avraham Weinberg , Kiryat Yam (Continued ) ( IL ) FOREIGN PATENT DOCUMENTS ( 73 ) Assignee : GRADIENT AQUACULTURE , CN 101011164 A 8 /2007 Shenzhen (CN ) CULTURE, CN 101209113 A 7 /2008 (Continued ) ( * ) Notice : Subject to any disclaimer , the term of this patent is extended or adjusted under 35 U . S . C . 154 ( b ) by 0 days . OTHER PUBLICATIONS This patent is subject to a terminal dis Rolls B . J . et al ., “ How flavour and appearance affect human claimer . feeding ” , Proceedings of Nutritions Society , Jun . 1982, Great Brit ain , vol. 42 , No. 109 , pp . 109 - 117 . (21 ) Appl. No. : 15 / 262 , 211 (Continued ) (22 ) Filed : Sep . 12 , 2016 Primary Examiner — Robert A Wax Assistant Examiner — Melissa Mercier (65 ) Prior Publication Data US 2017 /0049138 A1 Feb . 23 , 2017 (57 ) ABSTRACT The present invention provides a pasta - like shaped edible Related U . S . Application Data product comprising surimi, fish or portions thereof, prepared (63 ) Continuation - in -part of application No . 14 /601 , 765 , by a process consisting of the steps of: a . chopping frozen surimi to chips ; filed on Jan . 21 , 2015 , which is a continuation - in - part b . -
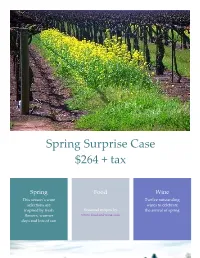
Spring Surprise Case 2020
Spring Surprise Case $264 + tax Spring Food Wine This season’s wine Twelve outstanding selections are wines to celebrate inspired by fresh Seasonal recipes by the arrival of spring flowers, warmer www.foodandwine.com days and lots of sun Twenty Mile Bench, Ca nada Spicy Linguine with Clams 1/4 cup extra-virgin olive oil 1 ounce hot capocollo or soppressata, cut into 1/4-inch diced 4 garlic cloves, thinly sliced Leaning Post 1/2 teaspoon crushed red pepper Riesling 6 tablespoons of Leaning Post Riesling (this wine pairing) 32 Manila or littleneck clams, scrubbed Nadia and Ilya have had to 3/4 pound linguine rely on the support of family Freshly ground black pepper and friends to make a dream 2 tablespoons each of thinly sliced mint and basil of owning their own winery on their home property in Winona, Ontario a reality. A In a deep skillet, heat the oil. Add the capocollo, garlic and leaning post is what you find crushed red pepper and cook over moderately low heat until the at the beginning of a row of garlic is golden, 1 1/2 minutes. Add the wine and bring to a boil grapes, anchoring the over moderately high heat. Add the clams, cover and cook for 5 framework for growing to 8 minutes; as the clams open, transfer them to a covered bowl. grapevines. Fresh and lively, this Riesling is the perfect In a pot of boiling salted water, cook the pasta until almost al example of what to expect dente. Drain, reserving 3/4 cup of the cooking water. -

Basilicata: Italy's Best-Kept Secret
This copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non-personal use, please contact client relations at 1-866-831-4314 or email [email protected]. THIS MONTH: DISCOVERIES IN SOUTHERN ITALY AND NANTUCKET ONLINE: INTERVIEW WITH FRANCIS MALLMANN FEBRUARY 2018 SINCE 1979 Traveling the world in search of truly enchanting places The old town of Matera, a collection of ancient troglodyte dwellings, some of which are now boutique hotels BASILICATA: ITALY’S BEST-KEPT SECRET Extraordinary hotels, untouched landscapes, distinctive cuisine asilicata is one of the most remote cooking style and some excellent little- and timeless atmosphere will doubtless Band least visited parts of Italy, but known wines. Its true gem is the town of be discovered by many more travelers during a recent road trip, we discovered Matera. Continuously inhabited for more when the city becomes one of Europe’s a fascinating and stunningly beautiful than 9,000 years, Matera is both a modern two Capitals of Culture in 2019. region that will remain long in the town, where most of its inhabitants Basilicata has no major airport of its memory. The sere southern Italian live today, and an old town, which was own, and its gateway is the city of Bari in landscape is marked by dramatic cocoa- originally a troglodyte settlement, with the neighboring province of Puglia. In the colored ravines, rolling fields of golden caves bored into the soft vanilla-colored early 20th century, Basilicata lost much wheat and white villages perched on limestone of a bluff. -

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,462.825 B2 Weinberg-Sehayek Et Al
USOO9462825B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,462.825 B2 Weinberg-Sehayek et al. (45) Date of Patent: Oct. 11, 2016 (54) SPAGHETTI-LIKE FISH PRODUCTS, (2013.01); A23L I/296 (2013.01); A23L I/307 METHODS OF MANUFACTURE THEREOF (2013.01); A23 V 2002/00 (2013.01) (58) Field of Classification Search (71) Applicant: GRADIENT AOUACULTURE, None Shenzhen (CN) See application file for complete search history. (72) Inventors: Noam Weinberg-Sehayek, Emek Hefer (56) References Cited (IL); Avraham Weinberg, Kiryat Yam (IL) U.S. PATENT DOCUMENTS (73) Assignee: GRADIENT AOUACULTURE, 4,704.291 A *ck 11/1987 Nagasaki .............. A33. Shenzhen (CN) 4,806,378 A 2f1989 Ueno et al. 5,028,444 A 7, 1991 Yamamoto et al. (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this . S. A E. KEY. patent is extended or adjusted under 35 4- 4 - aCal C. a. U.S.C. 154(b) by 0 days. 2007/0172575 A1* 7, 2007 Gune ............................ 426,641 (21) Appl. No.: 14/601,765 OTHER PUBLICATIONS (22) Filed: Jan. 21, 2015 Omega 6 and 3 in nuts, oils, meats, and fish. Tools to get it right, e a?- posted online May 10, 2011.* O O The Fat Content of Fish, available online 2004. (65) Prior Publication Data Rolls et al. "How Flavour and Appearance Affect Human Feeding”. US 2015/O132434 A1 Mayy 14, 2015 Proceedings of the Nutrition Society, Jun. 1982, pp. 109-117, vol. 41, 109, Great Britain. Related U.S. Application Data (Continued) (63) Continuation-in-part of application No. Primary Examiner — Robert A Wax PCT/IB2014/063294, filed on Jul 22, 2014. -

Einkauftipps Ohne Kuhmilch Coop, Migros, Denner
Einkauftipps ohne Kuhmilch Coop, Migros, Denner Migros Brot 3-Saatenbrot, Balser Ruchbrot, Bernd, Finnenbrot, Frischback Kloster-Baguette, Frischback Semmeli, Frischback-Krustenbrot, Gascon, Hirtenbrot, Kürbiskernbrot, Nussbrot, Olivenbrot, Paillasse, Panetti, Pitta, Pitta Oregano, Pumpernickel Bio, Rapunzel Bio, Roggenbrot, Roggenschrotbrot Bio, Semmeli, Sonnenblumenkernenbrot, Tessinerbrot, Toast-Vollkornbrot, Walliser Roggenbrot Bio, ZüriBürli Knäckebrot Darvida-Cracker, Darvida-Sesam, Nutricia Glutafin Fibre Crackers , Krisprolls Schwedebrötchen, Roland- Delikatess, Wasa Sesam Frühstück 5-Korn-Flocken, Bio Birchermüesli, Bio Cornflakes, Bio Haferflöckli, Cheerios, CornFlakes Kellogs, Crip Rice, Day Vita Flakes Früchte, Frosties, Frosties mit wenig Zucker, Hirseflocken, Maisflocken, Reddy Bio Müesli, Reddy Birchermüesli, Rustica Bio Dinkel, Rustica Bio Hafer, Rustica Bio Hirse, Topas Riegel, Weetabix, Zwieback M-Budget Margarine Balance, M-Budget, Rapunzel Bio Prima Margarine, Sanissa Classic Pasta • Agnesi: Alle Agnesi-Teigwaren, • Barilla: Ditali, Farfalle, Fusilli, Penne Lisce, Maccheroni, Penne Rigate, Spaghetti, Spaghettini, Spaghettoni, Tortiglioni • De Cecco: Casareccia, Conchiglie rigate, Farfalle, Fusilli, Orecchiette, Penne Rigate, Spaghetti, Farfalle Tricolore, Penne Rigate Tricolore • Glutafin: Fusilli, Penne, Spaghetti • Napoli Gemelli, Penne rigate, Pennette, Rigatoni, Spaghettini, Tagliatelle • Selection: Lanterne, Molloni, Spaghetti, Straccetti • Diverse: Bio Dinkel Tagliatelle, Bio Spaghetti Vollkorn Reis Risotto Milanese, -

Franco's Italy Pasta Shape Guide
Franco’s Italy Pasta Shape Guide According to some estimates there over 350 different pasta shapes. We have cataloged a large number and will update this list when the information becomes available. Unique Shapes 1. Campanelle Flattened bell-shaped pasta with a frilly edge on one end like little bells 2. Capunti Short convex ovals resembling an open empty pea pod 3. Casarecce Short lengths rolled into an S shape (from casereccio Translation homemade) 4. Cavatelli Short, solid lengths from the verb cavare Translation to hollow 5. Cencioni Petal shaped, slightly curved with rough convex side like little rags 6. Conchiglie Seashell shaped 7. Conchiglioni Large seashell-shaped like a Conch shell 8. Corzetti Flat figure-eight stamped 9. Creste di Galli Short, curved and ruffled resembling a Cock’s combs 10. Croxetti Flat coin-shaped discs stamped with coats of arms like little crosses 11. Farfalle Bow tie or butterfly shaped Farfalle refers to Butterflies 12. Farfallone Larger bowties large butterfly 13. Fiori Shaped like little flowers 14. Foglie d’ulivo Shaped like an olive leaf 15. Fusilli Three-edged spiral, usually in mixed colors. Many vendors and brands sold as fusilli are two-edged. From fusile, archaic/dialect form of fucile, Translation rifle. As the inside barrel of a gun is “rifled” using a similar screw-shaped device 16. Fusilli Bucati A spring-shaped variety of the above 17. Gemelli A single S-shaped strand of pasta twisted in a loose spiral Translation “twins” 18. Gigli Cone or flower shaped like lilies 19. Gnocchi Round in shape and often made with flour plus potatoes. -

Si Cucina Sempre Pensando a Qualcuno Altrimenti Stai Solo Preparando Da Mangiare
Si cucina sempre pensando a qualcuno altrimenti stai solo preparando da mangiare When you cook, you're always thinking about who you're preparing for, otherwise you're just making something to eat. (EGYZIA, TWITTER) Antipasti / STARTERS Guancialino di vitello in crosta di pasta sfoglia con morbida crema 16 di castagne e olio al tartufo / Veal cheek lard “ en croute” of puff pastry with soft chestnuts cream and truffle oil Carpaccio di ombrina con timo e cruditè di mela verde 12 / Croaker Fish Carpaccio with thyme and green apple crudités Tartare di manzo piemontese con vellutata di funghi porcini, scaglie di 15 castelmagno e nocciole tostate / Piedmontese Beef Tartare served with a velvet porcini mushrooms cream, Castelmagno cheese flakes and toasted hazelnuts Tartare di tonno con finocchietto selvatico, anacardi tostati e spicchi di mandarino 14 / tuna Fish Tartare with wild fennel, toasted cashews and mandarin cloves Burrata campana con disco di pomodoro San Marzano gelèe e colata di clorofilla al basilico 10 / Campania Burrata served with San Marzano tomato gelée and chlorophyll basil topping Selezione di salumi nostrani con slinzega di suino (bresaola) di produzione biologica 14 Lardo speziato, prosciutto di Parma (12 mesi stagionatura), salame con moscato e fragole di bosco / Cold Cuts selection with air-cured slinzega pork from biological production, aromatic lard, Parma Ham ( 12 months aging), salami with moscato wine and wild strawberries Primi / MAIN COURSES Risotto rosso integrale mantecato al barba blù di capra, con scaglie -
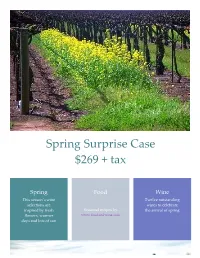
Spring Surprise Case 2020
Spring Surprise Case $269 + tax Spring Food Wine This season’s wine Twelve outstanding selections are wines to celebrate inspired by fresh Seasonal recipes by the arrival of spring flowers, warmer www.foodandwine.com days and lots of sun Twenty Mile Bench, Canada Spicy Linguine with Clams 1/4 cup extra-virgin olive oil 1 ounce hot capocollo or soppressata, cut into 1/4-inch diced 4 garlic cloves, thinly sliced Leaning Post 1/2 teaspoon crushed red pepper Riesling 6 tablespoons of Leaning Post Riesling (this wine pairing) 32 Manila or littleneck clams, scrubbed Nadia and Ilya have had to 3/4 pound linguine rely on the support of family Freshly ground black pepper and friends to make a dream 2 tablespoons each of thinly sliced mint and basil of owning their own winery on their home property in Winona, Ontario a reality. A In a deep skillet, heat the oil. Add the capocollo, garlic and leaning post is what you find crushed red pepper and cook over moderately low heat until the at the beginning of a row of garlic is golden, 1 1/2 minutes. Add the wine and bring to a boil grapes, anchoring the over moderately high heat. Add the clams, cover and cook for 5 framework for growing to 8 minutes; as the clams open, transfer them to a covered bowl. grapevines. Fresh and lively, this Riesling is the perfect In a pot of boiling salted water, cook the pasta until almost al example of what to expect dente. Drain, reserving 3/4 cup of the cooking water. -

Cut Dried Why It’S Irresistible, Again and Again
IN ITS MANY VARIETIES, DRIED PASTA HAS BEEN A STAPLE FOR GENERATIONS OF ITALIANS. DISCOVER CUT DRIED WHY IT’S IRRESISTIBLE, AGAIN AND AGAIN. 4 3 5 2 1 6 8 12 7 11 10 13 9 LONG PASTA 1 TAGLIOLINI 2 FETTUCCINE 3 LINGUINE 4 SPAGHETTI ALLA CHITARRA 5 TRENETTE 6 PICI 7 TAGLIATELLE 8 PAPPARDELLE 9 ZITI LUNGHI 14 10 PERCIATELLI 11 SPAGHETTI 12 CAPELLI D’ANGELO 13 LASAGNE RICCE 14 MAFALDINE PHOTOGRAPHS BY CHRISTOPHER BAKER TEXT BY LESLEY PORCELLI SHORT PASTA 15 GNOCCHETTI 15 16 TROFIE 17 CAVATELLI 18 CROXETTE 19 STROZZAPRETI 16 20 CHIOCCIOLE 21 PIPETTE 22 PENNE 23 PENNONI 24 TRENNE 18 25 RIGATONI 17 26 ZITI CORTI 27 ROMBI 28 GARGANELLI 29 CONCHIGLIONI 19 30 RADIATORE 23 31 FARFALLE 22 32 CAMPANELLE 33 LANTERNE 34 FUSILLI 35 ORECCHIETTE 36 CONCHIGLIETTE 37 TUBETTI 24 20 38 SEMI D’ORZO 21 39 STELLINE 27 25 26 28 29 37 30 31 32 34 36 33 38 35 39 83 case of PERCIATELLI, which translates roughly as “little holed things”), and long ZITI. Many long shapes, such as TAGLI- Most commercial dried pasta ATELLE, thin PICI, and is made from durum wheat, broad PAPPARDELLE, a hard flour that gives pasta are available in “nidi”: dried, a golden color. A few contain portion-size nest shapes. eggs and white flour in place Some pastas are “ricce,” or of durum wheat; these mimic curly, including MAFAL- the delicate texture and DINE (which was named flavor of homemade noodles, for Mafalda, a Savoy prin- and should be treated as cess) and LASAGNE. -

Schedario Napoletano 1
GIUSEPPE GIACCO S C H E D A R I O NAPOLETANO 2003 Proprietà letteraria dell’Autore Data ultima modifica: 16/10/06 Giuseppe Giacco, Schedario napoletano 1 IL NAPOLETANO CHE SOPRAVVIVE con REPERTORIO ITALIANO - NAPOLETANO e SCHEDARIO NAPOLETANO Anche il napoletano, come del resto quasi tutti i dialetti e le parlate locali, tende ormai da tempo ad uniformarsi alla lingua nazionale. Tale fenomeno, suscitato ed alimentato dalla scuola e dai mezzi di comunicazione, ha coinvolto masse sempre più ampie. Si è quindi imposto un napoletano "nobile", di cui neanche i più accesi tradizionalisti possono negare l'esistenza. Oggi si può dire che nel dialetto napoletano esistono tre tipi di vocaboli: i termini assimilati all'italiano ( o italianizzati) , perché già precedentemente abbastanza simili alla lingua nazionale, per la comune matrice quasi sempre latina; i termini disusati ( o desueti), o perché molto dissimili dall'italiano e quindi incomprensibili alle masse, o perché francamente brutti (e sono avvertiti come tali i termini settoriali o gergali, i quali sono usati ancora nella loro forma più antica, oppure sono stati interamente sostituiti dai corrispondenti termini italiani, quando esistevano, senza passare per stadi intermedi); i termini che sopravvivono , sia pure in una veste alquanto italianizzata, perché talvolta più belli e significativi di quelli della lingua nazionale. Lo stesso discorso può essere integralmente ripetuto per gli aspetti morfologici e sintattici del dialetto napoletano. Nella pratica quotidiana, queste diverse esistenze