(2016) 11–32 Initial. a Review of Medieval Studies 4 (2016) 11–32
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Web-Brochure
Luoghi Places SIRACUSA da scoprire RAGUSA Luoghi Places Sommario Introduzione Pag. 2 Luoghi di interesse Museo Archeologico Regionale di Kamarina Pag. 3 Castello di Donnafugata Pag. 4 Grotta delle Trabacche Pag. 5 Area archeologica Caucana Pag. 6 Riserva naturale di Randello Pag. 7 Scoglitti Pag. 8 Chiaramonte Gulfi Pag. 9 Luoghi del Barocco Siciliano Ragusa Ibla Pag. 10 Comiso Pag. 11 Modica Pag. 12 Scicli Pag. 13 Noto Pag. 14 Siracusa Pag. 15 Sicilia da Scoprire Bottega del Carretto Siciliano Pag. 16 Museo dell'olio di Chiaramonte Gulfi Pag. 17 Arte del Ricamo e dello Sfilato Siciliano Pag. 18 Casa delle Farfalle - Modica Pag. 19 Casa Museo Liberty - Chiaramonte Gulfi Pag. 20 Luoghi Places Introduzione SIRACUSA RAGUSA Provincia di Ragusa Comiso Vittoria RAGUSA Ibla Scoglitti Modica Punta Secca Scicli Ispica Marina di Ragusa Donnalucata Sampieri La Sicilia e il ragusano. Terre indimenticabili. La Sicilia è patria di miti, leggende e tradizioni che aondano le loro radici nell’antichità. Normanni, Greci, Romani, Arabi e Spagnoli hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dell’isola. Il Barocco siciliano è nato e ha trovato la sua massima espressione nella provincia di Ragusa e nella Val di Noto, elette per questo Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Cinema e televisione hanno sfruttato le particolarità architettoniche di città come Modica, Scicli e Ispica, assicurando loro una fama internazionale. In più le spiagge incantevoli di Marina di Ragusa, Scoglitti, Sampieri e le riserve protette rendono quest’area una meta di forte interesse paesaggistico. Il ragusano è un territorio spettacolare, che si scopre passeggiando tra gli ulivi circoscritti da muretti in pietra e abbandonandosi alla vista dell’orizzonte ondulato dei pascoli. -

Pasqua in Sicilia Antichi Riti E Processioni “Al Tramonto Del Sole Guardate Nella Rada, Un Piroscafo Appena Arrivato Porterà I Vostri Pensieri Verso L’Africa”
Pasqua in Sicilia antichi riti e processioni “Al tramonto del sole guardate nella rada, un piroscafo appena arrivato porterà i vostri pensieri verso l’Africa”. Dal 17 al 22 aprile 2019 1 giorno, mercoledi 17 aprile : Venezia – Catania – Siracusa (km 67) Noto (km 30) Ritrovo dei Sigg. partecipanti in luogo e orario convenuto. Trasferimento all’aerporto di Venezia e partenza con volo delle ore 10.20 diretto a Catania. Arrivo ore 12:00, Incontro con la guida locale e pranzo. Trasferimento a Siracusa, la città più importante della Magna Grecia che per circa due secoli è stata la città più potente al mondo conosciuto; la città antica di Ortigia ed il suo grande Parco Archeologico sono tappe essenziali di qualsiasi viaggio in Sicilia. Visita guidata al Parco Archeologico di Siracusa: Passeggiata all'isola di Ortigia, il cuore pulsante di Siracusa per circa 2700 anni. Lungo il nostro percorso vedremo i resti del tempio di Apollo (565 a.C. Circa e il Duomo di Siracusa. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento. 2 giorno, giovedì 18 aprile : Lo svelamento del Cristo alla Colonna a Ispica e visita al Parco Forza Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorate. In mattinata raggiungeremo Ispica, in provincia di Ragusa, per assistere al rito dello svelamento del Cristo alla colonna chiamato anche 'U Patri a Culonna' (letteralmente 'Padre alla Colonna'), il Cristo dei “cavari”, gli abitanti del fondo valle, dove sorgeva il vecchio insediamento della città, prima del disastroso terremoto dell’11 gennaio 1693. È il Cristo del ceto medio, degli artigiani, del popolo appartenente alla chiesa di Santa Maria della Cava. -

Archaeology & History Tours 2021
Archaeology & History Tours 2021 Fascinating journeys into history, prehistory and the ancient world Welcome... The year 2020 put everyone’s travel plans on hold, so I open this welcome message Wonderful Holidays, with a most heartfelt “thank you” to all of our customers for the loyalty and trust you have given us, from rescheduling your booking to simply sending kind and thoughtful Historic Wonders messages. And a huge thank you also to our brilliant expert tour directors, whose online ‘Armchair Archaeology Tours’ have kept us all engaged in the fascinating world of archaeological Created and led by archaeologists, travel without any of us leaving home. historians and expert guides History is hidden everywhere, underlying the character and identity of places and peoples, and forming the story of humankind, with a universal relevance for us all. This is why archaeological travel is so fascinating and why, at Hidden History, we remain dedicated to providing superb tours exploring the world’s ancient and historic sites. Throughout history, the nature of travel has continually changed, and now more acutely than ever we must all adapt to an evolving future of responsible, safe, worthwhile travel. The past is a foreign country: At Hidden History we are constantly creating new tours and new ways of enjoying them, whilst ensuring we maintain the excellent quality, value for money and personal service they do things differently there we have become known for. The immortal first line to L. P. Hartley’s ‘The Go-Between’ (1953) I hope you will enjoy looking through our 2021 brochure, whether you are itching to get wistfully condenses the nature of history, travel and the away soon or just thinking about the future. -

Eloro:La Villa Romana Del Tellaro
La villa romana del Tellaro presso Eloro: una residenza sontuosa di IV secolo d. C. in Sicilia Sud - Orientale. Lo scavo della Villa romana del Tellaro, situato a circa due chilometri e mezzo dal ben più noto sito di Eloro, su una lieve eminenza alla destra del fiume Tellaro, nei pressi della foce, costituisce, oltre che per la bellezza dei suoi mosaici, una testimonianza importante circa la frequentazione rurale nel territorio della provincia di Siracusa durante l’età tardo- antica e in particolare sulla presenza, in Sicilia Sud – Orientale, di un’aristocrazia terriera che in età tardo- imperiale costruiva ville sontuose come quella di Piazza Armerina. Lo scavo della suddetta villa comincia agli inizi degli ’70, quando la Soprintendenza di Siracusa insieme alla Guardia di Finanza scopriva e bloccava degli scavi clandestini in una fattoria agricola abbandonata in Contrada Vaddeddi o Caddeddi, portando alla luce dei tratti di mosaici pavimentali in ottimo stato di conservazione e di una viva e cangiante policromia. Questi mosaici erano relativi al pavimento di un portico di m 10, decorato con medaglioni e motivi geometrici intorno ai quali si snodano, in eleganti composizioni, ricche corone di foglie di alloro. Gli altri mosaici riguardano brevi tratti dei pavimenti di tre stanze che danno a Nord del portico di cui si è detto prima. Partendo da Est si osserva prima il pavimento dell’angolo di una stanza con una fastosa decorazione perimetrale e girali animati, in un caso, forse da un cervo e nell’altro dall’aggressivo corpo di una tigre. Questa fascia inquadra un emblema di cui è visibile una piccola zona raffigurante la parte inferiore di figure di armati. -

Los Mosaicos Del Balneum* Tessellated Paveme
ROMVLA 12-13, 2013-2014, págs. 349-378 Revista del Seminario de Arqueología de la ISSN: 1695-4076 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Pavimentos musivos DEL yacimiento ROMANO DE FUENTE ÁLAMO (PUENTE GENIL, CÓRDOBA): LOS mosaicos DEL BALNEUM* TESSELLATED PAVEMENT AT THE ROMAN SITE OF FUENTE ÁLAMO (PUENTE GENIL, CÓRDOBA): THE MOSAICS BALNEUM Sebastián Vargas Vázquez Doctor en Arqueología Resumen Con este trabajo iniciamos el estudio del rico patrimonio musivo del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, amplio catálogo que por su extensión requiere que en este primer acercamiento ofrezcamos sólo algunas consideraciones generales sobre todo el conjunto y que nos centremos, con mayor detenimiento, en los mosaicos de las estancias I y II del balneum. Palabras claves: Mosaico, tesela, diseño geométrico, composición geométrica, esvástica, perspectiva, balneum. Riassunto Con questo lavoro iniziamo lo studio del ricco patrimonio musivo del sito archeologico di Fuente Álamo, un ampio catalogo che per la sua estensione richiede che in questo primo * Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación HUM2007-61878 y HAR2010- 18594 y forma parte de la Tesis Doctoral: Vargas Vázquez, S. (2013): Diseños geométricos de los mosaicos del Conventus Astigitanus, dirigida por la Dra. López Monteagudo y por la Profra. León-Castro Alonso, continuación de un estudio previo que ha tenido por objeto el estudio de los mosaicos de la Capital de dicho Conventus: Vargas Vázquez, S. (2008): Diseños geométricos compositivos en los mosaicos de Écija (Sevilla), Memoria de Licenciatura realizada bajo la dirección de la Dra. Guadalupe López Monteagudo, leída en la Universidad Complutense de Madrid en 2008, y que formará parte del Corpus de Mosaicos Romanos de España. -
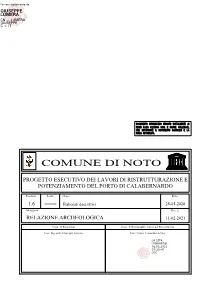
Comune Di Noto
COMUNE DI NOTO PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CALABERNARDO Tavola n. Scala: Classe Data: 1.6 ===== Elaborati descrittivi 28-05-2020 Ad oggetto: Rev. 2: RELAZIONE ARCHEOLOGICA 11-02-2021 Visto : Il Progettista Visto : Il Responsabile Unico del Procesimento F.to : Ing. arch. Giuseppe Lumera F.to : Geom. Leonardo La Sita COMUNE DI NOTO LAVORI DI RISTRUTTURAIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CALABERNARDO - PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE Data: Dott.ssa Serena Paola Paolucci Via G. B. Basile 5, Avola (Sr) Tel. 334 3636796 Maggio 2020 [email protected] Dott.ssa Marta Fitula C.da Gioi, Noto (Sr) Tel. 3348743228 [email protected] Progettista : VISTI DI APPROVAZIONE Ing. Arch. Giuseppe Lumera INDICE Premessa………………………………………………….…..………………………………............2 Descrizione topografica………………….……………..………………………………………….…2 Caratteristiche geomorfologiche …………………………………………..…………........................3 Inquadramento storico………………………………………………………………………………..4 Inquadramento archeologico ……………………………………………………………….…...……5 Conclusioni……………………………………………………………………………………….....11 Bibliografia…………………………………………………………………………………….……12 Documentazione grafica e fotografica…………………………………………...………..…….......17 1 Premessa La presente relazione preliminare riguarda l’area della ristrutturazione e potenziamento del porto in località Calabernardo, Noto, provincia di Siracusa. Il Piano Regolatore del Porto di Calabernardo, in variante al vigente piano regolatore generale è stato approvato per effetto del Decreto 20 dicembre 2006 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell‟Ambiente (G.U.R.S. n.7 del 09/02/2007). La realizzazione del porto suddetto comporta interventi nella zona costiera, sia a mare, che nella terra ferma: - dragaggi dei fondali; - rimozione del sopralzo in cls del molo vecchio; - potenziamento del molo di sottoflutto attuale; - realizzazione e banchinamento del nuovo molo di sopraflutto; - banchinamenti di riva; - modifiche delle zone limitrofe in prossimità dell’ex caserma della Guardia di Finanza. -

TRENI STORICI DEL GUSTO SICILIA 2018 Locomotiva Gr
Con la collaborazione di Regione Siciliana Azione 6.8.03 Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo TRENI STORICI DEL GUSTO SICILIA 2018 Locomotiva Gr. 740.049 in uscita dallo scalo merci del porto di Catania, 1969. Foto Archivio Fondazione FS Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana Come una ragnatela tessuta con dedizione e sacrificio, le linee ferrate isolane sono un fiore all'occhiello della mobilità sostenibile perchè consentono di addentrarsi nei meandri della Sicilia più autentica e di scoprirne le bellezze. E' con questo spirito che la Regione Siciliana offre il suo contributo per un progetto che diventa valore aggiunto di un'offerta turistica globale. Essa non guarda solo all'incoming, ma anche alla fruizione del territorio durante una permanenza finalizzata, tra l'altro, alla destagionalizzazione. Il treno ci riporta a un ritmo di viaggio da assaporare lentamente, un'occasione in più non solo per i turisti, ma anche per i tanti siciliani che, grazie a questa iniziativa, possono riscoprire le peculiarità della nostra terra e apprezzarne da vicino le tante sfaccettature. Viaggiare sulle rotaie diventa dunque il sistema perfetto per vivere appieno l'armonia fra cultura, gusto e paesaggio che solo quest'Isola sa offrire. Nello Musumeci Sandro Pappalardo, Assessore del Turismo,dello Sport e dello Spettacolo E' possibile vivere un'esperienza di viaggio coinvolgente attraverso i territori della Sicilia che sveli attraverso il cibo la storia della sua cultura materiale. Un viaggio che superi i tradizionali clichè e non si limiti alla visita del suo straordinario patrimonio monumentale, storico artistico, naturale. E' la scommessa culturale del progetto i Treni storici del gusto che offre un programma di ventitre itinerari e cinquanta appuntamenti per attraversare e conoscere la Sicilia dalla fine di luglio all'inizio di dicembre, in una visione di turismo relazionale integrato che rimanda ai principi ispiratori delle azioni condotte sui Borghi d’Italia, l’Anno del Cibo Italiano, il Turismo di ritorno. -
Viaggi Gioventu 2004
"" 0 “La mappa del cuore del vascello” “con il passo del poeta” Prefazione sommaria L’infinito viaggiare Il viaggio come un libro le bateau est seulement un: méfiez vous des imitations E’ la nostra azienda storica. Opera nel settore da oltre 60 anni. Riferimento del trasporto turistico a Roma certificazione ISO 9001 e nel mercato nazionale. Certificazione Bureau Veritas ISO 9001-2008 [email protected] ISO 14001-2004 Forever [email protected] Autoritratto in mostra Perchè le Bateau Ivre “Una questione di cuore” Da oltre trentacinque anni Le Bateau Ivre presenta “il viaggio e la bella avventura” ed ha maturato un’esperienza professionale che gli consente di essere “Leader” nei viag- gi di qualità. Ha sempre mantenuto una profonda dimensione culturale nelle proposte, in virtù della duplice e parallela convinzione: che ogni itinerario deve essere adattato alle esigenze di chi lo percorre e che l’arricchimento umano, insito nell’idea del viaggio, non va in alcun modo condizionato da rigidità organizzative. Un nuovo anno, un Libro del Viaggio nuovo …. Restiamo fedeli alla nostra storia, al nostro modo di intendere il viaggio; di anno in anno ci seduce l’ambizione di aiutare chi ha scelto il nostro Battello a scoprire sempre qual- cosa a cui non aveva pensato e nell’edizione 2018 presentiamo alcune sezioni comple- tamente nuove, oppure, profondamente rinnovate. Come ci piace ripetere, i tanti itine- rari proposti sono pur sempre una selezione parziale di quanto la nostra professionalità ci permette di progettare, e, soprattutto, costruire insieme, perché abbiamo nei fatti mostrato a tutti la nostra competenza e il nostro amore per il viaggio. -

Alle Origini Di Eloro. L'espansione Meridionale Di Siracusa Arcaica
ALLE ORIGINI DI ELORO 245 ALLE ORIGINI DI ELORO L’espansione meridionale di Siracusa arcaica Il nome di Eloro, piccola cittadina costiera posta trenta chilometri circa a sud di Siracusa, è scarsamente evocativo per gli storici della Sicilia antica. Esso è per lo più associato non già alla città bensì al fiume omonimo, sulle cui sponde si scontrarono Geloi e Siracusani nel 492 a.C., ovvero alla cosiddetta via Elorina, ricordata da Tucidide in relazione alle manovre dell’esercito ateniese durante la spedizione in Sicilia del 415-413 a.C. Ad incrementare l’oblio caduto sulla città ha contribuito proprio il silenzio di Tucidide, il quale, a proposito dell’espansio- ne coloniale di Siracusa, cita solamente le fondazioni di Acre, Casmene e Cama- rina (Thuc. VI 5). Eloro, rimasta nell’oscurità per secoli, ha cominciato a destare l’interesse degli studiosi soprattutto nella seconda metà del Novecento, in segui- to alla pubblicazione postuma degli scavi compiuti sul luogo da Paolo Orsi. Og- gi, a fronte di una proposta di datazione molto alta per la fondazione della città, risalente addirittura alla fine dell’VIII secolo a.C., ci pare opportuno un attento riesame delle fonti in nostro possesso, al fine di portare maggior luce sulla storia di una piccola polis ancora poco conosciuta. Ad orientare le nostre ricerche de- vono essere in via preliminare le fonti letterarie che, seppure scarne e frammen- tarie, hanno conservato memoria dell’antica cittadina ed hanno contribuito ad una sua precoce identificazione. La prima testimonianza si trova in Pindaro (Nem. IX 39-42), laddove il poeta canta le gesta di Cromio, eminente coman- dante al servizio di Gelone, il quale «sulle sponde dalle rocce dirupate dell’Elo- ro» combatté valorosamente contro i Siracusani. -

L. ARCIFA, Per Una Geografia Amministrativa Dell'altomedioevo In
PER UNA GEOGRAFIA AMMINISTRATIVA tenacemente disgregato le testimonianze archeologiche an- DELL’ALTOMEDIOEVO IN SICILIA cora cospicue cento anni fa, annullando ulteriormente la NUOVE IPOTESI DI RICERCA PER UN SITO possibilità di rilettura di quell’insediamento. Una occasio- ne insperata ci viene, invece, dalla documentazione archi- “BIZANTINO”: CITTADELLA DI VINDICARI (SR) vistica che consente di cogliere un ruolo non altrimenti ipo- di tizzabile e di ampliare i termini cronologici di questo abita- to, aprendo nel contempo prospettive nuove per una messa LUCIA A RCIFA a fuoco della geografia amministrativa di quest’area nel- l’altomedioevo. L’area archeologica di Cittadella è oggi compresa al- Il dibattito sulle trasformazioni delle strutture sociali, l’interno della più famosa oasi naturalistica di Vindicari; economiche e insediative nella Sicilia altomedievale, attra- essa occupa uno stretto e basso promontorio che si proten- verso la tarda età bizantina, l’invasione islamica, fino al- de da nord a sud circondato a est, nord e ovest da aree lacu- l’arrivo dei Normanni, si impernia sui numerosi contributi stri e paludose. Uno stretto canale, oggi parzialmente in- di carattere storico elaborati da H. Bresc nell’arco dell’ulti- sabbiato, collegava in antico al mare quest’area paludosa mo ventennio (AYMARD-BRESC 1973; BRESC 1976; BRESC che costituiva così una insenatura portuale naturale e ben 1980; BRESC 1983; BRESC 1984; BRESC 1995). Solo di re- riparata (Fig. 2). Tali caratteristiche geomorfologiche ripro- cente i modelli teorici fin qui proposti hanno trovato possi- pongono, peraltro, la conformazione tipica di questo tratto bilità di confronto nelle ricerche di archeologia medievale di costa a sud di Eloro, dove si susseguono numerosi panta- che con maggiore vigore e sulla base, appunto, di un tale ni lungo la costa o appena separati da essa da strette dune quadro interpretativo hanno ripreso il tema delle modifica- sabbiose (LENA-BASILE-DI STEFANO 1988). -

Val Di Noto: Il Barocco Ibleo
Rotary Club Milano San Babila Rotary International - Distretto 2041 - Gruppo 10 Service Above Self - He Profits Most Who Serves Best Viaggio di Club Val di Noto: il Barocco Ibleo 27 Aprile – 1° Maggio 2018 Rotary Club Milano San Babila Via della Moscova, 10 c/o Studio Terruzzi - 20121 Milano Cell. 334.93.78.99.2 [email protected] - www.rotarymilanosanbabila.it ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30 RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Hotel NH President - Largo Augusto 10 - Milano 27 APRILE La consolidata tradizione del “San Babila” di compiere un viaggio annuale, quest’anno ci ha visti in Sicilia, a visitare le importanti vestigia del Barocco Ibleo. Partiamo il 27.04, ad ora quasi… antelucana: siamo in 36, Soci ed amici, guidati dal Presidente Luigi Cella e dagli organizzatori del viaggio, Riccardo Costa e Maria Rita Surano. Dopo un ottimo volo, eccoci a Catania, sotto un cielo abbastanza gonfio di nuvole. Una rapida corsa in pullman ci porta a Ragusa: durante il viaggio, passano davanti ai nostri occhi i bei paesaggi siciliani, in un alternarsi di distese verdissime e di zona brulle e riarse, pianure e rilievi, centri abitati alternati a vaste zone senza tracce umane. Tutto questo paesaggio suscita certo, in molti di noi, il ricordo delle “gesta” dell’indomito commissario Montalbano. Nel pomeriggio, all’hotel che ci ospita (moderno e confortevole), incontriamo alcuni Soci del Rotary Club di Ragusa con il presidente Giuseppe Polara e il segretario Giuseppe Antoci, che con grande cortesia vengono ad accoglierci. Il prefetto del Club, Saro Di Stefano, ci fa addirittura da guida, con molta simpatia e profonda competenza, nella sua splendida città. -

Convegno AIIG Programma Preliminare
56° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 17° Corso Nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica 8° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Giovani La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo. Aggiornamenti scientifici e didattici Siracusa – Noto 24-30 ottobre 2013 Programma preliminare giovedì 24 ottobre 2013 Siracusa – (Sede: Sala Congressi Grand Hotel Villa Politi) ore 9.00 Accoglienza e inizio registrazione dei partecipanti ore 10.00 Escursione pre-convegno: Museo Archeologico “Paolo Orsi” e Parco Archeologico ore 14.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti ore 15.00 Cerimonia di apertura e saluto delle Autorità ore 15.30 Consegna del premio “G. Valussi” ore 16.00 Relazioni sul tema La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo. Presiede Prof. Gino De Vecchis. Interventi: Proff.ri Giuseppe Campione, Tullio D’Aponte, Franco Farinelli, José Gambino ore 18:30 Consulta dei Presidenti regionali ore 21.00 Cena sociale venerdì 25 ottobre 2013 Noto – (Sede: Palazzo Giavanti, Dipartimento di “Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali” – Università degli Studi di Messina) ore 8.30 Partenza per Noto ore 9.00 Visita guidata alla Villa Romana del Tellaro, conosciuta per i preziosi mosaici, e al centro storico di Noto, capitale del Barocco Siciliano e patrimonio UNESCO ore 12.30 Inaugurazione Convegno Giovani ore 13.30 Colazione di lavoro ore 15.00 Saluto delle Autorità ore 15.30 Tavola rotonda Crisi economica e prospettive di lavoro: il ruolo della geografia. Coordina Prof. Carlo Brusa. Interventi: Proff.ri Caterina Cirelli, Sergio Conti, Giuseppe Dematteis, Maria Prezioso, Lidia Scarpelli, Gaetano Sciuto ore 18.00 Coffee break ore 18.30 Tavola rotonda La valorizzazione dei beni culturali, un’opportunità di sviluppo per la Sicilia.