Tra Commercio E Arte. La Vita Divisa Di Marco Boschini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
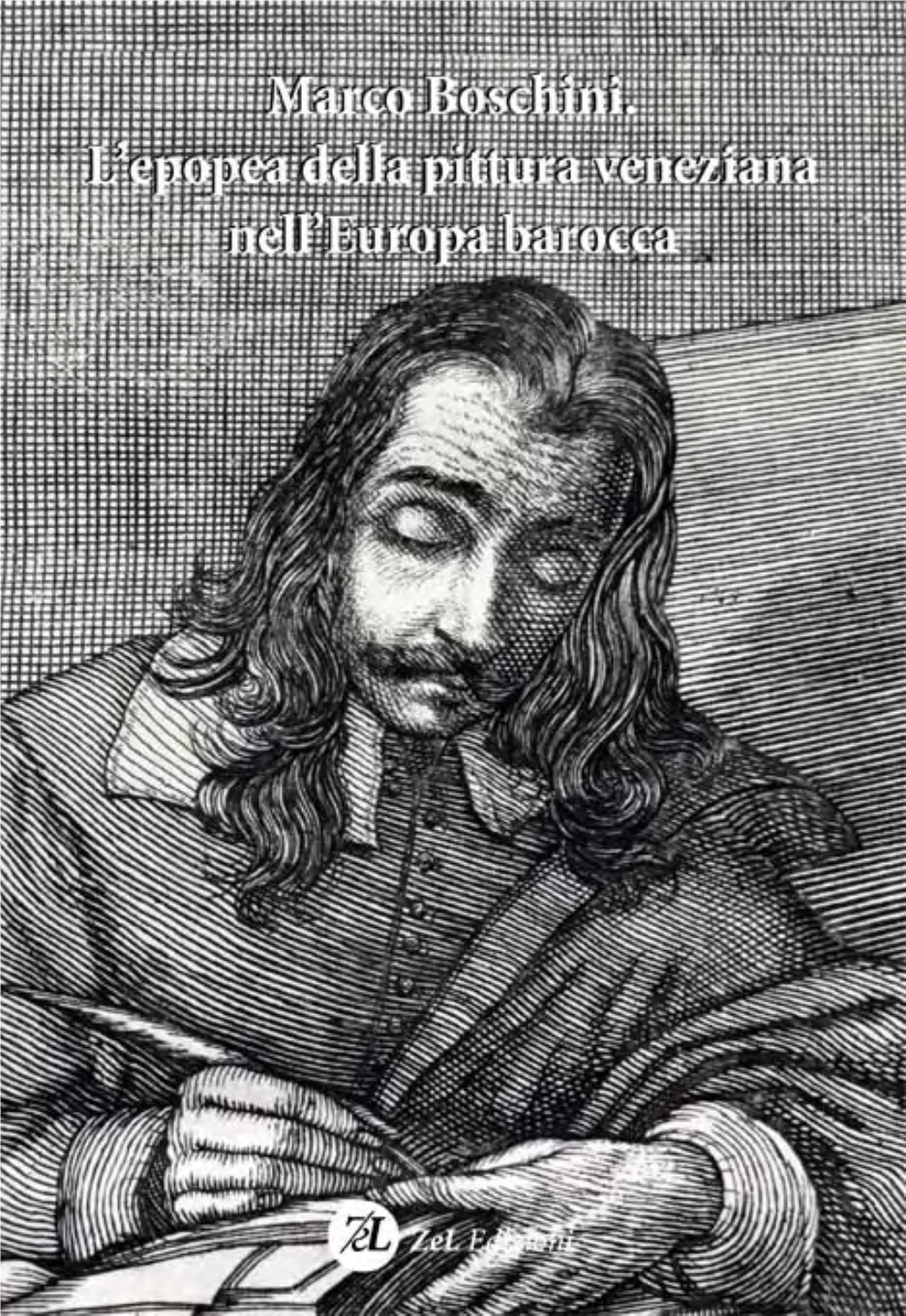
Load more
Recommended publications
-

A Second Miracle at Cana: Recent Musical Discoveries in Veronese's Wedding Feast
BASSANO 11 A SECOND MIRACLE AT CANA: RECENT MUSICAL DISCOVERIES IN VERONESE'S WEDDING FEAST Peter Bossano 1.And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there: 2. And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. 3. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. 4. Jesus saith unto her, Woman what have I to do with thee? mine hour is not yet come. 5. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. 6. And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece. 7. Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim. 8. And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. 9. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom, 10.And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worst; but thou hast kept the good wine until now. —John 2: 1-10 (KingJames Version) In Paolo Veronese's painting of the Wedding Feast at Cana, as in St. John's version of this story, not everything is as at seems. -

Annotazioni E Aggiunte Al Catalogo Di Pietro Negri, Pittore « Del Chiaro Giorno Alquanto Nemico » Seconda Parte
Annotazioni e aggiunte al catalogo di Pietro Negri, pittore « del chiaro giorno alquanto nemico » seconda parte Giorgio Fossaluzza Riguardo alla prima metà degli anni sessanta offrono un completamento d’in- dicazioni sulla posizione stilistica di Pietro Negri e il contesto della sua opera- tività veneziana i disegni raccolti nel cosiddetto Album di Camerino, che è stato conservato presso l’Archivio parrocchiale di Santa Maria in Via e ora fa parte delle raccolte del Museo Arcidiocesano Giacomo Boccanera della città marchi- giana.1 Sono annoverati ben quattro importanti fogli che la scritta antica assegna La prima parte di questo contributo è stata pubblicata in « Verona Illustrata », 23, 2010, pp. 71-90. Un devoto e sincero ringraziamento a mons. Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo di Camerino - San Severino Marche, per la generosa e collaborativa sollecitazione allo studio e valorizzazione dell’Album di Camerino. Questo contributo può vedere la luce anche grazie alla collaborazione del prof. Pier Luigi Fala- schi, direttore del Museo Arcidiocesano di Camerino. Mi è gradito dedicarglielo, quale cordiale omaggio e segno di amicizia. 1. La menzione e illustrazione dei disegni di Negri appartenenti a tale raccolta si trova in P. Zampetti, Note sparse sul ’600, Venezia 1967, p. 28 nota 23; Idem, Un quaderno di disegni a Camerino, « Notizie da Palazzo Albani », iii, 2/3, 1974, pp. 48-50; E.A. Safarik, Per la pittura veneta del Seicento: Francesco Ru- schi, « Römische Jahrbuch für Kunstgeschichte », 16, 1976, p. 338, nota 112; Idem, Pietro Negri, « Saggi e Memorie di Storia dell’Arte », 11, 1978, p. 83, note 2-3, fig. 1; P. -

Boschini E Il Restauro, Fra Tutela E Mercato
Fig. 91. Giorgione, Pala di Castelfranco, radiografia. 306 Boschini e il restauro, fra tutela e mercato Monica Molteni Un bel zardin no’ valerave niente, Se no ghe fusse un zardinier perfeto, Che dale ortiche el mantegnisse neto: El saria un bosco in breve certamente. Che cosa valerave un Arsenal Pien de armadure de molto valor, Se qualcun no netasse con amor El ruzene nemigo a quel metal? Ma meglio: che remedio, e che partio Sarave per drezzar chi havesse smosso De liogo, o roto per desgracia, un osso, Senza el Barbier de San Bartolamio?1 Ai fini della messa a fuoco del punto di vista di Boschini sul tema del restauro il passo della Carta (1660) citato è indubbiamente altamente esemplare, poiché l’elenco di beni – compreso lo stesso corpo umano – la cui buona conservazione dipende dalla costante erogazione di cure amorevoli e professionali qui sciorinato è sostanzialmente finalizzato a rafforzare il concetto espresso nella quartina precedente, e cioè che in una città come Venezia, «dove gh’è milioni de Piture», se non vi fossero «degne cure. / La sarave una pena manifesta»2. Nella lapidarietà di siffatta affermazione traspare in filigra- na uno dei motivi fondamentali sottesi all’intero poema, ovvero l’orgogliosa coscien- za dell’esistenza di un capitale artistico rappresentato dalla grande pittura del passato, particolarmente cinquecentesca, che è al contempo ricchissimo e fragilissimo, e ha un valore inestimabile in quanto elemento fondante dell’identità culturale veneziana: la cui tutela è dunque un atto materiale dovuto, necessitato dal senso di responsabilità morale che il possesso consapevole di un bene di pregio incorpora. -

Collaboration and Originality in Early Modern Art
Lindenwood University Digital Commons@Lindenwood University Faculty Research Papers Research, Scholarship, and Resources 8-2020 L’abbiam Fatta Tutti Noi: Collaboration and Originality in Early Modern Art James Hutson Lindenwood University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers Part of the Art and Design Commons Recommended Citation Hutson, James, "L’abbiam Fatta Tutti Noi: Collaboration and Originality in Early Modern Art" (2020). Faculty Research Papers. 4. https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers/4 This Article is brought to you for free and open access by the Research, Scholarship, and Resources at Digital Commons@Lindenwood University. It has been accepted for inclusion in Faculty Research Papers by an authorized administrator of Digital Commons@Lindenwood University. For more information, please contact [email protected]. Art and Design Review, 2020, 8, *-* https://www.scirp.org/journal/adr ISSN Online: 2332-2004 ISSN Print: 2332-1997 L’abbiam Fatta Tutti Noi: Collaboration and Originality in Early Modern Art James Hutson Art History Department, Lindenwood University, St. Charles, MO, USA Email: [email protected] How to cite this paper: Author 1, Author Abstract 2, & Author 3 (2020). Paper Title. Art and Design Review, 8, **-**. This article seeks a reevaluation of the collaborative efforts and critical valua- https://doi.org/10.4236/***.2020.***** tion of the Carracci in the frescoes of the Palazzo Magnani. While the signi- ficance of the cycle for the development of the nascent baroque style is de- Received: **** **, *** Accepted: **** **, *** monstrable, criticism has focused on attributional issues and the works re- Published: **** **, *** main understudied. Since their original biographers struggled over identify- ing which Carracci was responsible for which scene in the frieze, efforts have Copyright © 2020 by author(s) and been made to carefully dissect the contributions of each. -

The Evolution of Landscape in Venetian Painting, 1475-1525
THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 by James Reynolds Jewitt BA in Art History, Hartwick College, 2006 BA in English, Hartwick College, 2006 MA, University of Pittsburgh, 2009 Submitted to the Graduate Faculty of The Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2014 UNIVERSITY OF PITTSBURGH KENNETH P. DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by James Reynolds Jewitt It was defended on April 7, 2014 and approved by C. Drew Armstrong, Associate Professor, History of Art and Architecture Kirk Savage, Professor, History of Art and Architecture Jennifer Waldron, Associate Professor, Department of English Dissertation Advisor: Ann Sutherland Harris, Professor Emerita, History of Art and Architecture ii Copyright © by James Reynolds Jewitt 2014 iii THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 James R. Jewitt, PhD University of Pittsburgh, 2014 Landscape painting assumed a new prominence in Venetian painting between the late fifteenth to early sixteenth century: this study aims to understand why and how this happened. It begins by redefining the conception of landscape in Renaissance Italy and then examines several ambitious easel paintings produced by major Venetian painters, beginning with Giovanni Bellini’s (c.1431- 36-1516) St. Francis in the Desert (c.1475), that give landscape a far more significant role than previously seen in comparable commissions by their peers, or even in their own work. After an introductory chapter reconsidering all previous hypotheses regarding Venetian painters’ reputations as accomplished landscape painters, it is divided into four chronologically arranged case study chapters. -
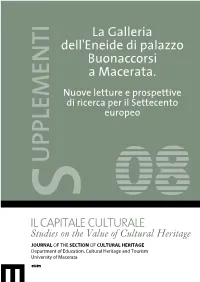
COPERTINA SUPPLEMENTI 08.Ai
I Nuove letture e prospettive di ricerca per il Settecento europeo LEMENT PP U 08 S IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage JOURNAL OF THE SECTION OF CULTURAL HERITAGE Department of Education, Cultural Heritage and Tourism University of Macerata eum IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage Supplementi 08 / 2018 eum Il Capitale culturale Donato, Rolando Dondarini, Andrea Emiliani, Studies on the Value of Cultural Heritage Gaetano Maria Golinelli, Xavier Greffe, Alberto Supplementi 08, 2018 Grohmann, Susan Hazan, Joel Heuillon, Emanuele Invernizzi, Lutz Klinkhammer, ISSN 2039-2362 (online) Federico Marazzi, Fabio Mariano, Aldo M. ISBN 978-88-6056-586-0 Morace, Raffaella Morselli, Olena Motuzenko, Giuliano Pinto, Marco Pizzo, Edouard Direttore / Editor Pommier, Carlo Pongetti, Adriano Prosperi, Massimo Montella Angelo R. Pupino, Bernardino Quattrociocchi, Margherita Rasulo, Mauro Co-Direttori / Co-Editors Renna, Orietta Rossi Pinelli, Roberto Tommy D. Andersson, Elio Borgonovi, Sani, Girolamo Sciullo, Mislav Simunic, Rosanna Cioffi, Stefano Della Torre, Michela Simonetta Stopponi, Michele Tamma, Frank di Macco, Daniele Manacorda, Serge Noiret, Vermeulen, Stefano Vitali Tonino Pencarelli, Angelo R. Pupino, Girolamo Sciullo Web http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult Coordinatore editoriale / Editorial Coordinator e-mail Francesca Coltrinari [email protected] Coordinatore tecnico / Managing Coordinator Editore / Publisher Pierluigi Feliciati eum edizioni università di macerata, Centro direzionale, -

Paolo Veroneses Art of Business
Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social Nexus Author(s): John Garton Reviewed work(s): Source: Renaissance Quarterly, Vol. 65, No. 3 (Fall 2012), pp. 753-808 Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of America Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/668301 . Accessed: 02/10/2012 14:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press and Renaissance Society of America are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Renaissance Quarterly. http://www.jstor.org Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social Nexus* by J OHN G ARTON Despite the prominent career of Paolo (Caliari) Veronese (1528 –88), much remains to be discovered about his patrons and peers. Several letters written by the artist are presented here for the first time, and their recipient is identified as the humanist Marcantonio Gandino. The letters reference artworks, visitors to Veronese’s studio, and economic data pertaining to the painter. Analyzing the correspondence from a variety of methodological viewpoints reveals how Veronese fulfilled commissions, interacted with nobility, and invested his painterly profits in land on the Venetian terraferma. -

Architetture Dipinte Nella Venezia Secentesca
Corso di Laurea magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici Tesi di Laurea Architetture dipinte nella Venezia secentesca Relatore Ch. Prof. Martina FRANK Laureando Anna Corato Matricola 811610 Anno Accademico 2012/ 2013 ! " # ! $ %% & & '(() # *+ ) , -& . /01"$23"/4 5 6)7 8(+ ,, 9(( 5 , ( )( 5 8 9 ) 5 ( ( ( + ) , ( : 5 ( 5 5 ( ( , (( 5 6 5 ( 7 $ 5 ( 5 5 6 ( ) 6 ;6 ( 89 , 8 ) ( 9( ,, 7 5 ) (* )* < 6 ;6 5 5 )) )9 8 5 9 ( 9(+ ! 5 ( 6 ( , 5 ) 5 9 ( 6 5 ( ) ) )5 8 )) + (+ " ++ ) ( 9 ) 7 ) = > ( , 8( ( )7 + ( ( ) , < $8'1' 1 , !'2?/ ', % 7< , ( ) : * )) : 8 8 : ' 5 6 5 ) 8 + (( 6 5 ( ; ( ) 5 ( , ++8,, ( 5 (* ) < ++( ()7( 75 ! 6 7 ) ) ,, : ) ( ( ( 7 ( )" ( ) ( ,, , (( , 5 (+ ) ) ( * ! $ 6 @ , ( 9(( ) 8 ++ ) ) (( ) ( (5 ) 8 ( 5 2 ( 6 ) A ( 7 ++, 5 -

Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy
Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy by Colin Alexander Murray A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto © Copyright by Colin Murray 2016 Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy Colin Alexander Murray Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto 2016 Abstract The intention of this dissertation is to open up collaborative pictures to meaningful analysis by accessing the perspectives of early modern viewers. The Italian primary sources from the fifteenth to the seventeenth centuries yield a surprising amount of material indicating both common and changing habits of thought when viewers looked at multiple authorial hands working on an artistic project. It will be argued in the course of this dissertation that critics of the seventeenth century were particularly attentive to the practical conditions of collaboration as the embodiment of theory. At the heart of this broad discourse was a trope extolling painters for working with what appeared to be one hand, a figurative and adaptable expression combining the notion of the united corpo and the manifold meanings of the artist’s mano. Hardly insistent on uniformity or anonymity, writers generally believed that collaboration actualized the ideals of a range of social, cultural, theoretical, and cosmological models in which variously formed types of unity were thought to be fostered by the mutual support of the artists’ minds or souls. Further theories arose in response to Giovanni Paolo Lomazzo’s hypothesis in 1590 that the greatest painting would combine the most highly regarded old masters, each contributing their particular talents towards the whole. -

Inhaltsübersicht
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2009 Marco Boschini, ”Breve instruzione”. Eine stilkritsche Einführung in ”Le ricche minere della pittura veneziana”, Venedig 1674. Italienisch-Deutsche Edition, 2 Bde., Diss. Universität Bern, 1994, Bern: Selbstverlag, 2009 Wasmer, Marc-Joachim Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-115604 Dissertation Originally published at: Wasmer, Marc-Joachim. Marco Boschini, ”Breve instruzione”. Eine stilkritsche Einführung in ”Le ricche minere della pittura veneziana”, Venedig 1674. Italienisch-Deutsche Edition, 2 Bde., Diss. Universität Bern, 1994, Bern: Selbstverlag, 2009. 2009, University of Zurich, Faculty of Arts. Inhaltsübersicht Band 1. Text und Kommentar Vorwort 1. Einleitung 2. Funktionen und Zielpublikum der Breve Instruzione 3. Rezeption 4. Venetia-Pitiura. Zum Frontispiz in Marco Boschinis Le rieche minere della pittura veneziana, Venedig 1674 5. Editorische Notiz 6. Le rieche minere della pittura veneziana - Die reichen Minen der venezianischen Malerei Serenissimo Prencipe - Durchlauchtigster Fürst AI Genio Pittoresco - Dem malerischen Genius Breve Instruzione. Per intender in qualche modo le maniere degli Auttori veneziani - Kurze Unterweisung, um mit den Stilen der venezianischen Künstler in etwa bekannt zu werden 7. Register 8. Kommentar 9. Verzeichnis der Abbildungen im ersten Band Band 2. Katalog und Dokumentation 1. Katalog. Verzeichnis der in der Breve Instruzione genannten Kunstwerke 2. Chronologie Marco Boschini 3. Vokabular 4. Literaturverzeichnis 5. Abkürzungen 6. Ein Musee imaginaire der venezianischen Malerei 7. Verzeichnis der Abbildungen im zweiten Band 8. Abbildungen zur Breve Instruzione Wasmer, Marc-Joachim digitalisiert durch: Marco Boschini - breve instruzione IDS Luzern 2009 Inhalt Band 1. -

Art History 636: Titian Syllabus Fall 2017 Prof
Art History 636: Titian Syllabus Fall 2017 Prof. Benjamin Paul Office: Art History Dept., 60 College Ave, Room 101 A Office Hours: Wednesday, 2:45-3:45 pm and by appointment Tel.: 732-9320122, ext. 21 Email: [email protected] Course description: Titian is the central figure in sixteenth-century Venetian art. In his long career he redefined virtually every aspect of Venetian painting including history painting, portraiture, the altarpiece, and ducal votive paintings. Together with Giorgione, he also invented the pastoral and introduced a new, much more open brushwork. This seminar will consider all these aspects within their historical context, discuss Titian’s style in relation to contemporary art theory, and investigate his self-fashioning as the Republic’s “Prince of Painters.” Requirements will include the weakly preparation of three questions concerning the readings, an oral report on specified readings and the object of the student’s research, as well as a written research paper (12 pages in double space). Textbook (not mandatory): Peter Humfrey, Titian , London, 2007. Sept. 6 Introduction David Rosand, Titian , New York, 1978 (introductory essay) Sept. 13 Venetian tonalism Marcia Hall, Color and Meaning. Practice and Theory in Renaissance Painting , Cambridge, 1992, pp. 199-236; Paul Hills, “Titian’s Colour,” in Tiziano (ex. cat. Prado 2003), ed. by Miguel Falomir, pp. 308-313; Paul Joannides, Titian to 1518. The Assumption of a Genius , New Haven, 2001, pp. 7-17. Sept. 20 The Pastoral David Rosand, “Giorgione, Venice and the Pastoral Vision,” in: Places of Delight: The Pastoral Landscape , New York, 1998, pp. 21-81; Una Roman D’Elia, The Poetics of Titian’s Religious Paintings , ch. -

Giovanni Antonio Canal (1697-1768)
GIOVANNI ANTONIO CANAL (1697-1768). CANALETTO Testo di Bożena Anna Kowalczyk Davanti alle sofisticate immagini di Canaletto il quesito più dibattuto già tra i contemporanei è quello della rispondenza al vero. Il pittore veronese Pietro Guarienti (1700 circa - 1765), il primo biografo dell’artista, così esordisce in una celebre nota, pubblicata a Venezia nel 1753: “Antonio Canale, veneziano, pittore di prospettive riputatissimo. Dopo aver studiato qualche tempo sotto il padre pittore passò a Roma ancor giovinetto, e facendo sua indefessa applicazione il disegnare con esattezza, e con mirabil gusto dipingere le belle antiche fabbriche, in pochi anni gli venne fatto di rappresentarle su tele con tale intendimento e maestria che da pochissimi degli antichi, e da nessun de’ moderni fu eguagliato nell’arte di copiare e contrafare con tanta perfezione la natura ed il vero”1. Anton Maria Zanetti di Alessandro (1706-1778), critico d’arte e custode della Biblioteca Marciana, che, con il più anziano cugino omonimo, è a Venezia tra le conoscenze più strette di Canaletto, ribatte invece con finezza, a pochi anni dalla morte dell’artista, nel 1771: “Unì il Canal ne’ suoi quadri alla natura le pittoresche licenze con tanta economia, che le opere sue vere compariscono a chi non ha che buon senso per giudicarne; e chi molto intende trova di più in esse grand’arte nella scelta de’ siti, nella distribuzione delle figure, nei campi, nel maneggio delle ombre e dei lumi; oltre a una bella nitidezza e saporita facilità di tinta e di pennello, effetti di mente serena e genio felice”2. L’impiego della camera ottica come strumento di riprese dal vero per gli amici di Canaletto era un dato di fatto: “Insegnò il Canal con l’esempio il vero uso della camera ottica”,afferma Zanetti3, e Pierre-Jean Mariette (1694-1774), collezionista e storico d’arte in contatto diretto con l’artista, riporta che “depuis qu’il eut abdiqué le théâtre, il ne s’occupa plus qu’à peindre des vues d’après nature, faisant usage de la chambre noire, dont il scavoit modérer le faux”4.