La Formazione Estetica Di Ida
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Hans Christian Andersen Between a Culture of Meaning and a Culture of Presence
Hans Christian Andersen between a culture of meaning and a culture of presence Mogens Davidsen, Associate Professor, University of Southern Denmark Abstract The article opens with questioning what kind of “community” Hans Christian Andersen as an artist can be said to have been a part of, considering that the community of Andersen’s upbringing was radically different from the one he was socialized into through his literary career. With the point of departure in Hans Ulrich Gumbrecht’s distinction between literature displaying “presence in language” and “presence achieved against language”, the article suggests that part of Andersen’s work (with Søren Kierkegaard’s critique of the novel Only a Fiddler in focus) can be seen as examples of presence achieved against language. With the two presence categories which Gumbrecht typologically distinguishes as a “presence culture” and a “meaning culture” in mind, the presence categories are ascribed to an oral culture of Andersen’s social background, and the elitist intellectual culture of the Danish Golden Age. Inspired by Kierkegaard’s characterization of Andersen’s novel in musical terms, the article further presents a possible understanding of presence, the implications of which reaches far beyond the harmonic paradigm of the Golden Age and into the musical modernism of Arnold Schönberg in the twentieth century. Introduction What kind of community can Hans Christian Andersen rightly be said to have been a part of, if such a community also has to be detectible in his work as formal or thematic aspects of his literature? This is not an altogether easy question to answer, taken into consideration that Andersen came from the very poorest part of society and was socialized into the cultural and artistic norms of the elitist circles of the Danish Golden Age of the late absolute monarchy. -

I Meilensteine in Thorvaldsens Künstlerbiografie
I Meilensteine in Thorvaldsens Künstlerbiografie 1 Jason und die Folgen Am 29. August 1796 bestieg Thorvaldsen in Kopenhagen die Fregatte Thetis, die ihn nach Malta brachte. Von dort reiste der Bildhauer nach Rom weiter, wo er sein Stipendium der Kopenhagener Kunstakademie antrat. Am 8. März 1797 erreichte er schließlich Rom und feierte dieses Datum fortan als seinen zweiten Geburtstag.1 Tags darauf schrieb Lorens Henrich Fisker, der Kapitän der Thetis, an seine Frau: „Thorvaldsen ist jetzt in Rom, Gott sei mit ihm! Er ist ein honetter Kerl, aber ein fauler Hund.“2 Die angebliche Bequemlich- keit des jungen Thorvaldsen sollte besonders in posthumen Biografien als Kontrast zur späteren Schaffenskraft betont und damit zu einem festen Bestandteil der Meistererzäh- lung seiner Künstlerbiografie gemacht werden.3 In Rom nahm sich der Archäologe Georg Zoëga seines jungen Landsmannes an. Während Fisker den Bildhauer als faul bezeichnet hatte, beklagte Zoëga dessen mangel- hafte Bildung. So betrachtete er Thorvaldsen zwar als äußerst begabten Künstler, jedoch sei er „höchst unwissend in allem, was ausserhalb der Kunst liegt“.4 Zoëga wunderte sich darüber, dass die Akademie ihre Stipendiaten „so roh“ nach Rom schicke, wo der Künstler „sehr viele Zeit verlieren muß, um Dinge zu lernen, ohne welche er seinen hiesigen Auf- enthalt nicht gehörig nützen kann, und welche er leichter und geschwinder vor der Reise hätte lernen können“.5 Weiter fragte er sich: 1 Thiele 1852 – 1856, Bd. 1, 33 – 46 (inkl. Thorvaldsens Reisetagebuch). Zu Thorvaldsens ‚römischem Ge- burtstag‘ siehe ebd., 46; auch Repholtz 1911, 41; Baronesse Stampes Erindringer 1912, 56. 2 Lorens Henrich Fisker an Charlotte Amalie Fisker, 9. -

Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger
Særtryk af FUND OG FORSKNING I DET KONGELIGE BIBLIOTEKS SAMLINGER Bind 50 2011 With summaries KØBENHAVN 2011 UDGIVET AF DET KONGELIGE BIBLIOTEK Om billedet på papiromslaget se s. 169. Det kronede monogram på kartonomslaget er tegnet af Erik Ellegaard Frederiksen efter et bind fra Frederik III’s bibliotek Om titelvignetten se s. 178. © Forfatterne og Det Kongelige Bibliotek Redaktion: John T. Lauridsen med tak til Ivan Boserup Redaktionsråd: Ivan Boserup, Grethe Jacobsen, Else Marie Kofod, Erland Kolding Nielsen, Anne Ørbæk Jensen, Stig T. Rasmussen, Marie Vest Fund og Forskning er et peer-reviewed tidsskrift. Papir: Lessebo Design Smooth Ivory 115 gr. Dette papir overholder de i ISO 9706:1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir. Grafisk tilrettelæggelse: Jakob Kyril Meile Nodesats: Niels Bo Foltmann Tryk og indbinding: SpecialTrykkeriet, Viborg ISSN 0060-9896 ISBN 978-87-7023-085-8 SPEAKING OF IRONY: Bournonville, Kierkegaard, H.C. Andersen and the Heibergs1 by Colin Roth t must have been exciting for the ballet historian, Knud Arne Jür Igensen, to discover a Bournonville manuscript in the Royal Library’s collection which opens with what is clearly a reference to Søren Kier ke gaard.2 Though not mentioned by name, Kierkegaard is readily identifiable because his Master’s degree dissertation on ‘The Concept of Irony’ is explicitly referred to in the first sentence. It was right that the discovery was quickly shared with researchers at the Søren Kierke gaard Research Centre at Copenhagen’s University. This article is a study of the document, its context and especially of the references con cealed within it. A complete transcription of the Danish original and a new English translation appear as appendices, one of which should, ideally, be read first. -

Katalin Nun. Women of the Danish Golden Age: Literature, Theater, and the Emancipation of Women
The Bridge Volume 40 Number 2 Article 15 2017 Katalin Nun. Women of the Danish Golden Age: Literature, Theater, and the Emancipation of Women. Nate Kramer Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/thebridge Part of the European History Commons, European Languages and Societies Commons, and the Regional Sociology Commons Recommended Citation Kramer, Nate (2017) "Katalin Nun. Women of the Danish Golden Age: Literature, Theater, and the Emancipation of Women.," The Bridge: Vol. 40 : No. 2 , Article 15. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/thebridge/vol40/iss2/15 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in The Bridge by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Katalin Nun. Women of the Danish Golden Age: Literature, Theater, and the Emancipation of Women. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2013. 196 pp. Reviewed by Nate Kramer Katalin Nun begins her book Women of the Danish Golden Age: Literature, Theater and the Emancipation of Women with the obligatory remarks about the signifi cance of the Danish Golden Age, but moves quickly to her main thesis: that the women who were also a part of that golden age have been overlooked, forgott en, or rendered impor- tant only because of the towering fi gures (men, of course!) of the pe- riod. Thus, Nun begins to carve out a space in which to address the authorships of Thomasine Gyllembourg and Mathilde Fibiger and the acting of Johanne Luise Heiberg, all three infl uential and important fi gures in their own right. -
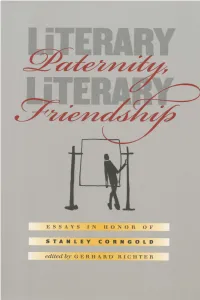
9781469658254 WEB.Pdf
Literary Paternity, Literary Friendship From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Literary Paternity, Literary Friendship Essays in Honor of Stanley Corngold edited by gerhard richter UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 125 Copyright © 2002 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Richter, Gerhard. Literary Paternity, Liter- ary Friendship: Essays in Honor of Stanley Corngold. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. doi: https://doi.org/ 10.5149/9780807861417_Richter Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Richter, Gerhard, editor. Title: Literary paternity, literary friendship : essays in honor of Stanley Corngold / edited by Gerhard Richter. Other titles: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures ; no. 125. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [2002] Series: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 2001057825 | isbn 978-1-4696-5824-7 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5825-4 (ebook) Subjects: German literature — History and criticism. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Daňo Juraj - (2007) do výtvarného života vstúpil tesne po 2. svetovej vojne; v tvorbe prekonal niekoľko vývojových zmien, od kompozícií dôsledne a detailne interpretujúcich farebné a tvarové bohatstvo krajiny, cez krajinu s miernou farebnou, tvarovou i rukopisnou expresionistickou nadsádzkou, až ku kompozíciám redukujúcim tvary na ich geometrickú podstatu; tak v krajinárskych, ako aj vo figurálnych kompozíciách, vyskytujúcich sa v celku jeho tvorby len sporadicky, farebne dominuje modro – fialovo – zelený akord; po prekonaní experimentálneho obdobia, v ktorom dospel k výrazne abstrahovanej forme na hranici informačného prejavu, sa upriamoval na kompozície, v ktorých sa kombináciou techník usiloval o podanie spoločensky závažnej problematiky; vytvoril aj celý rad monumentálno-dekoratívnych kompozícií; od roku 1952 bol členom východoslovenského kultúrneho spolku Svojina, zároveň členom skupiny Roveň; v roku 1961 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov; od roku 1969 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní; v roku 1984 mu bol udelený titul zaslúžilého umelca J. Daňo: Horúca jeseň J. Daňo: Za Bardejovom Heslo DANO – DAR Strana 1 z 22 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia J. Daňo J. Daňo: Drevenica Heslo DANO – DAR Strana 2 z 22 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia J. Daňo: J. Daňo Heslo DANO – DAR Strana 3 z 22 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia J. Daňo: Ulička so sypancom J. Daňo: Krajina Daňový peniaz - Zaplatenie dane cisárovi dánska loď - herring-buss Dánsko - dánski ilustrátori detských kníh - pozri L. Moe https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Danish_children%27s_book_illustrators M Christel Marotta Louis Moe O Ib Spang Olsen dánski krajinári - Heslo DANO – DAR Strana 4 z 22 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Danish_landscape_painters dánski maliari - pozri C. -

Medd. 1978, Beretning
Gengivelser i bscuit og terracotta efter Thorvaldsens arbejder. Erhvervet 1974-77. For at opbygge en lille studiesamling af ældre gengivelser efter Thorvald sens skulptureij har museet erhvervet et udvalg af biscuitfigurer og -relieffer fra Den Kgl. Porcelænsfabrik og Bing og Grøndahl. Efter museets udgivelse af »Biscnit efter Thorvaldsen« af Bredo Grandjean (1978) kan disse biscuit- eksemplarer nu dateres og kopisten bestemmes. Fra Bornholms Museum i Rønne erhvervedes i 1977 femten små relieffer i terracotta efter Thorvaldsen, fremstillede på L.Hjorths fabrik i Rønne omkring 1880. Eva Henschen BERETNING BESTYRELSEN I maj 1973 valgtes seminarierektor Carl-Einar Jørgensen til næstformand i bestyrelsen i stedet for arkitekt Peter Koch, der ønskede at afstå fra dette hverv. I maj 1974 valgte borgerrepræsentationen kontorchef Agnete Laustsen som medlem al bestyrelsen i stedet for forvalter K. J. Becker, der var udtrådt aí forsamlingen. 1. oktober 1974 trak borgmester Edel Saunte sig på grund af alder tilbage fra sin stilling som borgmester for magistratens 2. afdeling og hermed som formand lor museets bestyrelse. Borgmester Alsing Andersen efterfulgte Edel Saunte i embedet og valgtes 4. februar 1975 af bestyrelsen til dens formand. Højesteretspræsident Jørgen 1 rolle fratrådte 1. april 1975 sit embede og udtrådte hermed al museets bestyrelse. I hans sted valgte højesteret for resten al valgperioden til 31. marts 1976 højesteretsdommer Henrik Tamm som medlem af bestyrelsen. Ved valgperiodens udløb 1. april 1976 genvalgtes borgmester Alsing An 171 dersen, Carl-Einar Jørgensen og Agnete Laustsen af borgerrepræsentati onen. Rektor for Kunstakademiets billedkunstskoler, maleren Ole Schwalbe genvalgtes af akademirådet, og højesteretsdommer Henrik Tamm genvalg tes af højesteret. -

Volume 7, Tome III: Kierkegaard and His Danish Contemporaries – Literature, Drama and Aesthetics
Now available from Ashgate Publishing… Volume 7, Tome III: Kierkegaard and His Danish Contemporaries – Literature, Drama and Aesthetics Edited by Jon Stewart, Søren Kierkegaard Research Centre, University of Copenhagen, Denmark The period of Kierkegaard’s life corresponds to Denmark’s “Golden Contents: Hans Christian Andersen: Andersen was just an excuse, Age,” which is conventionally used to refer to the period covering Lone Koldtoft; Jens Baggesen: Kierkegaard and his master’s voice, roughly the first half of the nineteenth century, when Denmark’s most Henrik Blicher; Steen Steensen Blicher: the melancholy poet of the important writers, philosophers, theologians, poets, actors and artists Jutland heath, Sven Hakon Rossel; August Bournonville: leap of faith flourished. Kierkegaard was often in dialogue with his fellow Danes and the ‘noble art of Terpsichore’, Nathaniel Kramer; Mathilde Fibiger: on key issues of the day. Kierkegaard and the emancipation of women, Katalin Nun; Meïr The present volume, divided into 3 tomes features articles that Goldschmidt: the cross-eyed hunchback, Johnny Kondrup; Thomasine employ source-work research in order to explore the individual Gyllembourg: Kierkegaard’s appreciation of the everyday stories and Danish sources of Kierkegaard’s thought. Two Ages, Katalin Nun; Johan Ludvig Heiberg: Kierkegaard’s use of Tome III is dedicated to the diverse Danish sources that fall under Heiberg as a literary critic, George Pattison; Johanne Luise Heiberg: the rubrics “Literature, Drama and Aesthetics.” The Golden Age is an existential actress, Katalin Nun; Carsten Hauch: a map of mutual known as the period when Danish prose first established itself in misreadings, Poul Houe; Johan Nicolai Madvig: the master of Latin in genres such as the novel; moreover, it was also an age when some of Kierkegaard’s Parnassus, Jesper Eckhardt Larsen; Christian Molbech: Denmark’s most celebrated national poets flourished. -

Johanne Luise Heiberg Og Mutter Pätges
Henriette Pätges' værtshus i Ulkegade. Tuschtegning af Alfred V. Larsen, 1930. Johanne Luise Heiberg og Mutter Pätges 42 Johanne Luise Heiberg og Mutter Pätges Det er i år 200 år siden, Johanne Luise Heiberg blev født. Johanne Lui- ses mor Henriette Pätges drev af flere omgange værtshus, og stemnin- gen i disse beværtninger adskilte sig væsentligt fra de kredse, Johanne Luise senere skulle færdes i. Læseren får her et indblik i begge verdener. Af Merete Næsbye Christensen Johanne Luise Heiberg ville være fyldt 200 år den traktørsted ved navn Lille Ravnsborg. Indehaveren 22. november i år.1 Både som skuespiller og men- var formelt Christian Heinrich Pätges, men det neske er hun blevet bedømt meget lidenskabeligt – blev reelt drevet af hustruen Henriette Pätges, født både for og imod! Hartvig. Mens man boede og arbejdede her, fødtes Hendes liv var præget af mange modsætningsfor- de sidste af parrets 8 børn, herunder det næstyng- hold. Hun kom fra beskedne kår på Nørrebro, men ste, Johanne Luise, der blev født den 22. november avancerede socialt og flyttede til en herskabslejlig- 1812 og døbt den 1. januar 1813 i Sankt Petri. hed i København K. Hun kunne være endt som servitrice og bakkesan- I Adresseavisen for 3. juni 1813 blev det annonceret, gerinde men blev i stedet en højt respekteret skue- at der hver søndag og mandag fra 6-10½ er musik spillerinde, gift med en forfatter, filosof, teaterchef og dans ”alene til Fornøjelse for anstændige og hon- og etatsråd. ette Borgerfolk og deres Børn”. Sidst, men ikke mindst, bevægede hun sig fra dob- belt minoritetsstatus, som datter af en jødisk mor Forretningen blev drevet dér til 25. -

Literature Jens Lohfert Jørgensen, Aalborg University
Literature Jens Lohfert Jørgensen, Aalborg University This survey covers the years 2010 and 2011 1. General Anne-Marie Mai, Hvor litteraturen finder sted, i: Fra Guds tid til menneskets tid 1000–1800, 2010, ii: Længslens tidsaldre 1800–1900, 2010, iii: Moderne tider 1900–2010, Gyldendal, 473, 294, 496 pp., presents an innovative approach to Danish literary history. It is structured around (some of) the sites where literature has historically taken place, in and outside the country: the cathedral, exemplified by Ribe cathedral; the manor house and the court, exemplified by Anne Krabbe’s Jutland manor Stenalt, and Frederik II’s and Christian IV’s courts respectively; the academy, exemplified by Sorø Academy; the vicarage and the salon, by Nikolai Frederik Severin Grundvig’s vicarage in Udby and Friederike Brun’s salon on Sophienholm; the newspaper office, by Politikens hus in Copenhagen; the metropolis, by New York; and finally the virtual site constituted by the internet, exemplified by www.afsnit.dk, which is the oldest Danish literary site on the internet. Though Ribe Cathedral and Sorø Academy, in particular, are cultural centres that connect the literature of different historical periods, in M.’s depiction each site represents one particular period: from the Middle Ages to the present day. This brings literature alive. The analysis of the cathedral, for instance, is introduced by a description of how the phenomenological perception of time and space changes when one steps inside. M. thereby presents the reader with a somatic experience of Danish literary history, which no critic has previously achieved. Hvor litteraturen finder sted stands apart from its predecessors by the theoretical level of reflection that characterizes it. -

Theaterudstilling
INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK '• K. Theaterudstillingen. Udstillingen søger synligt at skildre det kongelige The aters Udvikling indtil Aaret 1874, da den nye Theaterbygning blev taget i Brug. Kun de dengang virkende Kræfter ere fulgte videre i Tiden. For de private Theatres Vedkommende er 1874 ogsaa sat som Grænseskjel. Indholdsfortegnelse. Det kongelige Theater. Indledning (Nr. 1—3). I. Theatret i Lille Grønnegade 1721 -1728. (Nr. 4—119). II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere 1748—1770. (Nr. 120-160). Danske Forfattere paa den danske Skueplads 1748—1770. (Nr. 161-164). Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads 1748-1770. (Nr. 165-176). III. Det kongelige Theater og dets Kunstnere 1770-1801. (Nr. 177-290). Danske Forfattere paa det kongelige Theater 1770-1801. (Nr. 291-364). Fremmede Forfattere paa det kongelige Theater 1770-1801. (Nr. 365-382). IY. Det kongelige Theater og dets Kunstnere 1801-1849. (Nr. 383-939). Danske Forfattere paa det kongelige Theater 1801-1849. (Nr. 940-1146). 1* Musikere og danske Komponister paa det kongelige Theater 1801-1849. (Nr. 1147—1171a). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater 1801-1849. (Nr. 1172-1221). V. Det kongelige Theater og dets Kunstnere 1849—1874. (Nr. 1222-1667). Danske Komponister og Forfattere paa det kongelige Theater 1849-1874. (Nr. 1668-1683). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater m. m. 1849-1874. (Nr. 1684-1702). VI. Forfattere af det kongelige Theaters Historie. (Nr. 1703-1707). VII. Theaterdekorationer i Modeller. (Nr. 1708—1719). VIII. Tegninger til det kongelige Theaters Dekorationer. -

Medd. 1997, Lundgreen-Nielsen
GRUNDTVIG AND COPENHAGEN DURING DENMARK'S GOLDEN AGE FLEMMING LUNDGREEN-NIELSEN BY Did Grundtvig really belong in Copenhagen during analysis and self-projection that fo rmed the basis of the Golden Age? In a literal sense, of course yes. He his authorship. Hans Christian Andersen did the lived in the capital throughout his professionally same, though to a less deliberate extent. But this was active life, spending a total of 65 years at 24 different not how Grundtvig used Copenhagen. When Grundt addresses. But in a figurative sense, virtually no. He vig walked in the streets of the capital it was not just 1 differs in important respects from the other great to be seen but because he had to go somewhere, fo r personalities of the age. example to a meeting in the Rigsdag (Parliament), or S0ren Kierkegaard was able to play upon the city's to call on friends. Sometimes - though perhaps not possibilities like a virtuoso on his instrument, trans so very often - he sought solitude, inspiration or a fo rming streets, squares, cafes, the theatre and the little fresh air by walking in Rosenborg Park (fig. 56) churches into catalysts for the tireless process of self- or on the city ramparts at Ve sterport? He made one 56. Henrik Gottfred Beenfeldt (1767-1829): The Gardens ofRo senborg Palace 1810. Tempera. 240 332 mm. K0benhavns . X BFIG.ymuseum, Copenhagen. lnv. no. 1932. 143. Rosenborg Gardens were opened to the public in 1771, offering the pleasant possibility of taking a country walk within the ramparts of the confined and overcrowded capital.