CS Lewis Le Cronache Di Narnia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
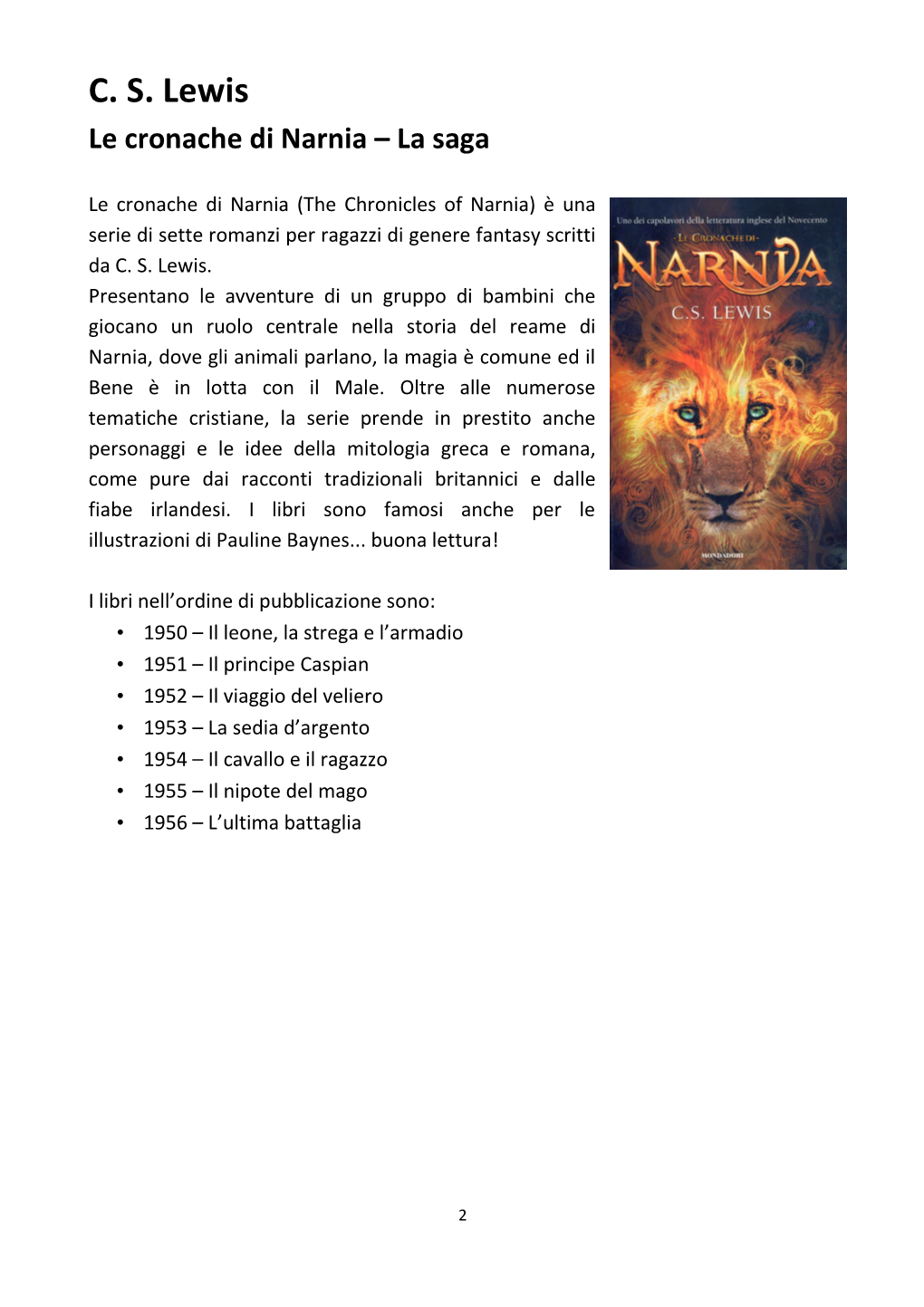
Load more
Recommended publications
-

Feminism and Spiritual Heroism in C. S. Lewis's the Chronicles Of
Feminism and spiritual heroism in C. S. Lewis’s The Chronicles of Narnia Raita Markkanen University of Tampere School of Language, Translation and Literary Studies English language and literature Master’s thesis May 2016 Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Filosofian maisterin tutkinto MARKKANEN, RAITA: Feminism and spiritual heroism in C. S. Lewis’s The Chronicles of Narnia Pro gradu -tutkielma, 62 sivua + lähdeluettelo 2 sivua Toukokuu 2016 Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee aihetta feminismi ja henkinen sankaruus C. S. Lewisin kirjasarjassa Narnian tarinat . Tutkimuksen päätarkoitus on tutkia Lewisin kirjoissa esiintyvää naiskuvaa. Tutkimuskysymyksiä ovat: välittävätkö Narnian tarinat lukijalleen seksististä naiskuvaa vai voidaanko väittää, että Lewisin tarinat ovat feministisen ideologian mukaisia; onko naisten käyttäminen pahoina roolihahmoina seksististä; ilmentääkö Susanin jättäminen pois ”pelastettujen” joukosta Lewisin naisvihaa tai seksismiä; ja onko Narnian tarinoissa esiintyvä patriarkaalinen hierarkia todistus naisia alistavasta ideologiasta? Tarkastelen tutkimuksessa Narnian tarinoita feministisestä ja kristillisestä näkökulmasta. Feministinen näkökulma toisaalta osoittaa miksi Narnian tarinoita pidetään seksistisinä ja toisaalta selittää miksi esimerkiksi Susanin tuomitseminen ei ole seksististä, miksi tarinoissa suositaan näennäisesti epänaisellista naiskuvaa ja miksi muun muassa Susanin ja Lasaraleenin edustama, näennäisesti naisellisempi naiskuva torjutaan. Feministisen näkökulman -

The Voyage of the Dawn Treader (The Chronicles of Narnia Facsimile, Book 5) Pdf
FREE THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER (THE CHRONICLES OF NARNIA FACSIMILE, BOOK 5) PDF C. S. Lewis,Pauline Baynes | 224 pages | 30 Sep 2010 | HarperCollins Publishers | 9780007360819 | English | London, United Kingdom What are the Christian themes in The Voyage of the Dawn Treader? | The Voyage of the Dawn Treader [a] is a high fantasy novel for children by C. Lewispublished by Geoffrey Bles in It was the third published of seven novels in The Chronicles of Narnia — and Lewis had finished writing it inbefore the first book was out. The Voyage of the Dawn Treader (the Chronicles of Narnia Facsimile the others, it was illustrated by Pauline Baynes and her work has been retained in many later editions. Lewis dedicated the book to Geoffrey Corbett. He is the foster-son of Owen BarfieldThe Voyage of the Dawn Treader (the Chronicles of Narnia Facsimile friend, teacher, adviser and trustee of Lewis. Macmillan US published an American edition within the calendar year [1] [3] with substantial revisions that were retained in the US until The Voyage of the Dawn Treader has been adapted and filmed as four episodes of a BBC television series in Book 5) as a feature film in The two youngest Pevensie children, Lucy and Edmundare staying with their odious cousin Eustace Scrubb while their older brother, Peteris studying for an exam with Professor Kirkeand their older sister, Susanis travelling through America with their parents. Edmund, Lucy, and Eustace are drawn into the Narnian world through a picture of a ship at sea. The painting, hanging neglected in the guest bedroom in which Lucy was staying, had been an unwanted present to Eustace's parents. -
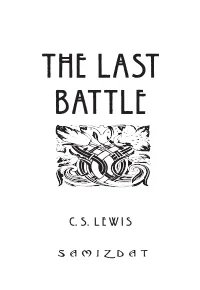
The Last Battle. (First Published 1956) by C.S
The Last Battle C. S. L e w i s Samizdat The Last Battle. (first published 1956) by C.S. Lewis (1895-1963) Edition used as base for this ebook: New York: Macmillan, 1956 Source: Project Gutenberg Canada, Ebook #1157 Ebook text was produced by Al Haines Warning : this document is for free distribution only. Ebook Samizdat 2017 (public domain under Canadian copyright law) Disclaimer This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost. Copyright laws in your country also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of flux. If you are outside Canada, check the laws of your country before down- loading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this Samizdat Ebook. Samizdat makes no claims regarding the copyright status of any work in any country outside Canada. Table Of Contents CHAPTER I By Caldron Pool 1 CHAPTER II The Rashness of the King 8 CHAPTER III The Ape in Its Glory 15 CHAPTER IV What Happened that Night 22 CHAPTER V How Help Came to the King 28 CHAPTER VI A Good Night's Work 35 CHAPTER VII Mainly About Dwarfs 42 CHAPTER VIII What News the Eagle Brought 50 CHAPTER IX The Great Meeting on Stable Hill 57 The Last Battle iii CHAPTER X Who Will Go into the Stable? 64 CHAPTER XI The Pace Quickens 71 CHAPTER XII Through the Stable Door 78 CHAPTER XIII How the Dwarfs Refused to be Taken In 85 CHAPTER XIV Night Falls on Narnia 93 CHAPTER XV Further Up and Further In 100 CHAPTER XVI Farewell to Shadow-Lands 107 CHAPTER I By Caldron Pool n the last days of Narnia, far up to the west beyond Lantern Waste and close beside the great waterfall, there lived an Ape. -

Ÿþm I C R O S O F T W O R
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI A RE-EXAMINATION THAT FEMALE ANTAGONISTS ARE REPRESENTATIONS OF MISOGNY IN C. S LEWIS’ S THE CHRONICLES OF NARNIA AN UNDERGRADUATE THESIS Presented as Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Sarjana Sastra In English Letters By Margareth Aritonang Student Number: 014214063 ENGLISH LETTERS STUDY PROGRAMME DEPARTMENT OF ENGLISH LETTERS FACULTY OF LETTERS SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2007 1 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI A RE-EXAMINATION THAT FEMALE ANTAGONISTS ARE REPRESENTATIONS OF MISOGNY IN C. S LEWIS’ S THE CHRONICLES OF NARNIA AN UNDERGRADUATE THESIS Presented as Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Sarjana Sastra In English Letters By Margareth Aritonang Student Number: 014214063 3 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI “Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari” (Pengkhotbah 1:9) 4 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI They give me references to what Life is and help me to open my heart to the mystery of it. This thesis is my deepest expression of thankfulness and prayers to them: My parents, brothers, and sister, Sr. Clare Hand, FCJ The Jansons: Sheralyn, Rinus, Luke and Daniel Faculty of Letters, University of Sanata Dharma, Sunday School Ministry, Yogyakarta International Congregation, Domby Kids Hope, Ex-CO Mrican, And those who I’ve encountered in my life 5 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI ACKNOWLEDGEMENTS I am greatly indebted to Dr. Novita Dewi, who has patiently guided me during the process of writing this thesis. -

Opinnäytteen Nimi
UNIVERSITY OF HELSINKI The strength of female characters in C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia Satu Manninen Master’s Thesis English Philology Department of Modern Languages University of Helsinki April 2016 Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Laitos – Institution – Department Humanistinen tiedekunta Nykykielten Laitos Tekijä – Författare – Author Satu Manninen Työn nimi – Arbetets titel – Title The strength of female characters in C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia Oppiaine – Läroämne – Subject Englantilainen filologia Työn laji – Arbetets art – Level Aika – Datum – Month and Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages year Pro Gradu -tutkielma Huhtikuu 2016 69 Tiivistelmä – Referat – Abstract Tässä tutkielmassa analysoin C.S. Lewisin Narnian tarinat-kirjasarjan vahvoja naishahmoja. Tutkielman keskeisiä teemoja ovat kristinuskon vaikutteet Lewisin henkilöhahmoissa ja sankaruuden käsite. Analysoin jokaista valitsemaani henkilöhahmoa edellä mainittujen teemojen pohjalta tarkoituksenani selvittää, miten ne vaikuttavat hahmojen sankaruuteen. Analyysini kohteena on viisi naishahmoa, joista jokaisella on tärkeä rooli Lewisin kirjasarjassa. Kolme henkilöä, Lucy, Aravis ja Jill, ovat sankarittaria, jotka esiintyvät Narniassa keskeisissä rooleissa. Kaksi muuta henkilöä, Jadis ja Vihreä Velho, ovat noitia, jotka edustavat Narnian pääasiallisia vastustajia eri tarinoissa. Analysoin sekä hyviä että pahoja henkilöhahmoja tuodakseni esiin naishahmojen moniulotteisuuden Narniassa. Ensimmäistä teemaa, kristinuskon vaikutusta, tutkin vertaamalla -

Download (534Kb)
CHAPTER II LITERATURE REVIEW A. Theoretical Review 1. Proper Noun a. The Terminology of Proper Noun Proper noun holds an essential role in the literary works especially novel because without the existence of proper noun the works will be meaningless. Proper noun contains the names of characters, places, the geographical, time, etc. In general, the proper noun has different characteristics with the common nouns. Many scholars have different perspectives on the definition and understanding of proper noun in translation studies. Proper nouns are recognized in some cultures as an indication that the proper nouns could be introduced as "Cultural markers," that is, they implicitly point to which culture owned characters (Nord, 2003: 184). The statement indicates that from the name of something, there will be known where the names come from. Names have cultural values that are will become an identity. For example, if a man called Sirgudsson or Larsson appears in Indonesian plot story of novel, the reader as a native of Indonesia, they will be directly assumed that name as foreigners or Iceland people. It shows that the proper noun has an essential and important role in literary works. Even though the proper nouns are not only talk about the name of people but it is more than those things. Then, the detail explanation of proper noun will be explained in the paragraphs below. 12 As simply according to The Oxford Concise English Dictionary (2001) in Ester (2016: 12) states that proper noun is "a name for someone, place, or organization that has an initial capital letter". Then, according to Hartmann and Stork as cited in Valentine, Brennen, Bredart, (2002: 2) that proper noun is any nouns that could be the name of an individual person, place or object, as opposed to a common noun which refers to any one of all things denoted by the noun. -
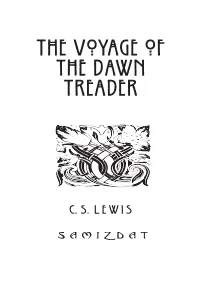
The Voyage of the Dawn Treader. (First Published 1952) by C.S
The Voyage of the Dawn Treader C. S. L e w i s Samizdat The Voyage of the Dawn Treader. (first published 1952) by C.S. Lewis (1895-1963) Edition used as base for this ebook: London: Geoffrey Bles, 1964 [fifth printing] Source: Project Gutenberg Canada, Ebook #1155 Ebook text was produced by Al Haines Warning : this document is for free distribution only. [EN] = Editor's note. Ebook Samizdat 2017 (public domain under Canadian copyright law) Disclaimer This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost. Copyright laws in your country also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of flux. If you are outside Canada, check the laws of your country before down- loading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this Samizdat Ebook. Samizdat makes no claims regarding the copyright status of any work in any country outside Canada. To Geoffrey Barfield Table Of Contents CHAPTER I The Picture in the Bedroom 1 CHAPTER II On Board the Dawn Treader 9 CHAPTER III The Lone Islands 19 CHAPTER IV What Caspian Did There 27 CHAPTER V The Storm and What Came of It 35 CHAPTER VI The Adventures of Eustace 43 CHAPTER VII How the Adventure Ended 52 CHAPTER VIII Two Narrow Escapes 60 CHAPTER IX The Island of the Voices 70 The Voyage of the Dawn Treader iii CHAPTER X The Magician's Book 79 CHAPTER XI The Dufflepuds Made Happy 89 CHAPTER XII The Dark Island 98 CHAPTER XIII The Three Sleepers 106 CHAPTER XIV The Beginning of the End of the World 114 CHAPTER XV The Wonders of the Last Sea 122 CHAPTER XVI The Very End of the World 130 Chapter I The Picture in the Bedroom here was a boy called Eustace Clarence Scrubb, and he almost deserved it. -

THE ROMANCES of CLIVE STAPLES LEWIS. The
This dissertation has been microfilmed exactly as received 7 0 -4 4 6 2 CHRISTOPHER, Joe Randell, 1935- THE ROMANCES OF CLIVE STAPLES LEWIS. The University of Oklahoma, Ph.D., 1969 Language and Literature, modern University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan 0 Copyright by JOE BAKDELL CHRISTOPHER 1970 All quotations from copyrighted material are reproduced under the fair quotation provision of the copyright law. THE UNIVERSITY OP OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE THE ROMANCES OP CLIVE STAPLES LEWIS A DISSERTATION SUBMITTED TO TSE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OP PHILOSOPHY BY JOE RANDELL CHRISTOPHER Norman, Oklahoma 1969 TEE ROMANCES OF CLIVE STAPLES LEWIS APPROVED BY ~A O^^IO'wQ, DISSERTATION COMMITTE: This dissertation Is dedicated to Dr. Paul George Ruggiers, who directed It; to Dr. John Marlin Raines, who first encouraged my professional Interest in G. S. Lewis; to Drs, Victor A. Elconln, Rudolph Charles Bambas, David P. French, and Alphonese Joseph Fritz, who served on my committee; and to my wife, who typed the whole thing twice. Ill \ \ TABLE OF CONTENTS Chapter . Page I, Of Confessions, Anatomies, Romances 1 II. ]%rmer .... 1? III. 'Hie Pilgrim's Regress 26 IV. The Hansom Trilogy 57 V. A Note on Screwtape 1^3 VI. The Great Divorce 155 VII. The Chronicles of Namia 185 VIII, Till We Have Paces 290 EC. Of Romances 328 Bibliography: Part One Works by Lewis ............. 338 Blbllograp)tiy: Part Two Works about Lewis (annotated) ............ 3^5 Bibliography: Part Three Other Works Consulted 404 Appendix One ^11 Appendix Two •,,,..,.,.o...... 4l6 Appendix Three 425 Appendix Four ......... -
Reading Guide Group Gu 1
gp Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Gro Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Guide Reading Group Gu eading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Guide Reading Group Reading Group Guide Read Group Guide Reading Gro The Voyage of the Dawn Treader The Last Battle Reading GroupGuide Reading Guide Group Gu 1. Eustace’s character changes drastically, though not 1. Though Puzzle helps Shift further his evil plans, he Reading Group Guide Read completely. What vestiges of his old self remain, and is easily forgiven. Does the outcome differ for those Group Guide Reading Gro what new qualities emerge? who act on their own conscience instead of Guide Reading Group Gu following the orders of others? What judgments does 2. Each of the islands seems to contain some Reading Group Guide Read the book render on faith, leadership, and human negative aspect. How do the portrayals of the islands Group Guide Reading Gro behavior? illustrate which qualities should be most eschewed? Guide Reading Group Gu Are any of the islands’ qualities portrayed favorably? 2. Beloved Narnia is demolished both by creatures and Reading Group Guide Read larger forces. Does the existence of a better, truer 3. Though Reepicheep is a comical character, he is also Group Guide Reading Gro Narnia temper this apocalyptic phase? brave. How is his bravery characterized? How does he Guide Reading Group Gu differ from other characters? 3. Of which ideals of the afterlife is this book a Reading Group Guide Read proponent? Do these ideals mesh with your own Group Guide Group Gu 4. -
Answer Key to the Voyage of the Dawn Treader Study Guide
Answer Key to The Voyage of the Dawn Treader Study Guide © 2012 C.S. Lewis Foundation. For more information and other study guides, please visit www.cslewis.org Chapter 1: The Picture in the Bedroom Vocabulary Enrichment Activities: A. Fill in the blanks with the words or expressions from the lists above that make the most sense based on the story. 1) Although he was puny, Eustace was a bully. 2) The ship in the picture was listing to her port side. 3) The prow of the ship was shaped like a dragon’s head. 4) It was the briny smell that convinced Lucy she wasn’t dreaming. 5) When he found himself standing on the picture frame, Eustace lost his head and clutched at the others. 6) A great blue roller swept all three children into the sea. 7) Instead of wine, Eustace wanted Plumptree’s Vitaminised Nerve Food, made with distilled water. 8) Eustace thought Reepicheep was a silly, vulgar, performing animal. 9) Caspian gave Lucy the stern cabin. 10) The Dwarf-made silver lamp in the cabin was exquisite. B. Correctly use each of these words in a sentence: 1) gilded 2) valiant 3) discourteous 4) courtly 5) rummaging © 2012 C.S. Lewis Foundation 2 of 34 Comprehension – Answer the following questions based on Chapter 1. 1) What did Eustace call his parents? Harold and Alberta 2) How were Eustace and the Pevensies related? They were cousins. 3) Why were Edmund and Lucy staying with Eustace and his parents? Because their parents and Susan had gone to America for the summer. -

The Last Battle C.S
The Last Battle C.S. Lewis CHAPTER ONE BY CALDRON POOL IN the last days of Narnia, far up to the west beyond Lantern Waste and close beside the great waterfall, there lived an Ape. He was so old that no one could remember when he had first come to live in those parts, and he was the cleverest, ugliest, most wrinkled Ape you can imagine. He had a little house, built of wood and thatched with leaves, up in the fork of a great tree, and his name was Shift. There were very few Talking Beasts or Men or Dwarfs, or people of any sort, in that part of the wood, but Shift had one friend and neighbour who was a donkey called Puzzle. At least they both said they were friends, but from the way things went on you might have thought Puzzle was more like Shift's servant than his friend. He did all the work. When they went together to the river, Shift filled the big skin bottles with water but it was Puzzle who carried them back. When they wanted anything from the towns further down the river it was Puzzle who went down with empty panniers on his back and came back with the panniers full and heavy. And all the nicest things that Puzzle brought back were eaten by Shift; for as Shift said, "You see, Puzzle, I can't eat grass and thistles like you, so it's only fair I should make it up in other ways." And Puzzle always said, "Of course, Shift, of course. -

C.S. Lewis the Chronicles of Narnia
C.S. Lewis The Chronicles Of Narnia THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE BY C.S.LEWIS CHAPTER ONE LUCY LOOKS INTO A WARDROBE ONCE there were four children whose names were Peter, Susan, Edmund and Lucy. This story is about something that happened to them when they were sent away from London during the war because of the air-raids. They were sent to the house of an old Professor who lived in the heart of the country, ten miles from the nearest railway station and two miles from the nearest post office. He had no wife and he lived in a very large house with a housekeeper called Mrs Macready and three servants. (Their names were Ivy, Margaret and Betty, but they do not come into the story much.) He himself was a very old man with shaggy white hair which grew over most of his face as well as on his head, and they liked him almost at once; but on the first evening when he came out to meet them at the front door he was so odd-looking that Lucy (who was the youngest) was a little afraid of him, and Edmund (who was the next youngest) wanted to laugh and had to keep on pretending he was blowing his nose to hide it. As soon as they had said good night to the Professor and gone upstairs on the first night, the boys came into the girls' room and they all talked it over. "We've fallen on our feet and no mistake," said Peter.