Esodi Di Italiani Dalla Dalmazia E Dal Dodecaneso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
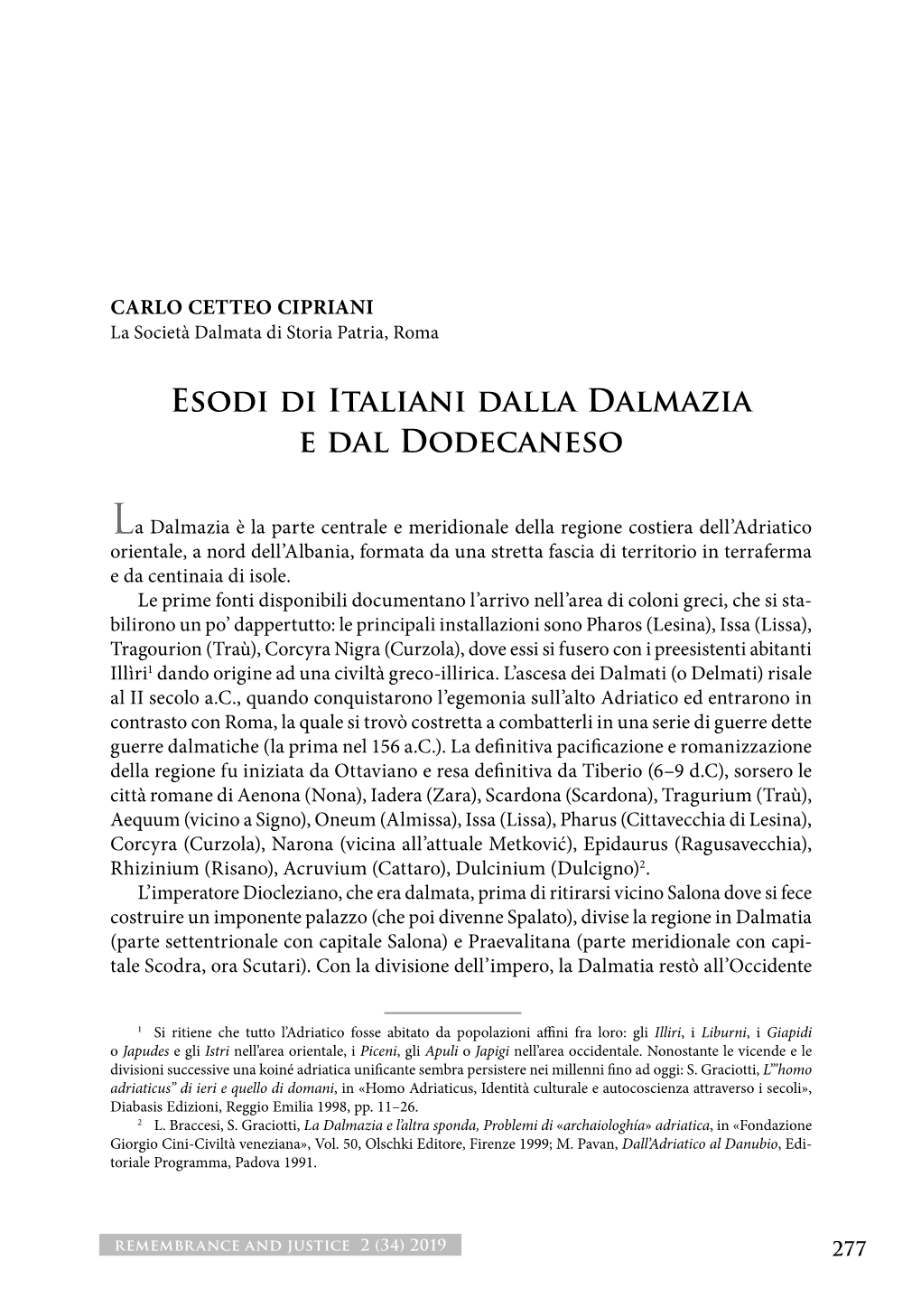
Load more
Recommended publications
-

Quaderni Musicali Marchigiani 14
Quaderni Musicali Marchigiani 14 a cura di Concetta Assenza Pubblicazione dell’A.Ri.M. – Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI 14/2016 a cura di Concetta Assenza ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) via P. Bonopera, 55 – 60019 Senigallia www.arimonlus.it [email protected] QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 Comitato di redazione Concetta Assenza, Graziano Ballerini, Lucia Fava, Riccardo Graciotti, Gabriele Moroni Realizzazione grafica: Filippo Pantaleoni ISSN 2421-5732 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 a cura di Concetta Assenza In copertina: Particolare dell’affresco di Lorenzo D’Alessandro,Madonna orante col Bambino e angeli musicanti, 1483. Sarnano (MC), Chiesa di Santa Maria di Piazza. La redazione del volume è stata chiusa il 30 giugno 2016 Copyright ©2016 by A.Ri.M. – onlus Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i Paesi. «Quaderni Musicali Marchigiani» – nota Lo sviluppo dell’editoria digitale, il crescente numero delle riviste online, l’allargamento del pubblico collegato a internet, la potenziale visibilità globale e non da ultimo l’abbattimento dei costi hanno spinto anche i «Quaderni Musicali Marchigiani» a trasformarsi in rivista online. Le direttrici che guidano la Rivista rimangono sostanzialmente le stesse: particolare attenzione alle fonti musicali presenti in Regione o collegabili alle Marche, rifiuto del campanilismo e ricerca delle connessioni tra storia locale e dimensione nazionale ed extra-nazionale, apertura verso le nuove tendenze di ricerca, impostazione scientifica dei lavori. -

Qualestoria1 2018 Corretto.Pdf
1 EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA QUALESTORIA Rivista di storia contemporanea 1 qs Anno XLVI, N.ro 1, Giugno 2018 EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE «QUALESTORIA» 1 2018 Rivista di storia contemporanea Periodico semestrale Realizzata con il contributo della Comitato di redazione Gorazd Bajc, Francesca Bearzatto, Fulvia Benolich, Irene Bolzon, Tullia Catalan, Franco Cecotti, Katja Hrobat Virlo- get, Patrick Karlsen, Giulio Mellinato, Gloria Nemec, Lorenzo Nuovo, Raoul Pupo, Roberto Spazzali, Fabio Todero, Fabio Verardo, Gianluca Volpi Comitato scientifico Giuseppe Battelli, Marco Bellabarba, Massimo Bucarelli, Andrea Di Michele, Marco Dogo, Gabriele D’Ottavio, Paolo Ferrari, Aleksej Kalc, Giorgio Mezzalira, Marco Mondini, Luciano Monzali, Egon Pelikan, Giovanna Procacci, Silvia Salvatici, Nevenka Troha, Marta Verginella, Rolf Wörsdörfer Direttore Gloria Nemec Direttore responsabile Roberto Spazzali Vicedirettore scientifico Raoul Pupo Redazione Francesca Bearzatto Direzione, redazione e amministrazione Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia Salita di Gretta 38, 34136 Trieste telefono: 040.44004 fax: 0404528784 mail: [email protected] sito: http://www.irsml.eu/qualestoria/ «Qualestoria» è la rivista dell’Irsrec FVG, fondata nel 1973 come «Bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia». Ospita contributi di autori italiani e stranieri, promuovendo la pubblicazione di numeri monografici e miscellanei. La rivista propone tradizionalmente tematiche legate alla storia contemporanea dell’area alto-adriatica e delle zone di frontiera, rivolgendo particolare attenzione allo studio e alla storiografia dei paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica. Le proposte di pubblicazione vanno inviate all’indirizzo e-mail della redazione. -

Bollettino Periodici
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA BOLLETTINO PERIODICI 2008 _________ A cura di Carla Capobianchi Con la collaborazione di Nicoletta Grella INDICE ___________________________________________________ Premessa Acta apostolicae sedis pag. 1 Administrative science quarterly pag. 16 Annali di storia moderna e contemporanea pag. 21 Archivi pag. 24 Archivio storico italiano pag. 27 Argomenti umani pag. 34 Aspenia pag. 49 Belfagor pag. 63 Bollettino d’arte pag. 72 Charta minuta pag. 75 (La) Civilta’ cattolica pag. 98 Clio pag. 125 Connaissance des arts pag. 129 (Il) Corriere giuridico pag. 142 Democrazia e diritto pag. 167 Diritto amministrativo pag. 168 Diritto dell’Unione Europea pag. 172 Diritto e societa’ pag. 177 Diritto pubblico pag. 180 Diritto pubblico comparato ed europeo pag. 183 Federalismo fiscale pag. 208 (Il) Filangieri pag. 211 (Il) Foro amministrativo – C.d.S. pag. 213 (Il) Foro amministrativo – T.A.R. pag. 223 (Il) Foro italiano pag. 234 Funzione pubblica pag, 255 Giornale di storia costituzionale pag. 258 Giurisdizione amministrativa pag. 262 Giurisprudenza costituzionale pag. 268 Giurisprudenza italiana pag. 279 Guida al diritto pag. 307 (L’) Industria pag. 318 Italianieuropei pag. 323 Iustitia pag. 338 (Il) Lavoro nelle pubbliche amministrazioni pag. 346 Lex pag. 355 Limes pag. 355 Micromega pag. 377 (Il) Mulino pag. 393 Nuova antologia pag. 408 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza pag. 424 (Le) Nuove leggi civili commentate pag. 467 (Il) Nuovo diritto pag. 480 Passato e presente pag. 487 Percorsi costituzionali pag. 491 Politica del diritto pag. 495 (Il) Ponte pag. 499 Quaderni costituzionali pag. 522 Quaderni di scienza politica pag. 534 Quaderni di storia pag. -

Leone Fortis E Arturo Colautti*
ADRIANA GUARNIERI CORAZZOL IDENTITÀ NAZIONALE E QUESTIONE WAGNERIANA TRA GIORNALISMO E ROMANZO: LEONE FORTIS E ARTURO COLAUTTI* ABSTRACT Il saggio affronta il tema del dibattito ottocentesco che oppone in un primo tempo la mu- sica italiana a quella tedesca, per precisarsi in seguito come opposizione Verdi vs Wagner, in modo particolare nell’ambito del movimento della Scapigliatura e dei suoi dintorni. Di quest’ultimo si prende in considerazione (con citazioni dai suoi articoli) un noto giorna- lista, Leone Fortis, finora poco analizzato negli studi sul dibattito wagneriano in Italia. Per il periodo successivo (anni Novanta), sempre in merito al caso Wagner italiano, il contri- buto cita e commenta passi di un romanzo di Arturo Colautti, steso negli anni in cui in- furia in Italia la ‘battaglia’ tra verdiani e wagneriani. PAROLE CHIAVE Nazionalismo, Opera italiana, Wagner, Leone Fortis, Arturo Colautti SUMMARY The essay is devoted to the nineteenth-century debate on Italian music as opposed to German music, which later (and most notably among the representants of the Scapiglia- tura) took the form of an opposition between Verdi and Wagner. The article focuses on the writings of a well-known (but as yet little studied in relation to the Wagnerian debate in Italy) Scapigliato journalist – Leone Fortis. As concerns the reception of Wagner’s works in the s, the analysis concentrates on some passages of a novel written by Ar- turo Colautti in the very years when the ‘battle’ between Verdians and Wagnerians swept Italy. KEYWORDS Nationalism; Italian Opera; Richard Wagner; Leone Fortis; Arturo Colautti ! Philomusica on-line. Rivista del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali N. -

A C AHAH C (Key of a Major, German Designation) a Ballynure Ballad C a Ballynure Ballad C (A) Bal-Lih-N'yôôr BAL-Ludd a Capp
A C AHAH C (key of A major, German designation) A ballynure ballad C A Ballynure Ballad C (A) bal-lih-n’YÔÔR BAL-ludd A cappella C {ah kahp-PELL-luh} ah kahp-PAYL-lah A casa a casa amici C A casa, a casa, amici C ah KAH-zah, ah KAH-zah, ah-MEE-chee C (excerpt from the opera Cavalleria rusticana [kah-vahl-lay-REE-ah roo-stee-KAH-nah] — Rustic Chivalry; music by Pietro Mascagni [peeAY-tro mah-SKAH-n’yee]; libretto by Guido Menasci [gooEE-doh may-NAH-shee] and Giovanni Targioni-Tozzetti [jo-VAHN-nee tar-JO- nee-toht-TSAYT-tee] after Giovanni Verga [jo-VAHN-nee VAYR-gah]) A casinha pequeninaC ah kah-ZEE-n’yuh peh-keh-NEE-nuh C (A Tiny House) C (song by Francisco Ernani Braga [frah6-SEESS-kôô ehr-NAH-nee BRAH-guh]) A chantar mer C A chantar m’er C ah shah6-tar mehr C (12th-century composition by Beatriz de Dia [bay-ah-treess duh dee-ah]) A chloris C A Chloris C ah klaw-reess C (To Chloris) C (poem by Théophile de Viau [tay- aw-feel duh veeo] set to music by Reynaldo Hahn [ray-NAHL-doh HAHN]) A deux danseuses C ah dö dah6-söz C (poem by Voltaire [vawl-tehr] set to music by Jacques Chailley [zhack shahee-yee]) A dur C A Dur C AHAH DOOR C (key of A major, German designation) A finisca e per sempre C ah fee-NEE-skah ay payr SAYM-pray C (excerpt from the opera Orfeo ed Euridice [ohr-FAY-o ayd ayoo-ree-DEE-chay]; music by Christoph Willibald von Gluck [KRIH-stawf VILL-lee-bahlt fawn GLÔÔK] and libretto by Ranieri de’ Calzabigi [rah- neeAY-ree day kahl-tsah-BEE-jee]) A globo veteri C AH GLO-bo vay-TAY-ree C (When from primeval mass) C (excerpt from -

Adriana Lecouvreur
FRANCESCO CILEA adriana lecouvreur conductor Opera in four acts Gianandrea Noseda Libretto by Arturo Colautti, based production Sir David McVicar on the play Adrienne Lecouvreur by Eugène Scribe and Ernest Legouvé set designer Charles Edwards Saturday, January 26, 2019 costume designer 8:00–11:20 PM Brigitte Reiffenstuel lighting designer New Production Adam Silverman Last time this season choreographer Andrew George The production of Adriana Lecouvreur associate director Justin Way was made possible by a generous gift from The Sybil B. Harrington Endowment Fund Co-Production of the Royal Opera House, Covent Garden, London; Gran Teatre del Liceu, Barcelona; Wiener Staatsoper; San Francisco Opera; and general manager L’Opéra National de Paris Peter Gelb jeanette lerman-neubauer This production was first seen at the Royal Opera music director Yannick Nézet-Séguin House, London, on November 18, 2010. 2018–19 SEASON The 81st Metropolitan Opera performance of FRANCESCO CILEA’S adriana lecouvreur conductor Gianandrea Noseda in order of vocal appearance mlle. jouvenot Sarah Joy Miller michonnet Ambrogio Maestri poisson Tony Stevenson* mlle. dangeville Samantha Hankey quinault Patrick Carfizzi the abbé of cha zeuil Carlo Bosi the prince of bouillon Maurizio Muraro adriana lecouvreur Jennifer Rowley Saturday, January 26, 2019, 8:00–11:20PM maurizio Piotr Beczała the princess of bouillon Anita Rachvelishvili major- domo Christian Rozakis chambermaid Anne Dyas mlle. duclos Snezhana Chernova pantalone Bill Corry judgment of paris ballet paris Kfir -

Comune Di Milano Archivio Delle Civiche Raccolte Storiche Museo Del
COMUNE DI MILANO ARCHIVIO DELLE CIVICHE RACCOLTE STORICHE MUSEO DEL RISORGIMENTO ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE CASTELLINI INVENTARIO DEI FONDI «RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA FONDAZIONE CASTELLINI» «ARCHIVIO PROPRIO DELLA FONDAZIONE CASTELLINI» «CARTE ROBERTO FORGES DAVANZATI» «ARTURO COLAUTTI» «GIOVANNI DE SIMONI» «GUALTIERO CASTELLINI» AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016 Archivio delle Civiche raccolte storiche del Comune di Milano – Museo del Risorgimento Archivio della Fondazione Castellini Sommario “Valorizzazione del patrimonio documentale di storia contemporanea” - Progetto pluriennale (IV fase, 2016) – Responsabilità ................................................................... 2 Premessa ........................................................................................................................... 3 Sigle e abbreviazioni convenzionali ................................................................................. 9 Fondazione Gualtiero Castellini profilo storico ............................................................. 10 Fondazione Gualtiero Castellini complesso di fondi ...................................................... 11 fondo Raccolta documentaria della Fondazione Gualtiero Castellini ............................ 12 fondo Archivio proprio della Fondazione Gualtiero Castellini ...................................... 64 Roberto Forges Davanzati profilo biografico ................................................................. 72 Carte Roberto Forges Davanzati fondo ......................................................................... -

Adriana Lecouvreur
LE BUGUE SAMEDI 12 JANVIER 18H25 LELELELE BUGUE BUGUEBUGUEBUGUE Salle Eugène Le Roy Réservation : Maison de la Presse Le Bugue 05 53 07 22 83 Francesco Cilea ADRIANA LECOUVREUR Rivals to life and on stage, the famous tragedian of the Comédie-Française Adrienne Lecouvreur and the Princess de Bouillon are both in love with the officer Maurice de Saxe. In the backstage of the theater, the jealousy of one will lead to the death of the other, poisoned by a bouquet she thought she received from her lover. The grand trio Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili and Piotr Beczała engage in love jealousies in Sir David McVicar's new production. From the backstage of the famous French theater to sumptuous ball residencies, Parisian life takes possession of the Met's stage. Soprano Anna Netrebko joins the ranks of Renata Tebaldi, Montserrat Caballé, and Renata Scotto, taking on—for the first time at the Met—the title role of the real-life French actress who dazzled 18th-century audiences with her on-and offstage passion. The soprano is joined by tenor Piotr Beczała as Adriana's lover, Maurizio. The principal cast also features mezzo- soprano Anita Rachvelishvili and baritone Ambrogio Maestri. Gianandrea Noseda conducts. Sir David McVicar's staging, which sets the action in a working replica of a Baroque theater, premiered at the Royal Opera House in London, where the Guardian praised the "elegant production, sumptuously designed ... The spectacle guarantees a good night out." Conductor Adriana The Principessa Gianandrea Anna Anita Noseda Netrebko Rachvelishvili soprano Mezzo-soprano Maurizio The abbé Prince de Piotr Carlo Bouillon Beczala Bosi Maurizio Muraro tenor tenor basse DATE : Saturday January 12 2019 Heure : 6.25pm Opera in 4 acts by Francesco Cilea ADRIANA LECOUVREUR World Premiere: Teatro Lirico, Milan, 1902. -

A Cura Di Domenico D
Questo catalogo è pubblicato con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Mercogliano, che qui si ringrazia nella persona del sindaco Massimiliano Carullo Copyright © Monkey adv, 2018 Via Circumvallazione, 79 83100 Avellino Distribuzione MEPHITE srl ISBN: 978-88-6320-190-1 Printed in Italy Tutti i diritti riservati PRESENTAZIONE Massimiliano Carullo* Volentieri l’Amministrazione comunale di Mercogliano ha aderito alla richiesta degli amici della Biblioteca di Montevergine di offrire un contributo alla stampa di questo catalogo. L’importanza della pubblicazione sarà sicuramente ben presente agli addetti ai lavori; tuttavia, non si può non riconoscere a questo volume - nel quale sono raccolti gli spartiti musicali appartenuti al maestro Luigi Imbimbo - un valore di più ampie proporzioni, ben riconoscibile anche da chi del settore non è. Questa Amministrazione comunale e chi scrive personalmente sono da sempre vicini alla Congre- gazione monastica verginiana e alla Biblioteca di Montevergine, non solo per onorare doverosa- mente rapporti ormai ampiamente consolidati nel corso degli anni, ma anche per riaffermare la con- creta e convinta volontà di offrire il proprio sostegno – nelle forme e nei modi che bilanci sempre più esigui possono consentire – alle innumerevoli attività che sul territorio danno lustro all’intera comunità. Una comunità che è tanto più coesa e interprete di valori positivi quanto più riesce ad individuare dei punti di riferimento concreti; uno di questi è stato sicuramente nel corso degli ultimi anni “il” direttore della Biblioteca di Montevergine, padre Placido Tropeano, al quale ci legano sentimenti di affetto e di riconoscenza, non solo personali, che nel tempo hanno trovato conferma anche in contesti istituzionali (penso ad esempio alla cittadinanza onoraria che questo Comune gli attribuì). -
Represija Nad Pripadniki Nemške Manjšine Na Hrvaškem, V Bosni in Hercegovini Ter Vojvodini, 1944–1948
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO REPRESIJA MED 2. SVETOVNO VOJNO IN V POVOJNEM OBDOBJU V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DRŽAVAH Uredila: Dr. Nevenka Troha Dr. Zdenko Čepič Letnik LIII Ljubljana 2013 Številka 1 Prispevki za novejšo zgodovino LIII - 1/2013 Contributions to the Contemporary History Contributions a l'histoire contemporaine Beiträge zur Zeitgeschichte UDC 94(497.4)"18/19" UDK ISSN 0353-0329 Uredniški odbor: dr. Zdenko Čepič (odgovorni urednik), dr. Damijan Guštin (glavni urednik), dr. Aleksej Kalc, dr. Boris Mlakar, dr. Avguštin Malle, dr. Dušan Nećak, dr. Janko Prunk, dr. Franc Rozman, dr. Mario Strecha, dr. Mojca Šorn Redakcija zaključena 3. 6. 2013 Za znanstveno vsebino tekstov in točnost podatkov odgovarjajo avtorji. Lektoriranje: Bojana Samarin, prof. Prevodi: Borut Praper – angleščina Bibliografska obdelava: Igor Zemljič Izdaja: Inštitut za novejšo zgodovino Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija tel. (386) 01 200 31 20, fax (386) 01 200 31 60 e-mail (odgovorni urednik) [email protected] Številka vpisa v razvid medijev: 720 Založil: Inštitut za novejšo zgodovino s sofinanciranjem Javne agencije za knjigo Republike Slovenije Računalniški prelom: MEDIT d.o.o., Notranje Gorice Tisk: Fotolito Dolenc d.o.o. Cena: 15,00 EUR Zamenjave (Exchange, Austausch): Inštitut za novejšo zgodovino Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija Prispevki za novejšo zgodovino so indeksirani v bazi Historical Abstract in ERIH – European Reference Index for the Humanities Prispevki za novejšo -
Emanuel Stelzer
Emanuel Stelzer Shakespeare Among Italian Criminologists and Psychiatrists, 1870s-1920s Σ Skenè Texts • 4 Skenè Texts • 4 Emanuel Stelzer Shakespeare Among Italian Criminologists and Psychiatrists, 1870s-1920s Σ S K E N È Theatre and Drama Studies Executive Editor Guido Avezzù. General Editors Guido Avezzù, Silvia Bigliazzi. Editorial Board Simona Brunetti, Nicola Pasqualicchio, Susan Payne, Gherardo Ugolini. Managing Editors Bianca Del Villano, Savina Stevanato. Assistant Managing Valentina Adami, Emanuel Stelzer, Roberta Zanoni. Editors Communication Chiara Battisti, Sidia Fiorato. Editorial Staff Petra Bjelica, Francesco Dall’Olio, Marco Duranti, Carina Louise Fernandes, Leonardo Mancini, Antonietta Provenza, Angelica Vedelago. Typesetter Lorenza Baglieri. Advisory Board Anna Maria Belardinelli, Anton Bierl, Enoch Brater, Jean-Christophe Cavallin, Richard Allen Cave, Rosy Colombo, Claudia Corti, Marco De Marinis, Tobias Döring, Pavel Drábek, Paul Edmondson, Keir Douglas Elam, Ewan Fernie, Patrick Finglass, Enrico Giaccherini, Mark Griffith, Daniela Guardamagna, Stephen Halliwell, Robert Henke, Pierre Judet de la Combe, Eric Nicholson, Guido Paduano, Franco Perrelli, Didier Plassard, Donna Shalev, Susanne Wofford. Supplement to SKENÈ. Journal of Theatre and Drama Studies Copyright © 2021 S K E N È All rights reserved. ISBN 979-12-200-6186-5 ISSN 2464-9295 No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission from the publisher. SKENÈ Theatre and Drama Studies https://textsandstudies.skeneproject.it/index.php/TS [email protected] Dir. Resp. (aut. Trib. di Verona): Guido Avezzù P.O. Box 149 c/o Mail Boxes Etc. (MBE150) – Viale Col. Galliano, 51, 37138 Contents Acknowledgements 7 Introduction 9 A Note on the Texts and Their Translation 41 Texts: 1. -

Ricerche Sociali
CDU 3/32+008(497.4/.5)(=50)"18/19" ISSN 0353-474X CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO RICERCHE SOCIALI N.16 UNIONE ITALIANA- FIUME UNIVERSITÀ POPOLARE - TRIESTE ROVIGNO 2009 RICERCHE SOCIALI- Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 16, pp. 1-175, Rovigno, 2009 CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO UNIONE ITALIANA- FIUME UNIVERSITÀ POPOLARE - TRIESTE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE Piazza Matteotti 13- Rovigno (Croazia), tel. +385(052)811-133 - fax (052)815-786 inter.net: www.crsrv.org e-mail: [email protected] COMITATO DI REDAZIONE EGIDIO lVETIC LUCIANO MONICA ALESSIO RADOSSI GIOVANNI RADOSSI NICOLò SroNzA FuLvio SuRAN REDATTORE SILVANO ZILLI DIRETTORE RESPONSABILE GIOVANNI RADOSSI Recensore: FuLVIO SuRAN Coordinatore editoriale: FABRIZIO SOMMA © 2009 Tutti i dirilli d'autore e grafici appartengono al Centro di ricerche storiche di Rovigno, nessun escluso. Stampato con il contributo dell'Università Popolare di Trieste presso la Tipografia B.B. Artigrafiche s. n.e. INDICE, Ricerche Sociali, 16, 2009, pp. 1-175 5 INDICE FRANCESCO CIANCI, La tutela delle minoranze attraverso gli strumenti della rappresentanza: un'analisi giuridica comparata e questioni teoriche (ancora) aperte ............ ............... ... 7 MASSIMILIANO ROVATI, La minoranza italiana in !stria e l'ingresso della Slovenia in Europa: situazione, scenari futuri ed opportunità . ...... ..................................... ........................ 43 MARKO PALIAGA- LENKO URAVIé, Approccio integrale allo sviluppo del brand e allo sviluppo economico delle città, in condizioni di concorrenzialità globale ............................................... ...... ............... ... 71 ELIANA MoscARDA MIRKOVIé, Quattro identità a confronto. L'esperienza letteraria di Marisa Madieri, N elida Milani-Kruljac, Anna Maria Mori e Graziella Fiorentin .................................... 85 STEFANO PONTIGGIA, Vivere da superstiti. L'esodo istriano come esperienza del presente nel mondo associativo triestino ...................................................................................