Storia Di Roma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The First Illyrian War: a Study in Roman Imperialism
The First Illyrian War: A Study in Roman Imperialism Catherine A. McPherson Department of History and Classical Studies McGill University, Montreal February, 2012 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts ©Catherine A. McPherson, 2012. Table of Contents Abstract ……………………………………………….……………............2 Abrégé……………………………………...………….……………………3 Acknowledgements………………………………….……………………...4 Introduction…………………………………………………………………5 Chapter One Sources and Approaches………………………………….………………...9 Chapter Two Illyria and the Illyrians ……………………………………………………25 Chapter Three North-Western Greece in the Later Third Century………………………..41 Chapter Four Rome and the Outbreak of War…………………………………..……….51 Chapter Five The Conclusion of the First Illyrian War……………….…………………77 Conclusion …………………………………………………...…….……102 Bibliography……………………………………………………………..104 2 Abstract This paper presents a detailed case study in early Roman imperialism in the Greek East: the First Illyrian War (229/8 B.C.), Rome’s first military engagement across the Adriatic. It places Roman decision-making and action within its proper context by emphasizing the role that Greek polities and Illyrian tribes played in both the outbreak and conclusion of the war. It argues that the primary motivation behind the Roman decision to declare war against the Ardiaei in 229 was to secure the very profitable trade routes linking Brundisium to the eastern shore of the Adriatic. It was in fact the failure of the major Greek powers to limit Ardiaean piracy that led directly to Roman intervention. In the earliest phase of trans-Adriatic engagement Rome was essentially uninterested in expansion or establishing a formal hegemony in the Greek East and maintained only very loose ties to the polities of the eastern Adriatic coast. -

Bibliography
Bibliography Many books were read and researched in the compilation of Binford, L. R, 1983, Working at Archaeology. Academic Press, The Encyclopedic Dictionary of Archaeology: New York. Binford, L. R, and Binford, S. R (eds.), 1968, New Perspectives in American Museum of Natural History, 1993, The First Humans. Archaeology. Aldine, Chicago. HarperSanFrancisco, San Francisco. Braidwood, R 1.,1960, Archaeologists and What They Do. Franklin American Museum of Natural History, 1993, People of the Stone Watts, New York. Age. HarperSanFrancisco, San Francisco. Branigan, Keith (ed.), 1982, The Atlas ofArchaeology. St. Martin's, American Museum of Natural History, 1994, New World and Pacific New York. Civilizations. HarperSanFrancisco, San Francisco. Bray, w., and Tump, D., 1972, Penguin Dictionary ofArchaeology. American Museum of Natural History, 1994, Old World Civiliza Penguin, New York. tions. HarperSanFrancisco, San Francisco. Brennan, L., 1973, Beginner's Guide to Archaeology. Stackpole Ashmore, w., and Sharer, R. J., 1988, Discovering Our Past: A Brief Books, Harrisburg, PA. Introduction to Archaeology. Mayfield, Mountain View, CA. Broderick, M., and Morton, A. A., 1924, A Concise Dictionary of Atkinson, R J. C., 1985, Field Archaeology, 2d ed. Hyperion, New Egyptian Archaeology. Ares Publishers, Chicago. York. Brothwell, D., 1963, Digging Up Bones: The Excavation, Treatment Bacon, E. (ed.), 1976, The Great Archaeologists. Bobbs-Merrill, and Study ofHuman Skeletal Remains. British Museum, London. New York. Brothwell, D., and Higgs, E. (eds.), 1969, Science in Archaeology, Bahn, P., 1993, Collins Dictionary of Archaeology. ABC-CLIO, 2d ed. Thames and Hudson, London. Santa Barbara, CA. Budge, E. A. Wallis, 1929, The Rosetta Stone. Dover, New York. Bahn, P. -

Còpia Digital
BrniceDonl + LUIS .rnwo senAvi inapileptori. enimoq -,ávE-1 ADMINISTRACIÓN I MAMÓ/ ARCO DIIL TEATRO, Al 123 _ 11111 1(8111STA MISPADO-15 CIIICADA 1:1 PRECIO ENTODA ESPAIPA: LOS PRECIOS UN NIPIERD, 25CÉNT.—UN ANO, 13 PTAS. TODAS LAS szk EP CUBA, PUERTO-RICO, FILIPINAS EUROPA, ASIA? ÁFRICA.-1111 ANO, 25 FRS. Y NACIONES DE AMÉRICA, *ameres, 5( :asa .A*0 u eit va °Raes, las Fiada he anona Coseassorisode. 26 Julio In, N-Cunero 247 El tomo empieza en I.° de Enero y termina en 31 de Diciembre SUMARIO: nerPO: EA,Aza Mameso, por D. Federico Ralsota.—Cartasa Dalia por D. Adolfo Fernández Ferranda.—Uns escena entre los amas florei, —Vas, (esselesión), porD. 7. C U.De.—Las por . de A. dades.—Nuatro• grabados.—Enearoación, poesia por OR Dolores Correa Zapata.—IDies posa, por Isan.—Lardeta. pi:isla por D. Vicente Risa ?al,se R.—Viaje por Túnez (ssaiFaasiddriA Pa F. Capo,' R. Sal...s.—Las .5 el sitio de Granada (osas.. Aits),por lord Ly1.1. de laAsnas. GRABADOS: Catedral de Jaca Silla aleroble trsulpido.—Caricaturas.—El can, de Constad á SaoPetersburgo —Une, hel Llega&áS.s.—Puente sobrela ublellai Espana y Marruecos. 1-119 RODEEMOS en el anterior articulo d." estudiar detenidamente lo que habla hecho y lo que deberle hacer Espana en Marruecos. Para que se vea la prisa 'que todas las naciones euro , peas se dan en el reparto del África, como temiendo llegar tarde al festin, léanse los datos aducidos por Sir Rawson Raw son en la Real Sociedad de Geografia Londonense. Según lasafirrnacionesdeéste, Inglaterra posee en África 2,017 millas, Francia 2,339, Portugal I,96o, Espana 35, , Alemania 270 é Italia 40e total 6,661; que dando libres para los indigenas 10,057 millas, espacio que irá disminuyendo cada 5ez más. -
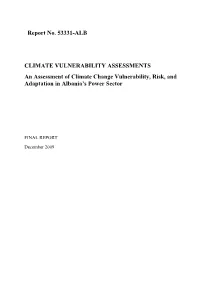
An Assessment of Climate Change Vulnerability, Risk, and Adaptation in Albania's Energy Sector
Report No. 53331-ALB CLIMATE VULNERABILITY ASSESSMENTS An Assessment of Climate Change Vulnerability, Risk, and Adaptation in Albania’s Power Sector FINAL REPORT December 2009 ESMAP MISSION The Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) is a global knowledge and technical assistance trust fund program administered by the World Bank and assists low- and middle-income countries to increase know-how and institutional capacity to achieve environmentally sustainable energy solutions for poverty reduction and economic growth. ESMAP COPYRIGHT DISCLAIMER Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) reports are published to communicate the results of ESMAP‘s work to the development community with the least possible delay. Some sources cited in this paper may be informal documents that are not readily available. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this report are entirely those of the author(s) and should not be attributed in any manner to the World Bank, or its affiliated organizations, or to members of its board of executive directors for the countries they represent, or to ESMAP. The World Bank and ESMAP do not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of their use. The boundaries, colors, denominations, other information shown on any map in this volume do not imply on the part of the World Bank Group any judgment on the legal status of any territory or the endorsement of acceptance of such boundaries. Vice President: Philippe H Le Houerou Country Director: Jane Armitage Sector Director: Peter Thomson Sector Manager: Ranjit Lamech Task Team Leader: Jane Ebinger i TABLE OF CONTENTS SYNOPSIS vi ACKNOWLEDGMENTS vii ACRONYMS viii EXECUTIVE SUMMARY ix Albania‘s Energy Sector and Climate Change ix Recommendations for Building Climate Resilience of the Energy Sector xi PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE xv Sektori i energjisë në Shqipëri dhe ndryshimet klimatike xv Rekomandimet për krijimin e elasticitetit klimatik të sektorit energjitik xvii 1. -

The Coinage of Apollonia and Dyrrhachium 31 3.1 Introduction 31 3.2 Brief Discussion of the Coin Types 31
Ross, Scott (2013) An assessment and up-to-date catalogue of the coins of Apollonia and Dyrrhachium between the 5th and 1st centuries B.C. MPhil(R) thesis. http://theses.gla.ac.uk/4335/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Scott Ross MA (Hons) 0706244 “An assessment and up-to-date catalogue of the coins of Apollonia and Dyrrhachium between the 5th and 1st centuries B.C.” Submitted for the honour of Master of Philosophy (by research) 2012 Classics, School of Humanities, University of Glasgow 1 Acknowledgments 3 Introduction 4 Chapter 1: Methodology 7 Chapter 2: The History of Illyria 12 2.1 Introduction 12 2.2 Physical geography 13 2.3 Political structure of Illyria 15 2.4 Conflict and turmoil 17 2.5 Piracy and Roman intervention 20 2.6 Conclusions 29 Chapter 3: The Coinage of Apollonia and Dyrrhachium 31 3.1 Introduction 31 3.2 Brief discussion of the coin types 31 Chapter 4: Weight standard and circulation 35 Chapter 5: Iconography of Silver Issues 41 5.1 Corcyrean Staters 41 5.2 Corinthian Staters 44 5.3 Drachms 45 5.4 Apollo Denarius 48 5.5 Conclusions 49 Chapter 6: Conclusion 50 Catalogue 52 Monograms 236 Bibliography 238 List of Images 241 2 Acknowledgements This is to say thanks to: Dr. -

Ini13111iuni LI!!
II UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGIA DEPARTAMENTO DE FILOLOGíA LATINA LA CONCEPCION DE LA HISTORIA EN AURELIO VICTOR TOMO 1 LI!!INI9841013111IUni UNIVERSIDAD COMPLUTENSE TESIS DOCTORAL REALIZADA POR: AVELINA GONZÁLEZ CONZÁLEZ BAJO LA DIRECCION DEL Dr. ENRIQUE OTON SOBRINO MADRID, 1997 INDICE Pág - AGRADECIMIENTOS 1 - PROLOGO II - CAP, 1.-LOS ACCIDENTES GEOGRAFICOS EN AUR .VICT 1 Introducción 1 - Los Estrechos 5 • Los Golfos 6 • Las Islas 6 • Los Lagos 14 • Las Lagunas 16 - Los Mares 17 - Los Montes y Colinas 18 • Las Penínsulas 31 • Los Puentes 35 • Los Puertos 36 • Los nos 37 • Las Rocas 48 - Notas Accidentes Geográficos 48 - CAP, II - - LOS BARRIOS. BOSOUES. CAMPOS. FAMILIAS .JUE-ET1 w449 302 m482 302 lSBT 005. LEYES. PLAZAS. PUERTAS. TEMPLOS. Y VíAS EN Ami .VICT .51 • Introducción 51 • Los Barrios 53 - Notas Barrios 55 - Los Bosques 55 - Los Campos 56 - Notas Campos 62 • Las Familias 65 Los Juegos 69 . • Las Leyes 70 • Las Plazas 73 • Las Puertas 73 • Notas Puertas 74 • Los Templos 74 • Las Vias 75 • Notas Vias 78 - CAP,III.— LAS CIUDADES EN AURELIO VICTOR .79 • Introducción 82 • Notas Ciudades 187 - CAP,IV.- LAS DIOSAS.ILOS DIOSES Y LOS HEROES EN AUR.VICT 194 • Introducción 194 • Las Diosas 196 • Notas Diosas 203 • Los Dioses 206 • Notas Dioses 223 • Los Héroes 225 • Notas Héroes 238 CAP, y - LOS EMPERADORES EN AIIM - VTCT 240 • Introducción 240 • Los Emperadores 243 • Notas Emperadores 356 . AGRADECIMIENTOS Resulta ineludible, en primer lugar, mostrar mi más profundo agradecimiento al Dr.Enrique Otón Sobrino, director de esta tésis. Su dedicación, disponibilidad, abnegación y buen hacer, han hecho posible compatibilizar mi trabajo de ama de casa, madre de cuatro hijos, y profesional de la enseñanza, con la realización de esta tésis. -

The Authenticity of the Book of Judges, by Bill Cooper
The Authenticity of the Book of Judges Bill Cooper Copyright 2015@Dr Wm R Cooper For Ross Rosevear in gratitude for the many years of industry and expertise that he has poured into managing and building up both the CSM and its Genesis Expo in Portsmouth Thank you, Ross! About the Author Bill Cooper is a Vice President and Trustee of the Creation Science Movement in England. He also serves as Adjunct Professor of Providential History and Apologetics on the Master Faculty at the Institute for Creation Research School of Biblical Apologetics (Dallas, Texas). He is the author of After the Flood (1995); Paley’s Watchmaker (1997); William Tyndale’s 1426 ew Testament (old spelling ed. British Library. 2000); The Wycliffe ew Testament of 1388 (British Library. 2002); The Authenticity of the Book of Genesis (CSM. 2012); The Authenticity of the Book of Daniel (2012); The Authenticity of the Book of Jonah (2012); The Authenticity of the Book of Esther (2012); The Chronicle of the Early Britons (2012); Old Light on the Roman Church (2012); The Authenticity of the ew Testament Part 1: The Gospels (2013); The Authenticity of the ew Testament Part 2: Acts, the Epistles and Revelation (2014) ; After the Flood 2 nd edition (2014) ; Foxe’s Actes & Monuments 1463 (2014) ; Paley’s Historicity of St Paul (Horae Paulinae 1790 ) (2014) ; The Wycliffe ew Testament (1388) original spelling (2014) ; and The Authenticity of the Book of Joshua (2015). He has authored numerous technical articles on Creationism, Palaeoanthropology, Bible Apologetics, the Reformation and the History of the English Bible. -

National Myths in Interdependence
National Myths in Interdependence: The Narratives of the Ancient Past among Macedonians and Albanians in the Republic of Macedonia after 1991 By Matvey Lomonosov Submitted to Central European University Nationalism Studies Program In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts CEU eTD Collection Advisor: Professor Maria Kovács Budapest, Hungary 2012 Abstract The scholarship on national mythology primarily focuses on the construction of historical narratives within separate “nations,” and oftentimes presents the particular national ist elites as single authors and undisputable controllers of mythological versions of the past. However, the authorship and authority of the dominant national ist elites in designing particular narratives of the communal history is limited. The national past, at least in non- totalitarian societies, is widely negotiated, and its interpretation is always heteroglot . The particular narratives that come out of the dominant elites’ “think-tanks” get into a polyphonic discursive milieu discussing the past. Thus they become addressed to alternative narratives, agree with them, deny them or reinterpret them. The existence of those “other” narratives as well as the others’ authorship constitutes a specific factor in shaping mythopoeic activities of dominant political and intellectual national elites. Then, achieving personal or “national” goals by nationalists usually means doing so at the expense or in relations to the others. If in this confrontation the rivals use historical myths, the evolution of the later will depend on mutual responses. Thus national historical myths are constructed in dialogue, contain voices of the others, and have “other” “authors” from within and from without the nation in addition to “own” dominant national ist elite. -

AJA 1 (1885) 71-103 (AIA Website Colors).PMD
AJA ONLINE PUBLICATIONS News Department: A Sketch of the Chief Results of Archaeological Investigation in 1884 THOMAS W. LUDLOW It is the design of the Editors to give in this dancing or playing on the double flute, vari- department a record, as complete as pos- ous masks, and hares, sheep, dolphins, and sible, of the advance of Archæology through- other animals. The same excavation brought out the field which the Journal seeks to cover. For this first number it was hoped that a suc- to light a plate of silver ornamented with cinct account might be prepared of the whole flowers. All these objects have been taken to archæological gain secured during the year the Museum of Nikosia.—Revue Archéolo- 1884. It has not been found possible to fully gique, II, 1884, p. 92. realize this hope, and the following sketch is defective in various departments. The indul- Arabia gence of the reader is therefore requested; and in succeeding numbers of the Journal ev- M. Huber, who was sent upon a mission ery effort will be made to keep pace with the to Arabia by the Académie des Inscriptions, honorable accomplishment of archæological has been assassinated at Kasr Alliah, near students and excavators in both hemi- Tafna. M. Huber was a scholar possessing spheres. zeal and sagacity. He had already sent home ASIA valuable squeezes from inscriptions in the Valley of Tombs, and it was confidently ex- Cyprus pected that his journey would have results of Mr. Max Ohnefalsch-Richter, who has for importance. The French Government will some years conducted the archæological in- make an effort to recover the unfortunate vestigations carried on in Cyprus by the Brit- gentleman’s papers and effects.— Revue ish Government, has explored the ruins of a Archéologique, II, 1884, p. -

Interventions by the Roman Republic in Illyria 230 – 167 BC
Interventions by the Roman Republic in Illyria 230 – 167 BC Submitted by Jack James Willoughby, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Classics, September 2018. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. (Signature) ……………………………………………………………………………… Page 1 of 181 Abstract This thesis aims to determine how and why Rome undertook a series of interventions in Illyria during the period of 230 – 167 BC. The thesis is based on a detailed examination and consideration of the ancient written sources and the subsequent historiography on the subject. The Roman interventions in Illyria during this period have traditionally been treated as a component of wider studies of Roman expansion, although Rome’s involvement in Illyria has recently been examined by Dzino in his 2010 work Illyricum in Roman Politics 229BC-AD68. This work examined the development and integration of Illyricum in Roman political discourse, in which the Roman interventions were a smaller component in the broader study. A study of the Roman interventions in Illyria during the period of 230 – 167 BC has never previously been treated on this scale, nor effectively with a synthesis of the various approaches and pieces of evidence that are now available. -

Marta Daniel Institute of Archaeology, University of Warsaw [email protected]
Światowit • LVII • 2018 Marta Daniel Institute of Archaeology, University of Warsaw [email protected] FINDS OF ILLYRIAN COIN HOARDS FROM THE TERRITORIES OF GREEK ILLYRIA. AN AttEMPT AT RECONSTRUCTING THE CIRCULATION OF COINAGE BASED ON THE RANGE OF PARTICULAR EMISSIONS1 Abstract The aim of this paper is to reconstruct the circu- a cumulative form, as well as sorted by date and place lation of coinage through an analysis of finds of hoards of issue. Distribution of finds in relation to terrain and of ‘Illyrian coins’ from the territory of Greek Illyria in settlement patterns was studied in order to locate con- the period from the 4th to the 1st century BC. To this centrations of coins of given centres in different periods. end, hoards from modern-day Albania, Bosnia and Additionally, important observations concerned places Herzegovina, Croatia, Montenegro, Kosovo, and Serbia, in which coin hoards are absent or very scarce. The that is the maximum territorial extent of the so-called catalogue was also useful for tracing patterns in the ‘Illyrian state’, were compiled in a catalogue. This cat- composition of the hoards – those consisting of coins alogue of hoards of Illyrian coins served as a basis for most commonly minted together and those dominated producing dedicated maps which present data in by coins of differing provenance. Keywords: Illyria, Greek-Illyrian coinage, coin hoards, circulation of coinage, Balkan Peninsula The term ‘Illyrians’ refers to tribes that inhabited Illyrians did not form a ‘state’ with an established terri- the Balkan Peninsula from the 4th century BC onwards. tory and clearly-defined borders.4 The name ‘Illyria’ comes from the Greek language and is Numismatists conducting research on the ‘Illyrian of a mythological origin.2 Its interpretation is a subject coinage’5 lack sufficient archaeological data in the form of dispute among modern historians, who propose of coin finds. -

Why Illyrian King Agron and Queen Teuta Came to a Bad End and Who Was Ballaios?
From the history of ancient Rhizon/Risinium: Why Illyrian king Agron and queen Teuta came to a bad end and who was Ballaios? Piotr Dyczek*1* Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw In 2001 the Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe of the University of Warsaw opened a new archaeological excavation project in the Republic of Montenegro. The site lies in the territory of modern Risan, on the coast of the northern branch of Kotor Bay [Fig. 1]. The name of the town appears in different written sources in variants corresponding to the period: Rhizon, Rhizinium, Risinium, but always echo- ing in the modern name of Risan. Consequently, the identification of the location did not raise any doubts already in the 19th century, but the name itself is of unclear origin. It may have been derived either from the Greek rhizon, that is, root or from rhizotom, a grass or to be more precise, a medicinal herb which still grows in proliferation around the locality (cf. Ivčević 1999: 101, Dyczek 2008: 155–156). Arthur Evans was the first to explore the area in the 1870s (Evans 1884: 42ff.) and he concluded that the plateau Fig. 1. General location of Risan * This paper was prepared with support from the Lanckoroński Foundation. Classica Orientalia 157 Piotr Dyczek situated at the foot of the Građine hill which rises to an altitude of 207 m, was the site of intensive settlement in antiquity. Risan is a small locality today, but it was once the most important center in the whole bay and a significant player in the history of Illyria and its relations with the Roman Republic.