Per La Storia Degli Etruschi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Umbria from the Iron Age to the Augustan Era
UMBRIA FROM THE IRON AGE TO THE AUGUSTAN ERA PhD Guy Jolyon Bradley University College London BieC ILONOIK.] ProQuest Number: 10055445 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10055445 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis compares Umbria before and after the Roman conquest in order to assess the impact of the imposition of Roman control over this area of central Italy. There are four sections specifically on Umbria and two more general chapters of introduction and conclusion. The introductory chapter examines the most important issues for the history of the Italian regions in this period and the extent to which they are relevant to Umbria, given the type of evidence that survives. The chapter focuses on the concept of state formation, and the information about it provided by evidence for urbanisation, coinage, and the creation of treaties. The second chapter looks at the archaeological and other available evidence for the history of Umbria before the Roman conquest, and maps the beginnings of the formation of the state through the growth in social complexity, urbanisation and the emergence of cult places. -

A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite? Jodi Magness University of North Carolina at Chapel Hill
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 8 Article 4 2001 A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite? Jodi Magness University of North Carolina at Chapel Hill Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Magness, Jodi (2001) "A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite?," Etruscan Studies: Vol. 8 , Article 4. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol8/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. A Near EasTern EThnic ElemenT Among The ETruscan EliTe? by Jodi Magness INTRODUCTION:THEPROBLEMOFETRUSCANORIGINS 1 “Virtually all archaeologists now agree that the evidence is overwhelmingly in favour of the “indigenous” theory of Etruscan origins: the development of Etruscan culture has to be understood within an evolutionary sequence of social elaboration in Etruria.” 2 “The archaeological evidence now available shows no sign of any invasion, migra- Tion, or colonisaTion in The eighTh cenTury... The formaTion of ETruscan civilisaTion occurred in ITaly by a gradual process, The final sTages of which can be documenTed in The archaeo- logical record from The ninTh To The sevenTh cenTuries BC... For This reason The problem of ETruscan origins is nowadays (righTly) relegaTed To a fooTnoTe in scholarly accounTs.” 3 he origins of the Etruscans have been the subject of debate since classical antiqui- Tty. There have traditionally been three schools of thought (or “models” or “the- ories”) regarding Etruscan origins, based on a combination of textual, archaeo- logical, and linguistic evidence.4 According to the first school of thought, the Etruscans (or Tyrrhenians = Tyrsenoi, Tyrrhenoi) originated in the eastern Mediterranean. -

Social Mobility in Etruria Gérard Capdeville
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 9 Article 15 2002 Social Mobility in Etruria Gérard Capdeville Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Capdeville, Gérard (2002) "Social Mobility in Etruria," Etruscan Studies: Vol. 9 , Article 15. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol9/iss1/15 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. SociaL MobiLity iN Etruria by Gérard Capdeville H(astia) . Ecnatnei . Atiuce . lautnic ([ CIE , 3088 =] TLE , 550 = Cl 1.1568) y “social Mobility” I MeaN here a chaNge of social class, which is Not easy to dis - cerN iN Etruria because we do Not have Much geNeral iNforMatioN oN the struc - Bture of EtruscaN society. The Most iMportaNt chaNge, aNd the Most obvious, is the traNsitioN froM servile to free status, heNce the iMportaNce of freedMeN for our subject. The word for “freedMaN” is well kNowN, as we have circa 175 iNscriptioNs: it is lautuni, lautni (rec. lavtni ), feM. lautni a, lautnita (rec. lavtnita ). Its MeaNiNg is attested by two biliNgual Etrusco-LatiN iNscriptioNs ( CIE , 1288 ClusiuM; 3692 Perugia), which testify to the equivaleNce of lautNi to the LatiN libertus. EquivaleNce does Not MeaN ideNtity of status, especially duriNg the iNdepeNdeNt cities period. At least two questioNs arise. What is the relatioNship betweeN the lautni aNd his forMer Master? What is the positioN of the lautni as regards citizeNship? The oNoMastic, for which we have a very rich corpus of epitaphs, provides us with part of the aNswer. -

An Examination of Cavità 254 in Orvieto, Italy, and Its Primary Usage As an Etruscan Quarry
An Examination of Cavità 254 in Orvieto, Italy, and its Primary Usage as an Etruscan Quarry Master’s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Graduate Program in Ancient Greek and Roman Studies Professor Ann Olga Koloski-Ostrow, Advisor In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Ancient Greek and Roman Studies by Kelsey Latsha May 2018 Copyright by Kelsey Latsha © 2018 ACKNOWLEDGEMENTS This Project is the culmination of years of work on the excavation of Cavità 254 under the direction of Professor David George and Claudio Bizzarri. I would like to thank Professor George for the opportunity to work on the site of Cavità 254 and for introducing me to the world of the Etruscans during my time at Saint Anselm College. I am forever grateful for Professor George’s mentorship that motivated me to pursue a graduate degree in Ancient Greek and Roman Studies at Brandeis University. I would also like to thank Doctor Paolo Binaco a fantastic teacher, friend, and archaeologist. Paolo has guided me in the right direction, while simultaneously sparking excitement in asking new questions about our unique site. Thank you, Paolo, for the unforgettable adventures to see Orvieto’s “pyramids” and for teaching me everything Etruscan. This thesis would not be possible without the immense support of the Department of Classical Studies at Brandeis. I especially would like to thank my Advisor Professor Ann Olga Koloski-Ostrow for her enthusiastic support of my project from its early beginnings and always pushing me to better my writing and research. -

Ancient Roman Civilization
ANCIENT ROMAN CIVILIZATION HANDOUT PACKAGE FALL 2009 HISTORY 4322/6322 Dr. Peter J. Brand 1 MOST ANCIENT ROME: ORIGINS AND BEGINNINGS Legend of Trojan origins: dates back at least to 5th century BCE, when Greek historian Hellanicus refers to it. Trojan hero Aeneas, in flight from Troy, lands on Italian coast and intermarries with Latin ruling family. His descendants are Romulus and Remus. Aeneas himself was worshipped in Rome under the label Iuppiter Indiges (“native Jupiter”). She-Wolf Legend: current in Italy by late 5th or earlier 4th century, though not clearly with reference to Rome. A statue of babies Romulus and Remus with she-wolf is known to have been set up in Rome as early as 296 BCE. “Latial”/ “Villanovan” settlement on Palatine Hill, which Romans regarded as site of Romulus’ original settlement Sabine component of Roman population: (1) early inhabitants of Quirinal Hill (2) Term for people “Quirites,” originally referring to Sabines, later used for Romans as group. (3) Legend of Sabine women probably is ex-post-facto explanation of Sabine component in Roman makeup. Foundation of Rome: traditionally agreed as being April 21, 753; Roman time-reckoning was generally in terms of so many years “since the founding of the city” (ab urbe condita, abbreviated AUC) Etruscan kings of Rome: Tarquinius Priscus (# 5) and Tarquin the Proud (# 7). The traditional date of his expulsion is 509 BCE. The Republic was believed to have begun immediately afterwards, but this is complicated by Lars Porsenna (of Clusium): attacked, and probably took Rome after Tarquin the Proud was expelled, but did not reinstall him. -

Archaeological and Literary Etruscans: Constructions of Etruscan Identity in the First Century Bce
ARCHAEOLOGICAL AND LITERARY ETRUSCANS: CONSTRUCTIONS OF ETRUSCAN IDENTITY IN THE FIRST CENTURY BCE John B. Beeby A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics in the College of Arts and Sciences. Chapel Hill 2019 Approved by: James B. Rives Jennifer Gates-Foster Luca Grillo Carrie Murray James O’Hara © 2019 John B. Beeby ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT John B. Beeby: Archaeological and Literary Etruscans: Constructions of Etruscan Identity in the First Century BCE (Under the direction of James B. Rives) This dissertation examines the construction and negotiation of Etruscan ethnic identity in the first century BCE using both archaeological and literary evidence. Earlier scholars maintained that the first century BCE witnessed the final decline of Etruscan civilization, the demise of their language, the end of Etruscan history, and the disappearance of true Etruscan identity. They saw these changes as the result of Romanization, a one-sided and therefore simple process. This dissertation shows that the changes occurring in Etruria during the first century BCE were instead complex and non-linear. Detailed analyses of both literary and archaeological evidence for Etruscans in the first century BCE show that there was a lively, ongoing discourse between and among Etruscans and non-Etruscans about the place of Etruscans in ancient society. My method musters evidence from Late Etruscan family tombs of Perugia, Vergil’s Aeneid, and Books 1-5 of Livy’s history. Chapter 1 introduces the topic of ethnicity in general and as it relates specifically to the study of material remains and literary criticism. -

Etruscan News 19
Volume 19 Winter 2017 Vulci - A year of excavation New treasures from the Necropolis of Poggio Mengarelli by Carlo Casi InnovativeInnovative TechnologiesTechnologies The inheritance of power: reveal the inscription King’s sceptres and the on the Stele di Vicchio infant princes of Spoleto, by P. Gregory Warden by P. Gregory Warden Umbria The Stele di Vicchio is beginning to by Joachim Weidig and Nicola Bruni reveal its secrets. Now securely identi- fied as a sacred text, it is the third 700 BC: Spoleto was the center of longest after the Liber Linteus and the Top, the “Tomba della Truccatrice,” her cosmetics still in jars at left. an Umbrian kingdom, as suggested by Capua Tile, and the earliest of the three, Bottom, a warrior’s iron and bronze short spear with a coiled handle. the new finds from the Orientalizing securely dated to the end of the 6th cen- necropolis of Piazza d’Armi that was tury BCE. It is also the only one of the It all started in January 2016 when even the heavy stone cap of the chamber partially excavated between 2008 and three with a precise archaeological con- the guards of the park, during the usual cover. The robbers were probably dis- 2011 by the Soprintendenza text, since it was placed in the founda- inspections, noticed a new hole made by turbed during their work by the frequent Archeologia dell’Umbria. The finds tions of the late Archaic temple at the grave robbers the night before. nightly rounds of the armed park guards, were processed and analysed by a team sanctuary of Poggio Colla (Vicchio di Strangely the clandestine excavation but they did have time to violate two of German and Italian researchers that Mugello, Firenze). -

A Short History of the Etruscans the Etruscan Non-Polis 4 the Etruscan Non-Polis Urban Growth in the Archaic Period Piazza
A Short History of the Etruscans The Etruscan Non-polis 4 The Etruscan Non-polis Urban Growth in the Archaic Period Piazza d’Armi at Veii and the earliest architectural terracottas Between the nineteenth and the beginning of the twentieth century, some archaeologists believed that the high terrace to the south of the main plateau of Veii known as Piazza d’Armi was the acropolis of the Etruscan city; George Dennis and eminent scholars Luigi Canina and Rodolfo Lanciani were of this opinion, but not everyone agreed. Its high position, naturally defended on three sides, was notable, but the terrace was separated from the plateau of the city by the gorge of the Fosso della Mola. To Ettore Gabrici, Neapolitan archaeologist then working at the Villa Giulia Museum, the area looked like an uncultivated patch with a few traces of ancient remains. In 1913, he went on to conduct the first ever stratigraphic excavation in the middle of the terrace, and brought to light painted tiles, parts of drystone walls and an elliptical structure dressed with tufa blocks, which he assumed belonged to a very early date prior to the flourishing of the Etruscans, but which we now know to be a cistern. Less than ten years later, field investigation in the area continued under the direction of Enrico Stefani who subsequently published the finds in 1944 (Stefani, 1944, p. 143). Among them were Iron Age huts, a series of buildings with stone blocks arranged according to an almost orthogonal plan, the remains of the ancient walls related to a large gate that, he saw, connected the terrace to the ancient city to the north (Figure 4.1). -

A Digital Workflow and Disseminating Data Katherine L. Mccusker And
11 The Vulci3000 Project: A Digital Workflow and Disseminating Data Katherine L. McCusker and Maurizio Forte Abstract: This article discusses the methodology of as the Tomb of Isis (Bonamici 1980). A large the Vulci3000 Project, which aims to examine the percentage of Attic vases known in the world today archaeological landscape as well as the urban space have been found in the Vulci cemeteries. The of the Western Forum at the Etruscan age site of habitation site is a uniquely stratified and mostly Vulci, located in Viterbo, Italy. A digital workflow untouched urban context that includes, in the same is proposed that efficiently incorporates data types area, Iron Age, Etruscan, Roman, and Medieval and results into the previous archaeological settlements (Arancio 2014; Ward-Perkins 1962). It workflow to create a more encompassing and had an area of c. 126 hectares and an estimated comprehensive project methodology. This digital population of thousands of inhabitants in the workflow will allow a virtual reality platform to be Classical period (6–5th centuries BCE). It was part created using the integrated data and interpretations. of the Etruscan dodecapolis, the Etruscan The methodological focus on the integration of Federation of the most important cities of Etruria. utilized data types points to a wider issue in the Vulci was highly important in terms of exchange, archaeological field, that of storing and sharing data political and social rank, production of valuable on one platform as well as how to disseminate such goods, and trade with the entire Mediterranean data to both the academic community and the Basin. -

The Discovery of the Mithras Statue of Tarquinia
Acta Ant. Hung. 58, 2018, 9–23 DOI: 10.1556/068.2018.58.1–4.2 MARIA GABRIELLA SCAPATICCI THE DISCOVERY OF THE MITHRAS STATUE OF TARQUINIA Summary: In 2014 the discovery of a Mithras’ statue at Tarquinia occurred. This was due to the Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, which informed the Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale about clandestine activities in May 2014 on the poggio della Civita – where the ancient city of Tarquinia stood – in a zone close to the Etruscan temple of the Ara della Regina (fig. 1). As soon as possible, the Soprintendenza carried out an archaeological excavation, focusing the ef- fort on the need to find evidence for the place of origin of the magnificent sculptural group (fig. 2), which represents Mithras Tauroctonus. This sculpture was recovered by the Carabinieri after investigation by the police, directed by the Procura della Repubblica of the law court of Rome. Archaeological research since then has led to the discovery of another marble part of the same sculpture (fig. 3), i.e., the dog leaning on the knee of the bull and perfectly dovetailing with the Mithraic Tauroctony. The discovery of another fragment pertaining to the same sculpture is an irrefutable proof that the Mithras’ statue came from the domus of the Civita of Tarquinia, which represents an important and new scientific result. The only other sculptural group depicting Mithras in Southern Etruria was one previously found in Vulci, discovered in 1975 after a clandestine excavation close to the domus del Criptoportico. This new finding proves the spread of this cult in Tarquinia, as well, and the style of the new sculpture suggests a chronological priority of the Tarquinian Mithraeum in respect to that in Vulci. -

Chiusi Romana Ricerche Di Prosopografia E Di Storia Socio-Economica
Chiusi romana Ricerche di prosopografia e di storia socio-economica Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln im Fach Alte Geschichte, Historisches Institut vorgelegt von Giuliano Caracciolo aus Rom, Italien Köln, den 30. Oktober 2018 Erster Referent: Prof. Dr. Werner Eck Zweiter Referent: Prof. Dr. Gian Luca Gregori A zia Dedé 2 SOMMARIO INTRODUZIONE 5 PARTE I. IL CONTESTO STORICO 1. Etruria romana. Modalità e criteri di espansione territoriale (III-I sec. a.C.) 10 2. Il nuovo ordine politico-amministrativo dopo il bellum sociale 15 2.1. Da municipio a colonia? La questione dello status giuridico di Clusium 20 PARTE II. PROSOPOGRAFIA E SOCIETÀ 1. Elementi di continuità e integrazione culturale nel corso del I sec. a.C. 26 1.1. Genealogie chiusine nella fase di transizione 27 1.2. Mutamenti nella prassi epigrafica 40 1.3. Iscrizioni digrafe e bilingui 43 1.4. Iscrizioni latine della fase di transizione 61 2. I gruppi sociali nella città romana 74 2.1. Senatori 75 2.2. Cavalieri 79 2.3. Magistrati 81 2.4. Militari 83 2.5. Altri gruppi sociali 86 2.5.1. Donne di nascita libera 86 2.5.2. Liberti e schiavi 90 2.6. Clusium e Clusini nel resto dell’Impero 94 3. Vita religiosa. Tradizioni etrusche e culti romani in territorio chiusino 95 4. Chiusi e Roma. Dediche a senatori e tracce della “praesentia Caesaris” 107 5. Chiusi tardoantica 111 5.1. Il complesso ipogeo “misto” di S. Caterina 116 5.2. La catacomba di S. Mustiola e la comunità cristiana 118 PARTE III. -
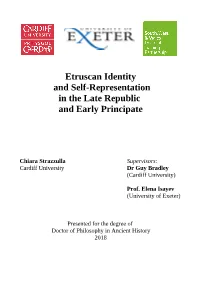
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate Chiara Strazzulla Supervisors: Cardiff University Dr Guy Bradley (Cardiff University) Prof. Elena Isayev (University of Exeter) Presented for the degree of Doctor of Philosophy in Ancient History 2018 Acknowledgements Research might often be portrayed as a solo enterprise, but no work of research is ever truly done alone. This work would most certainly not have been possible without the help and support of many others beside me, who gave their own precious insights, directed my investigation to unexpected corners of the subject topic, and generously gave assistance when assistance was needed. My heartfelt thanks go therefore to: My supervisors, Dr Guy Bradley and Prof. Elena Isayev, who have been present at every stage, providing fundamental clarifications, encouraging me to push my limits and find my strengths, helping me shape what was a disconnected bunch of ideas about Romans and Etruscans into something concrete. Their dedication to this work cannot be understated and without it none of it would have been possible. All at AHRC and the South, West and Wales Doctoral Training Partnership, for generously funding my PhD and providing invaluable occasions for personal and professional development, debate, and sharing. The discussions had at cohort days organised by the DTP have helped guide the direction my research was taking, provided me with additional tools and given me interdisciplinary insights. My thanks in particular to Chantelle Payne and Rose Jones, for their tireless organisational work; and to all the fellow DTP students with whom I exchanged opinions and ideas, most importantly Beatrice Hitchman, Sophie Payne, Maria Tomlinson, Anna Field, James Thomas Lloyd, and Jo Bryant.