Annales Oratorii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
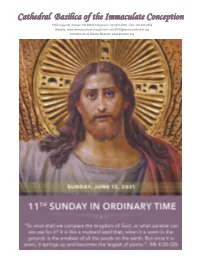
Cathedral Basilica of the Immaculate Conception 1535 Logan St
Cathedral Basilica of the Immaculate Conception 1535 Logan St. Denver, CO 80203 Telephone: 303-831-7010 - Fax: 303-831-9514 Website: www.denvercathedral.org Email: [email protected] Archdiocese of Denver Website: www.archden.org . CATHEDRAL BASILICA OF THE IMMACULATE CONCEPTION DENVER, CO ARCHBISHOP OF DENVER: Most Reverend Samuel J Aquila, STL MASS SCHEDULE AUXILIARY BISHOP OF DENVER: Most Reverend Jorge Rodriguez PASTOR AND RECTOR: Very Reverend Ronald W. Cattany WEEKDAY MASSES: 7:00 AM, 12:10 PM, 5:30 PM PAROCHIAL VICAR: Reverend Michael Rapp, S.S.L. Saturday: 7:00AM IN RESIDENCE: Reverend Andreas Hoeck Anticipated Saturday: 4:30PM DEACONS: Deacon Robert Finan, Deacon Robert Rinne, SUNDAY: 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM, & 6:30PM and Deacon Charles Goldburg DIRECTOR OF WORSHIP: John Brooks VISITING HOURS Weekday: 6:45am-7:45am, 11:00am-1:15pm DIRECTOR OF SACRED MUSIC: Phil Bordeleau Sunday: 8:15-9:45am, 10:15-11:45am, 12:15pm-1:45pm, PASTORAL ASSOCIATE: Brigid Demko 5:30-7:45pm RCIA COORDINATOR: Brett Manero Please call the office as special events or recordings may RELIGIOUS EDUCATION: Luciane Urban require closing. The Church may be closed during Mass. COORDINATOR OF COMMUNITY OUTREACH: Dave Martinez MANAGERS OF FINANCE AND ASSETS: Elizabeth Odum & Joe Cavaleri SACRAMENT OF RECONCILIATION (Confessions) ADMINISTRATIVE ASSISTANT: Linda Flores Monday-Friday 11:00am—12:00pm, Saturday 3 PM – 4 PM, BUILDINGS, GROUNDS, AND RECTORY OPERATIONS: Sunday 5:30—6:30pm Sebastian Luke Oliver Or by appointment, please call the office and wait for a MAINTENANCE AND GROUNDS: Jacob Carper confirmation call. You will need to wear a mask. -

Worth Reading
Worth Reading General Worth Assembly #1089 Fort Worth, Texas Newsletter for July 2018 Navigator’s Compass The passing of the gavel from FN Adrian Romero to incoming Navigator SK Ron Harris occurred at our Installation & Awards Dinner the evening of June 8th, held at St. Peter the Apostle Catholic Church Parish Hall. It was well attended by both the fine Master Staff of our awesome Third District Master Pat Conway, and our Members along with our faithful and supportive wives, with a total of almost sixty. The delicious meal was provided and served again by Luby’s Catering, with entrees of Angus beef, roasted turkey and chicken cordon bleu, and good variety of deserts. Not everyone who was receiving awards this year was able to attend this function, so they received their awards at following Assembly meetings. These awards included: SK Michael Smerick—60 years of Service to General Worth Assembly SK George Webster—Honorary Life Membership Top Sword Award—Michael Echevarria Family of the Year Award—Ron and Priscilla Harris The Month of May ended in a big way with all of the Memorial Day celebrations, the primary ones being the Honor Guard standings at both the National Cemetery in Dallas, and Mount Olivet Cemetery in Fort Worth, where dignitaries included the Mayor and the Navy Commander and Navy Chaplain of the Joint Reserve Naval Air Station, who even accompanied us for the Annual Toss of a wreath into the Trinity River from the Bridge. As a special treat, our Lady Knights posed with the Mayor of Fort Worth. -

{PDF} Benedict, Me and the Cardinals Three
BENEDICT, ME AND THE CARDINALS THREE PDF, EPUB, EBOOK William Meredith Morris | 437 pages | 30 Jun 2014 | ATF Press | 9781921511417 | English | Hindmarsh, SA, Australia Benedict, Me and the Cardinals Three PDF Book Archbishop emeritus of Hanoi. Archbishop of Barcelona. President emeritus of the Administration of the Patrimony of the Apostolic See. In the view of a number of civil lawyers, canon lawyers and theologians, both here in Australia and overseas, I was deprived of natural justice as I was in no way able to appeal the judgments or decisions that were made in these circumstances. Synods Ordinary general assemblies Extraordinary general assemblies Special assemblies. The Holy See Apostolic constitution. By default, this table is sorted by order of precedence, as denoted by the No. The book details the background and events which led to my being asked by Pope Benedict XVI to resign as Bishop of Toowoomba when I had a meeting with him in Rome on the 4th of June Auxiliary Bishop of San Salvador. Archbishop emeritus of Kaunas. Some such stories are better substantiated than others. Gualtiero Bassetti. Major Penitentiary emeritus. Dominique Mamberti. Login Register. Archivist and Librarian of the Holy Roman Church. Download as PDF Printable version. Archbishop of Cologne. Patrick, C. Details if other :. Retrieved 5 April Marian Jaworski" in Polish. A few keep their sexuality entirely private and adhere to the vow of celibacy. Society of Jesus Jesuits. Archived from the original on 5 April Months later, another leak of confidential information brought the subject of a gay lobby back into the news. Jozef De Kesel. -

Atividades Pastorais Junho/2018
ação católica ação católica Apresentação Apresentação Apresentação Neste número de Ação Católica damos particular relevo à no- meação de catorze novos cardeais, entre os quais se conta o Bispo de Leiria-Fátima, D. António Augusto dos Santos Marto. A propósito recordamos a origem e história do Colégio Cardinalício e apresen- tamos o elenco dos cardeais portugueses, a partir de Mestre Gil. Saudamos particularmente D. Francisco Senra Coelho e o P. José Tolentino Mendonça. Aquele, porque, nomeado arcebispo de Évora, deixa a Arquidiocese de Braga, onde tem exercido as funções de Bispo auxiliar. Este, porque foi nomeado bispo e bibliotecário arquivista da Santa Sé. Publicamos do senhor D. Jorge homilias proferidas no fim de uma peregrinação ao Sameiro e na celebração do Dia de Santo António, em Vila Nova de Famalicão. Damos notícia de visitas pastorais realizadas pelo senhor D. Nuno Almeida no arciprestado de Cabeceiras de Basto. Publicamos mensagens para o Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes: da Congregação do Clero e do Arcebispo Primaz. O Diretor Apresentação 1. Tema do Mês Origens e história do Colégio Cardinalício A história dos cardeais começa por estar ligada ao clero de Roma e já vem de longe: o título de cardeal foi reconhecido pela primeira vez durante o pontificado de Silvestre I (314-335). Inicialmente o título de cardeal (do latim ‘cardo/cardinis’, que significa “eixo”) era atribuído genericamente a pessoas ao serviço de uma igreja ou diaconia, reservando-se mais tarde aos responsá- veis das igrejas titulares de Roma e das igrejas mais importantes da Itália e do mundo. Os cardeais nascem do grupo de 25 presbíteros das comuni- dades eclesiais primitivas (títulos) em Roma, nomeados pelo Papa Cleto (séc. -
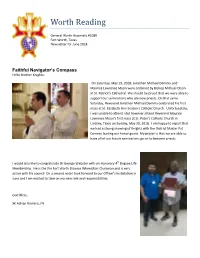
Worth Reading
Worth Reading General Worth Assembly #1089 Fort Worth, Texas Newsletter for June 2018 Faithful Navigator’s Compass Hello Brother Knights: On Saturday, May 19, 2018, Jonathan Michael Demma and Maurice Lawrence Moon were ordained by Bishop Michael Olson at St. Patrick’s Cathedral. We should be proud that we were able to support our seminarians who are now priests. On that same Saturday, Reverend Jonathan Michael Demma celebrated his first mass at St. Elizabeth Ann Seaton’s Catholic Church. Unfortunately, I was unable to attend I did however attend Reverend Maurice Lawrence Moon’s first mass at St. Peter’s Catholic Church in Lindsey, Texas on Sunday, May 20, 2018. I am happy to report that we had a strong showing of Knights with the District Master Pat Conway leading our honor guard. My prayer is that we are able to have all of our future seminarians go on to become priests. I would also like to congratulate SK George Webster with an Honorary 4th Degree Life Membership. He is the the Fort Worth Diocese Wheelchair Chairman and is very active with his council. On a second note I look forward to our Officer’s Installation in June and I am excited to take on my new role and responsibilities. God Bless, SK Adrian Romero, FN Captain’s Corner In my final Captain’s Corner I want to thank SK Alvin Melman for stepping up to fill the vacancy left in the Officers rotation by SK John Achtyl stepping up to fill the Comptroller vacancy created when SK David Siebold moved to San Antonio. -

Bollettino Diocesano 2016.2019 Online
Bollettino Diocesano Fabriano - Matelica 2016-2019 n.10 1 2 3 Bollettino Diocesano Diocesi Fabriano - Matelica marzo 2016 – gennaio 2019 4 Direttore responsabile: Mons. Tonino Lasconi Redazione: Curia Vescovile P.zza Giovanni Paolo II, 2 60044 Fabriano (AN) Pubblicazione ufficiale della Curia Diocesana 5 Mons. Stefano Russo Vescovo di Fabriano - Matelica 6 7 EDITORIALE Quattro anni, soprattutto in tempi di cambiamenti travolgenti come quelli che stiamo vivendo, sono tanti. E sono stati tanti anche per la nostra Diocesi. Tanti e non da poco. Ne basta uno per riassumere tutti gli altri: un nuovo Vescovo. Raggiunti i settantacinque anni, il 26 luglio 2015, il Vescovo Mons. Giancarlo Vecerrica ha offerto a Papa Francesco le sue dimissioni, diventando emerito il 18 giugno 2016, con la venuta in Diocesi del nuovo Vescovo, Mons. Stefano Russo, nominato dal Papa il diciotto marzo 2018, e ordinato Vescovo il 28 maggio 2016 nella cattedrale di Ascoli Piceno. Ricevendo il pastorale dalle mani di Mons. Vecerrica, alla presenza del Cardinale Edoardo Menichelli, il nuovo Vescovo raccolse il suo servizio alla Chiesa di Fabriano- Matelica con una serie di “sogni”: “una Chiesa che sia capace di testimoniare con i fatti prima ancora che con le parole, la realtà di Dio; una Chiesa in cui, i suoi diversi membri, nel rispetto di un disegno ordinato alla e dalla comunione, si sentano direttamente impegnati e responsabili della sua costruzione; una Chiesa capace di comprendere che la passione che è chiamata a vivere è prima di tutto quella che nasce dalla disponibilità a rinnegare se stessi e prendere ogni giorno la propria croce, seguendo Gesù; una Chiesa in ascolto, capace di cogliere il disegno di Dio dentro la nostra storia; una Chiesa maestra di relazioni; una Chiesa trasparente, capace cioè di dare ragione di se stessa; una Chiesa al passo con i tempi; una Chiesa in cui i presbiteri, i diaconi, le religiose, i religiosi, siano i primi testimoni della comunione”. -

Oggi I Vespri a San Giovanni Con Il Vicario
www.romasette.it Anno XLV – Numero 26 – Venerdì 29 giugno 2018 In evidenza facebook.com/romasette twitter.com/romasette Scommessa educativa [email protected] contro quelle del Web è un’emergenza nascosta. Non se ne parla sui C’giornali. Né occupa i tg della prima serata. È il miraggio del denaro facile per migliaia di ragazzi, anzi di ragazzini. Le cifre fornite dalla Caritas, di cui parliamo nel giornale, sono drammatiche. A Roma due ragazzi su tre, tra i 13 e i 17 anni, giocano d’az- zardo almeno una volta all’anno; il 36% gioca abi- tualmente. Il campionario è vario: scommesse sporti- ve, il “gratta e vinci”, le scommesse online. «I ragazzi romani sanno tutto dell’azzardo», denuncia la Cari- tas. E lo smartphone è lo strumento più utilizzato da- Inserto redazionale di gli adolescenti. C’è da chiedersi come si arrivi a tutto questo. O forse la risposta già la sappiamo, è dentro di noi. È in quel clima culturale che respirano i ra- gazzi, nell’idea del denaro al primo posto, nel deside- rio di un oggetto da soddisfare a ogni costo, nella so- Pagine a cura della Diocesi di Roma Avvenire - Redazione pagine diocesane litudine che vivono in casa. Con genitori assenti o di- L’ordinazione Coordinamento editoriale: Angelo Zema Piazza Carbonari 3 - 20125 Milano stratti, che concedono troppo presto uno smartphone Coordinamento redazionale: Giulia Rocchi Tel. 02.67801 - fax 02.6780483 in mano ai propri figli. «Un’azione criminale», com- di Palmieri, vescovo Piazza San Giovanni in Laterano 6 www.avvenire.it menta un esperto del Bambino Gesù. -

A Mio Fratello Corradino © One Group Edizioni (L’Aquila) [email protected] - Maggio 2017
a mio fratello Corradino © ONE GROUP EDIZIONI (L’AQUILA) [email protected] - www.onegroup.it Maggio 2017 Coordinamento: FRANCESCA POMPA e DUILIO CHILANTE Grafica: ELISABETTA SANTINI ISBN: 978-88-89568-57-6 GOffREDO PALMERINI S.S. 17 bis, 28/A Paganica - 67100 L’Aquila Tel. +39 0862.68416 - Cell. +39 328.6113944 [email protected] Goffredo Palmerini L’Italia nel cuore Sensazioni Emozioni Racconti di viaggio Ottobre 2014 - Dicembre 2015 INDICE Presentazione di LUISA PRAYER 9 Prefazione di CARLA ROSATI 11 Nota dell’Autore 15 Manhattan d’autunno ha i colori dell’arte fauve 17 ANNALISA DI RUSCIO, giovane talento d’Abruzzo ad Harvard 21 Diario dagli States: il Columbus Day, il teatro di FRATTI ed altro 27 Il terremoto della Marsica nel racconto di JOHANNES JØRGENSEN 35 Presentato a Genova il dizionario delle migrazioni italiane 39 MARIO FRATTI, drammaturgo insigne, ora anche poeta 45 MARIO FRATTI e le maschere nude del suo Volti di LILIANA BIONDI 47 Amigdalus, radici, natura e colori della nostra terra 53 Quattro scrittori insigniti a Lecce del premio Nelson Mandela 59 A Perugia l’omaggio della romania all’arte di CONSTANTIN UDROIU 61 A Pescara, l’omaggio alle donne costituenti abruzzesi 67 Il contributo di Maria Federici per l’Italia di CARLO FONZI 69 Paganica in lutto, vicina alle famiglie LEONE e IOVENITTI 73 A Padova la mostra antologica di GIGINO FALCONI 77 TORQUATO TASSO alla National Gallery di Washington 83 Il giorno di stefano: a Roma giornata delle culture migranti 85 A Casa Argentina e alla Sapienza due eventi sulle migrazioni 89 Un rosario di chiavi, una storia d’emigrazione abruzzese 93 La memoria per ricostruire un futuro possibile di CINZIA MARIA ROSSI 95 Con l’uomo carbone si rivive la tragedia di Marcinelle 97 La lingua italiana è uno spettacolo! intervista a M. -

Bartolomeo: «Il Martirio Dell'indifferenza» P
www.romasette.it Anno XLV – Numero 21 Domenica 27 maggio 2018 In evidenza facebook.com/romasette twitter.com/romasette Comunicazione, [email protected] storie e testimoni nvestire sulla comunicazione soprattutto per of- Ifrire percorsi di senso, in costante ascolto della realtà. Guardando quindi più al versante educati- vo che a quello degli strumenti, pur importanti. Con l’obiettivo di creare una nuova cultura della comu- nicazione a partire dalle comunità locali. Potrem- mo sintetizzare così il risultato della riflessione dei vescovi italiani riuniti nei giorni scorsi nell’assem- blea generale sul tema “Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo”. Al cuore del problema della comunicazione del Vangelo nel- Inserto redazionale di l’attuale società i vescovi hanno indicato l’espe- rienza evangelica più che il mezzo, il linguaggio o la capacità di utilizzo delle più moderne tecnologie (per le quali hanno espresso tuttavia una “simpatia critica”). E hanno evidenziato la necessità di risco- Pagine a cura della Diocesi di Roma Avvenire - Redazione pagine diocesane prire la narrazione. «C’è bisogno di raccontare la vi- Oggi speciale su Ostia Coordinamento editoriale: Angelo Zema Piazza Carbonari 3 - 20125 Milano ta, le storie delle persone attraverso le quali passa Coordinamento redazionale: Giulia Rocchi Tel. 02.67801 - fax 02.6780483 il messaggio», si legge nel comunicato finale del- verso il Corpus Domini Piazza San Giovanni in Laterano 6 www.avvenire.it l’assemblea Cei. In fondo, basta riandare alla Bib- 00184 Roma - tel. 06.69886150 e-mail: [email protected] bia, storia fatta di tante storie, per rendersi conto con papa Francesco di quanto sia davvero qui la chiave dell’autentico € annuncio cristiano. -

God Speed, Class of 2018
FLORIDAWWW.THEFLORIDACATHOLIC.ORG | June 2018 Catholic MIAMI ARCHDIOCESE ARCHBISHOP ARCHBISHOP IMMACULATA- CARROLLTON SCHOOL COLEMAN CARROLL EDWARD MCCARTHY LASALLE OF THE SACRED HEART Valedictorian Salutatorian Valedictorian Salutatorian Valedictorian Salutatorian Valedictorian Valedictorian Ryan Alejandro Rebecca Matthew Maria del Shannon Gabriela Nathalie Cruz Camacho Zasloff Estenoz Rocio Velilla Mary Hurley Blanco Fuentes OUR LADY OF LOURDES God speed, BELEN JESUIT class of 2018 FLORIDA CATHOLIC STAFF Hispanic Scholars, 5 percent. Valedictorian Salutatorian r DPNNVOJUZTFSWJDFIPVST Valedictorian Salutatorian Claudia Evely MIAMI | The smiling faces all around completed. Andres Jorge Pichardo Forte Dones you are only part of the story of the class rDPNQMFUFEZFBSTPG$BUIPMJD Moscoso of 2018 in the Archdiocese of Miami. But CARDINAL GIBBONS FEVDBUJPOSFQSFTFOUJOHQFSDFOUPGUIF CHAMINADE-MADONNA even the numbers below — as impres- graduates of six schools that keep those sive as they are — don’t paint a com- statistics. God speed, class of 2018. Don’t plete picture. Numbers don’t convey the forget your roots. Hold on to your faith. hours of effort, the strength of character And continue to make your parents and or the depth of dedication of this year’s your Church proud. 3,062 graduates of the 12 Catholic high schools, and one virtual school, in the ST. THOMAS AQUINAS archdiocese. So keep that in mind as you read about some of their accom- Valedictorian Valedictorian plishments (inside) and peruse these Valedictorian Salutatorian Ethan Nicholas -

Lina Palmerini Prefazione Di Benedetta Rinaldi
a Mario Fratti, drammaturgo scrittore e poeta insigne, amico straordinario e fraterno con L’Aquila nel cuore © 2020 - ONE GROUP S.R.L. S.S. 17 Ovest, Tecnopolo D’Abruzzo 67100 L’Aquila [email protected] - www.onegroup.it Coordinamento Editoriale DUILIO CHILANTE Direzione creativa FRANCESCA POMPA Grafica ROBERTA GUIDA - One Group ISBN: 978-88-89568-873 GOFFREDO PALMERINI S.S. 17 bis, 28/A Paganica - 67100 L’Aquila Tel. +39 0862.68416 - Cell. +39 328.6113944 [email protected] Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubbli- cazione può essere riprodotta, interamente o in parte, memorizzata o inserita in un sistema di ricerca delle informazioni o trasmessa in qualsiasi forma e con qual- siasi mezzo (elettronico o meccanico, in fotocopia o altro), senza il consenso scritto dell’editore. G off RE do P ALMERINI Italia ante Covid Presentazione di LINA PALMERINI Prefazione di BENEDETTA RINALDI INDICE Presentazione di LINA PALMERINI 9 Prefazione di BENEDETTA RINALDI 13 Dieci anni dal terremoto dell’Aquila: il nostro grazie 15 Nota dell’Autore 21 Una cupola vera sulla cattedrale dell’Aquila 23 Ricordando il Battaglione Alpini “L'Aquila” 29 Gallipoli e Galatone s’illuminano con arte e letteratura 35 John Bailey è il nuovo presidente dell’Academy Awards 41 A Galatone una serata di testimonianze sulla Pace 45 A New York anche con la pioggia un grande Columbus Day 49 Reportage dal Canada: le giornate di Ottawa e Montreal 63 1. Alla scoperta delle meraviglie del Belpaese L'incantesimo del barocco, tra colori e odori della Sicilia -

L'o S S E Rvator E Romano
Price € 1,00. Back issues € 2,00 L’O S S E RVATOR E ROMANO WEEKLY EDITION IN ENGLISH Unicuique suum Non praevalebunt Fifty-third year, number 44 (2.670) Vatican City Friday, 30 October 2020 The Pope condemns the criminal act that took place in Nice and is close to the French community General Audience Silence the weapons Nice attack: death in a place in Cameroon of love and consolation “Having learned of the brutal at- tack that took place this morn- ing in Nice, causing the death of several innocent people, His Holiness Pope Francis joins with his prayer, the suffering of the grieving families and shares their pain”, Secretary of State Cardi- nal Pietro Parolin wrote in a telegram addressed to Bishop At the General Audience on André Marceau of Nice. The Wednesday, 28 October, the Holy telegram was referring to the at- Father made the following appeal. tack carried out on Thursday I participate in the suffering of morning, 29 October, in the the families of the young students Notre Dame Basilica, which left who were barbarically killed last three dead and one injured. The Saturday in Kumba, in Pontiff, the telegram continued, Cameroon. I feel great bewilder- “asks the Lord to bring them comfort and keep the victims in ment at such a cruel and senseless his mercy. Strongly condemning act, which tore the young inno- similar violent acts of terror, he cents from life while they were at- ensures his closeness to France’s tending lessons at school. May Catholic community and all the God enlighten hearts, so that people of France whom he in- similar gestures may never be re- vites to unity”.