Vie Del Gusto” (Cod
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di Annone Veneto
Data immissione 05.07.2004 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it COMUNE DI ANNONE VENETO STATUTO Delibera n. 20 del 30/3/2004. TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 DEFINIZIONE 1. Il comune di Annone Veneto rappresenta la comunità dei cittadini di Annone Veneto, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia. 2. Il comune di Annone Veneto è paese autonomo secondo: a) le norme del presente Statuto b) i principi costituzionali della Repubblica Italiana e del trattato dell’Unione Europea. 3. Il Comune esercita e promuove funzioni attribuite e/o delegate dalle leggi regionali, nazionali ed europee, e altresì funzioni autonome, attingendo liberamente da risorse proprie di cui disporre con deliberazione del Consiglio comunale. 4. La sede del comune è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1. La circoscrizione del Comune è costituita da Annone Veneto Capoluogo e delle frazioni di Spadacenta, Giai, Loncon. Il territorio del comune si estende per 25,79 KM2 e confina con i Comuni di Pravisdomini (PN), Pramaggiore (VE), Portogruaro (VE), Santo Stino di Livenza (VE), Motta di Livenza (TV), Meduna di Livenza (TV). Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 5. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma e il gonfalone. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Annone Veneto, con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951. -

Elenco Immobili in Proprietà Ater Venezia - Gestione ERP
Elenco Immobili in Proprietà Ater Venezia - Gestione ERP Ultimo Fitto Codice Descrizione Indirizzo Comune Mensile UI_11140002 Alloggio VIALE VENEZIA 11 ANNONE VENETO 20,73 UI_11140003 Alloggio VIALE VENEZIA 11 ANNONE VENETO 104,34 UI_11140004 Alloggio VIALE VENEZIA 13 ANNONE VENETO 35,67 UI_18630002 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 13 CAMPAGNA LUPIA 243,44 UI_18640003 Alloggio STADIO 13 CAMPAGNA LUPIA 10,73 UI_18640006 Alloggio STADIO 9 CAMPAGNA LUPIA 50,99 UI_18650001 Alloggio BRESSANIN 21 CAMPAGNA LUPIA 53,86 UI_18650002 Alloggio BRESSANIN 21 CAMPAGNA LUPIA 129,26 UI_18660001 Alloggio GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 67,68 UI_18660002 Alloggio GORIZIA 5 CAMPAGNA LUPIA 10,73 UI_18660003 Alloggio GORIZIA 3 CAMPAGNA LUPIA 92,33 UI_18660004 Alloggio GORIZIA 3 CAMPAGNA LUPIA 67,70 UI_1866BB01 Box GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 0,00 UI_1866BB02 Box GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 0,00 UI_1866BB03 Box GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 0,00 UI_1866BB04 Box GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 0,00 UI_1866BB05 Box GORIZIA 1 CAMPAGNA LUPIA 0,00 UI_30640001 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 53,90 UI_30640002 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 67,82 UI_30640003 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 80,84 UI_30640004 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 415,75 UI_30640005 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 20,73 UI_30640006 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 166,30 UI_30640007 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 80,84 UI_30640008 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 249,45 UI_30640009 Alloggio SALVO D'ACQUISTO 20 CAMPAGNA LUPIA 35,04 -

Come Funziona Il Prestito Degli Ebook
Puoi prendere in prestito gli ebook della Biblioteca Digitale Venezia BIBLIOTECHE METROPOLITANE VENEZIA Metropolitana e della Biblioteca Digitale del Polo regionale del Veneto Città metropolitana di Venezia Puoi leggere gli ebook protetti con DRM se sei iscritto a una delle biblioteche aderenti alla Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA Il prestito di un ebook (con DRM) ha SERVIZIO ATTIVO una durata di 14 giorni. Trascorse le NELLE BIBLIOTECHE DI 2 settimane il file risulterà bloccato sul ANNONE VENETO, CAMPAGNA LUPIA, Come funziona tuo dispositivo CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, CAORLE, CAVALLINO-TREPORTI, CAVARZERE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONA, DOLO, il prestito degli ERACLEA, FIESSO D’ARTICO, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FOSSÒ, GRUARO, JESOLO, MARCON, MARTELLAGO, eBook MEOLO, MIRANO, MUSILE DI PIAVE, NOALE, PIANIGA, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, Puoi avere in prestito 3 ebook della QUARTO D’ALTINO, SALZANO, Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SAN STINO DI LIVENZA, SANTA MARIA DI SALA, alla volta SCORZÈ, SPINEA, STRA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO, VIGONOVO RETE BIBLIOTECHE VENEZIA Anche gli ebook sono prenotabili Catalogo bimetrove.regione.veneto.it BIBLIOTECHE METROPOLITANE VENEZIA EREADER SMARTPHONE / TABLET Scarica una qualsiasi di queste app per Che cosa devo fare per Installa sul tuo computer Adobe Digital Editions e autorizzalo con l’ADOBE ID leggere gli ebook: prendere in prestito un Ti servirà per trasferire l'ebook ebook della biblioteca? scaricato dal pc all’ereader Aldiko Bluefire Reader Poche cose, https://www.adobe.com/it/solutions/ ebook/digital-editions/download.html OverDrive ma importanti. Segui questi passaggi Autorizza la app con il tuo Adobe ID nell'ordine. -

San Donà Di Piave-Noventa Di Piave-Iesolo Coordinatore Ceggia-- Fossalta Di Piave-Musile Di Piave Di RLS ZONA DI SAN DONA' E
San Donà di Piave-Noventa di Piave-Iesolo Coordinatore Ceggia-- Fossalta di Piave-Musile di Piave di RLS ZONA DI SAN DONA' E. Berto Cavallino - Eraclea – Meolo -Torre di Mosto Tel. 3669223995 3 EURO AL MARE. Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare il Progetto “Al mare con 3€” : soggiorno Estivo per anziani, promosso dalla Amministrazioni Comunali di san Donà di Piave e Noventa di Piave, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL , UILP-UIL, Pensionati. Lo scopo era quello di consentire l’accesso alle vacanze a persone anziane dando la possibilità di utilizzare spiagge e mare nella vicina località di Eraclea Mare e la buona partecipazione ha dimostrato la validità del progetto e ci permette e ci da forza nel continuare in questa iniziativa. CONSULTA PER LA CITTA’ METROPOLITANA. Lunedì 14 Settembre si è svolto il primo incontro presso il Municipio di San Donà di Piave, per avviare un confronto tra il Consiglio Metropolitano eletto lo scorso Agosto, il quale ha reso concreto il passaggio dalla Provincia alla Città Metropolitana di Venezia. Tale mutamento interessa direttamente i rappresentanti dei lavoratori e le imprese del nostro territorio. Il Sindaco di San Donà di Piave ha invitato anche i rappresentanti della FNP-CISL che, hanno portato il proprio contributo nella proposta della stesura dello Statuto per il funzionamento della città metropolitana. Al termine dell’incontro si è convenuto che gli incontri proseguiranno non appena si avrà la possibilità di avere materialmente in mano lo Statuto della citta metropolitana, per poter contribuire ulteriormente nelle proposte attinenti non solo alla categoria dei pensionati, ma per tutte le problematiche che riguardano le persone anziane. -

Tabella Corrispondenza Aree Comuni.Pdf
ZONE DI RIFERIMENTO PER IL BOLLETTINO PM10 Codice ISTAT NOME COMUNE PROVINCIA ZONA RIFERIMENTO BOLLETTINO 25001 Agordo BL Comune appartenente a zona montana 25002 Alano di Piave BL Feltre 25003 Alleghe BL Comune appartenente a zona montana 25072 Alpago BL Belluno 25004 Arsie' BL Feltre 25005 Auronzo di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25006 Belluno BL Belluno 25007 Borca di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25074 Borgo Valbelluna BL Feltre 25008 Calalzo di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25023 Canale d'Agordo BL Comune appartenente a zona montana 25010 Cencenighe Agordino BL Comune appartenente a zona montana 25011 Cesiomaggiore BL Feltre 25012 Chies d'Alpago BL Comune appartenente a zona montana 25013 Cibiana di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25014 Colle Santa Lucia BL Comune appartenente a zona montana 25015 Comelico Superiore BL Comune appartenente a zona montana 25016 Cortina d'Ampezzo BL Comune appartenente a zona montana 25017 Danta di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25018 Domegge di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25019 Falcade BL Comune appartenente a zona montana 25021 Feltre BL Feltre 25022 Fonzaso BL Feltre 25025 Gosaldo BL Comune appartenente a zona montana 25027 La Valle Agordina BL Comune appartenente a zona montana 25026 Lamon BL Comune appartenente a zona montana 25029 Limana BL Belluno 25030 Livinallongo del Col di Lana BL Comune appartenente a zona montana 25071 Longarone BL Belluno 25032 Lorenzago di Cadore BL Comune appartenente a zona montana -

Recapiti Formazioni Campionato PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Recapiti Formazioni Campionato PRIMA DIVISIONE FEMMINILE Squadra [06.027.0141] ASD PALLAVOLE CEGGIA (Società: ASD PALLAVOLO CEGGIA) Dir.resp. BALDO STEFANIA Recapiti cell: 3485199278 e-mail: [email protected] Impianto: Palasp. Ceggia - - CEGGIA - VE - Via Don A. Folegot Squadra [06.027.0002] CUS VE TERMINAL FUSINA (Società: CUS VENEZIA) Dir.resp. PAZZI FABIO Recapiti cell: 3299439497 e-mail: [email protected] Impianti: Palasport Arsenale - - VENEZIA - VE - Castello 2132 Impianti Sport. Cus - - VENEZIA - VE - Calle dei Guardiani Squadra [06.027.0208] ESSECI SOLUTIONS (Società: PALLAVOLO MESTRE A.S.D.) Dir.resp. GIOVANNI POZZI Recapiti cell: 3481784358 e-mail: [email protected] Impianto: Gramsci - CAMPALTO - VENEZIA - VE - Via Passo Cavana 3 Squadra [06.027.0197] EURO TERRAGLIO FAVARO (Società: TERRAGLIO VOLLEY SRL) Dir.resp. GIOVANNI POZZI Recapiti cell: 3481784358 e-mail: [email protected] Impianto: Palestra Terraglio - MESTRE - VENEZIA - VE - Via Penello, 5-7 Squadra [06.027.0005] F229 VOLLEY PROJECT (Società: F229 VOLLEY PROJECT ASD) Dir.resp. GALLO LUCA Recapiti cell: 3356357352 e-mail: [email protected] Impianto: Leopardi - - MIRA - VE - Via Oberdan Squadra [06.027.0051] FURLAN MARCO ELPIS VOLLEY (Società: ELPIS VOLLEY ASD) Dir.resp. FORLIN GUGLIELMO Recapiti cell: 3470680444 e-mail: [email protected] Impianto: Palasp. Meolo - - MEOLO - VE - Via Buranello Squadra [06.027.0198] IMOCO VOLLEY SAN DONA' (Società: S.S.D. SAN DONA' PIAVE VOLLEY SRL) Dir.resp. BUSCATO MASSIMO Recapiti cell: 3460789253 Impianti: Palasport Fontebasso - - NOVENTA DI PIAVE - VE - Via Guaiane 37/c S.M. Toti - - MUSILE DI PIAVE - VE - Via Marconi 1 Volterra - - SAN DONA' DI PIAVE - VE - Via Milano 9 Squadra [06.027.0153] LAGUNA VOLLEY (Società: LAGUNA VOLLEY) Dir.resp. -

Allegato 3 Fattorie Aperte Provincia
PROVINCIA DI VENEZIA PROVINCIA DI VENEZIA ALLA VACCHERIA CORTE FRANCA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola Campagna Lupia Cavarzere www.fondazionefranceschettiedicola.it Alla Vaccheria 335 1354663 329 8594301 [email protected] [email protected] - [email protected] FATTORIA DA GIULIA Azienda agricola - Agriturismo DIMENSIONE NATURA Ceggia Azienda agricola - Agriturismo Campagna Lupia Fattoria Giulia www.dimensione-natura.com 347 7528689 Dimensione Natura Franca Callegaro [email protected] 340 3071293 LUDOFATTORIA L'OCA PAZZA [email protected] Azienda agricola - Agriturismo Ceggia LA CHIOCCIA www.pradarca.it Azienda agricola - Agriturismo Comune di Ceggia - Prot. n. 0011410 del 09-10-2019 Campagna Lupia Agriturismo Pra d'Arca www.agriturismolachioccia.it 342 1338236 Agriturismo La Chioccia [email protected] 041 5185270 ALLEVAMENTO VENETO OVINI [email protected] CORTE BONICELLA Azienda agricola - Agriturismo FATTORIA SOLIDALIA Cona Azienda agricola biologica www.cortebonicella.it Oasi WWF Valle Averto Campagna Lupia Agriturismo Corte Bonicella 340 3513379 Fattoria Solidalia [email protected] 041 5185068 [email protected] PROVINCIA DI VENEZIA PROVINCIA DI VENEZIA TENUTA CIVRANA LE SERRE CORRADI Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola Cona Marcon www.tenutacivrana.it www.retecorradi.it Tenuta Civrana Az.Agr.Corradi 347 2220023 349 6339803 [email protected] [email protected] BLU VERDERAME AI LAGHETTI Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola - Agriturismo -

5.5 La Provincia Di Venezia
5.5 LA PROVINCIA DI VENEZIA Comuni n. 44 Abitanti 858.731 Densità di popolazione (ab/km 2) 347,5 Presenze turistiche 33.585.048 Abitanti equivalenti 950.745 Adesioni al compostaggio domestico 41.232 Comuni in Tariffa (ai sensi dell’ art. 238 del D.Lgs 152/06) 32 Dati anno 2009 La produzione di rifiuti urbani tonnellate Var % Produzione totale 532.074 -4,54 500.000 kg/ab*a Var % 400.000 Produzione pro capite 620 -5,09 300.000 Dati anno 2009 200.000 tonnellate 100.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Produzione totale di rifiuto urbano - Anni 1997-2009 (Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti) La raccolta differenziata tonnellate Var % kg/ab*a Var % 400.000 Raccolta differenziata 239.709 0,01 279 0,08 350.000 Rifiuto Urbano Residuo 292.365 -8,42 340 -8,94 300.000 45,1 Secco/Indifferenziato 261.879 -0,08 305 -8,63 250.000 42,7 38,1 35,2 Spazzamento 13.896 -0,29 16 -29,33 200.000 32,8 29,1 29,1 30,1 tonnellate 27,0 Ingombranti 16.589 0,13 19 12,76 150.000 21,8 23,7 18,3 Dati anno 2009 100.000 13,3 50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Raccolta differenziata Residuo %RD Produzione di rifiuto urbano differenziato e di rifiuto urbano residuo - Anni 1997-2009 (Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti) I rifiuti avviati a recupero tonnellate Var % kg/aba Var % FORSU 53.251 7,98 62,0 7,36 Imballaggi metallici RAEE Multimateriale Altro recuperabile 55.098 -1,15 64,2 -1,72 0,1% 1,4% Rifiuti Verde Plastica 19,0% 9,7% 0,6% particolari Vetro 2.670 18,45 3,1 17,77 0,3% Carta -
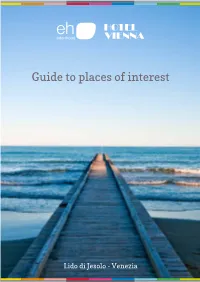
Guide to Places of Interest
Guide to places of interest Lido di Jesolo - Venezia Cortina Oderzo Portogruaro Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Caorle Altino Eraclea Vicenza Jesolo Eraclea Mare Burano Cortellazzo Lido di Jesolo Dolo Venezia Verona Padova Cavallino Mira Cà Savio Chioggia Jesolo and the hinterland. 3 Cathedrals and Roman Abbeys . 10 Visits to markets Concordia Sagittaria, Summaga and San Donà di Piave Venice . 4 From the sea to Venice’s Lagoon . 11 St Mark’s Square, the Palazzo Ducale (Doge’s Palace) and the Caorle, Cortellazzo, Treporti and Lio Piccolo Rialto Bridge The Marchland of Treviso The Islands of the Lagoon . 5 and the city of Treviso . 12 Murano, Burano and Torcello Oderzo, Piazza dei Signori and the Shrine of the Madonna of Motta Verona and Lake Garda. 6 Padua . 13 Sirmione and the Grottoes of Catullo Scrovegni Chapel and Piazza delle Erbe (Square of Herbs) The Arena of Verona and Opera . 7 Vicenza . 14 Operatic music The Olympic Theatre and the Ponte Vecchio (Old Bridge) of Bas- sano del Grappa Cortina and the Dolomites . 8 The three peaks of Lavaredo and Lake Misurina Riviera del Brenta . 15 Villas and gardens The Coastlines . 9 Malamocco, Pellestrina, Chioggia 2 Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Eraclea Caorle Jesolo Eraclea Mare Lido di Jesolo Cortellazzo Cavallino Jesolo and the hinterland The lagoon with its northern appendage wends its way into the area of Jesolo between the river and the cultivated countryside. The large fishing valleys of the northern lagoon extend over an area that is waiting to be explored. Whatever your requirements, please discuss these with our staff who will be more than happy to help. -

Linea 53-55-56-57-58-58R-59-66-67
LINEA 67R PIOVE DI SACCO - CORTE - SAMPIERI - BOJON - CAMPAGNA LUPIA - PROZZOLO - CALCROCI - LUGHETTO - VIA ROMEA - VIA MALCONTENTA - VIA PADANA - VIA F.LLI BANDIERA - VIA DELLA LIBERTÀ - VENEZIA (nes) (nes) (nes) (sab) (nes) (nes) (nes) (nes) (nes) (1) (3) (7) (2) (14) (8) (15) (8) (11) (8) (15) (12) (13) (10) (8) (14) (8) (10) (15) (8) (9) (14) FERIALE PIOVE DI SACCO 4.45 5.25 - 6.15 - 6.30 - 6.50 6.50 - 12.05 12.45 13.13 - - 17.15 - 20.45 CORTE - - - - 6.20 - - - - - - - - - - - 17.45 - CAMPOLONGO MUNICIPIO 4.51 - - - 6.25 - - 6.56 6.56 - - 12.51 - - - - - 20.51 BOJON CENTRO 4.54 - - - 6.28 - - 6.59 6.59 - - 12.54 - - - - - 20.54 BOJON SP13 4.55 5.34 6.10 6.24 6.30 6.39 6.50 7.00 7.01 7.05 12.14 12.55 13.22 15.15 15.45 17.24 17.49 20.55 CAMPAGNA LUPIA 4.58 5.37 6.13 6.27 6.33 6.42 6.53 7.03 7.04 7.08 12.17 12.58 13.25 15.18 15.48 17.27 17.52 20.58 CALCROCI CHIESA 5.03 5.41 6.17 6.31 6.37 6.46 6.57 7.08 7.08 7.12 12.21 13.03 13.29 15.22 15.52 17.31 17.56 21.03 LUGHETTO 5.05 5.44 6.19 6.34 6.40 6.49 6.59 7.10 7.11 7.14 12.24 13.05 13.32 15.24 15.54 17.34 17.59 21.05 VENEZIA 5.33 6.12 6.48 7.02 7.08 7.17 7.28 7.39 7.39 7.42 12.52 13.33 14.00 15.52 16.23 18.02 18.27 21.33 (nes) NON EFFETTUATA AL SABATO (sab) EFFETTUATA AL SABATO (1) A CALCROCI CHIESA COINCIDENZA DA VIGONOVO LINEA 55. -

24-2020 Dirigente Medico Di Oncologia P.O. MIRANO
AULSS3.au12ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0115791.03-08-2020 AVVISO PUBBLICO N. 24 – DEL 03.08.2020 PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI ONCOLOGIA AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MIRANO TEMPO PIENO ED ESCLUSIVO Pubblicato all’Albo Pretorio e nel Sito Internet dell’Azienda in data 03.08.2020 - SCADENZA 02 SETTEMBRE 2020 - IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO NELLE MORE DELL’ACQUISIZIONE DELLA PREVISTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE E, PERTANTO, L’EFFETTIVA IMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI EVENTUALI CANDIDATI PRESCELTI AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE. L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA CHE L’ESITO DELLA PRESENTE PROCEDURA È CONDIZIONATO ALL’ESITO NEGATIVO DELLE PROCEDURE DI ESUBERO EX ART. 34-BIS D.LGS. N. 165/2001. DIRETTORE RESPONSABILE DEL COLLOQUIO E DELLA VALUTAZIONE DEI CURRICULA : Dott. Giuseppe AZZARELLO – Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa UOC ONCOLOGIA del Presidio Ospedaliero di Mirano SEDE DEL COLLOQUIO: Az. Ulss 3 Serenissima – Via Don F. Tosatto, 147 Mestre (VE) – 3° piano – sala Igea DATA E ORA DEL COLLOQUIO: 14 SETTEMBRE 2020 ORE 15:30 Nell’accesso e nello stazionamento nei locali della sede del colloquio è fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento personale di almeno 1 metro e nella fase di identificazione sarà richiesto, tramite autocertificazione, di confermare di: V non versare in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; V non aver avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data del colloquio; V se risultato positivo al Covid19, di possedere certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone. -

Il Territorio Aggiornato
Il territorio: aspetti demografici, socio- culturali ed economici dei Comuni di Ceggia e di Torre di Mosto L'Istituto Comprensivo "G. Marconi" comprende sei plessi scolastici: * due di Scuola dell'Infanzia * due di Scuola Primaria * due di Scuola Secondaria di primo grado inseriti nelle realtà territoriali di due Comuni: Ceggia e Torre di Mosto. I due Comuni sono situati in quel area geografica denominata Nord Est , formata dal Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che ha visto una "rapida trasformazione" a partire dagli anni Novanta. Aspetti territoriali Comune di Ceggia Comune di Torre di Mosto Il territorio di Ceggia si trova nella parte Il territorio di Torre di Mosto si trova nella orientale della Provincia di Venezia ed è parte orientale della provincia di Venezia ed è compreso tra i Comuni di S.Donà di Piave a compreso tra i Comuni di Cessalto (TV) a Sud, Cessalto a Nord-Ovest e Torre di Mosto Nord, Ceggia a Nord-Ovest, Eraclea a Ovest, a Nord-Est. Caorle a Sud e Santo Stino di Livenza a Est. Il principale corso d'acqua presente nel I confini con Eraclea, Caorle e Santo Stino di territorio è il Canale Piavon, ci sono inoltre Livenza sono in buona parte delimitati numerosi canali di bonifica. rispettivamente dal Canale consorziale Brian e L'estensione del Territorio è di 21 Km. dal fiume Livenza. quadrati . L'estensione territoriale è di 38,34 Km. Collegamenti stradali sono rappresentati da quadrati . alcune strade provinciali e dalla Strada Collegamenti stradali sono rappresentati da Statale 14 Triestina che collegano Ceggia con alcune Strade Provinciali che collegano Torre S.Donà di Piave, Torre di Mosto, Cessalto, di Mosto con S.Donà, Portogruaro, Caorle, Santo Stino di Livenza.