San Marco in Syivis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Head of a Sheep Pastel, Black Chalk and Touches of Gouache on Light Brown Paper
Francesco Paolo Michetti (Tocco di Casauria 1851 - Francavilla al Mare 1929) The Head of a Sheep Pastel, black chalk and touches of gouache on light brown paper. Signed Michetti at the lower right. 527 x 438 mm. (20 3/4 x 17 1/4 in.) Sheep, goats and other animals appear in several of Michetti’s paintings of pastoral subjects in the 1880’s and 1890’s. The present sheet, executed with the artist’s characteristic bravura handling of a combination of pastel and gouache, may be compared stylistically with a large sheet of studies of goats in pastel, datable to 1886, in a private collection. Between 1895 and 1900 Michetti also made several photographs of sheep and goats, which he may also have used as preparatory studies for paintings. Provenance: Private collection, Chile, until 2010. Artist description: A pupil of Domenico Morelli at the Accademia di Belle Arti in Naples, Francesco Paolo Michetti enjoyed his earliest success in Paris, where he participated in the Salons of 1872 and 1875. However, it was not until 1877, when his large canvas of The Procession of the Corpus Domini at Chieti was exhibited in Naples to popular acclaim, that he secured his reputation in Italy. Michetti developed a distinctive style of painting, with the use of bold colours and vibrant effects achieved with a virtuoso technique. A common thread in his work is his interest in rural themes, and particularly the beliefs and traditions of his native Abruzzi region, seen in such paintings of the 1880’s as The Vow, now in the Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome. -

The British & International Pictures Auction Lot
The British & International Pictures Auction Wed, 21st Nov 2018 Viewing: Monday 19th - 9am-5pm Tuesday 20th - 9am-5pm Wedensday 21st - 9am-2pm Lot 506 Estimate: £2000 - £4000 + Fees A RARE PASTEL BY FRANCESCO PAOLO MICHETTI FRANCESCO PAOLO MICHETTI (ITALIAN 1851 - 1929), THE PIPE PLAYER pastel on paper, signed 35.50cm x 26.00cm Mounted, framed and under glass Provenance: Acquired Shapes Auctions (Edinburgh) 31st March 2007 lot 596 for £6300 (hammer) Note: Michetti was born in Tocco da Casauria in the Province of Chieti. His father having died when he was a boy, Michetti was forced to work with a local artisan. In 1868, Michetti was awarded a stipend by the province to study at the Accademia (now Istituto) in Naples under Domenico Morelli. Among his colleagues was Eduardo Dalbono. There he also interacted with Filippo Palizzi, Giuseppe De Nittis, and Marco De Gregorio, artists of the School of Resina. Disciplinary problems soon caused Michetti to return to Chieti. He began to spend time in Francavilla a Mare, which by 1878 would be his home. He traveled to Paris, encouraged and supported by De Nittis, by the patron Beniamino Rotondo, and by the art merchant Reutlinger. In Paris, he exhibited in the Salon of 1872: Ritorno dall'erbaggio, Dream of Innocence, and The Pumpkin Harvest. He also exhibited at Salons in 1875 and 1876. In 1874, he befriended the Spanish painter Mariano Fortuny in Naples. In 1877, with his Corpus Christi Procession, a highly colourful, efervescent depiction of a festival, he became recognized as one of the best in the schools exhibition. -

Download Catalogue
ONE HUNDRED DRAWINGS & WATERCOLOURS STEPHEN ONGPIN GUY PEPPIATT PEPPIATT GUY ONGPIN STEPHEN WATERCOLOURS & DRAWINGS HUNDRED ONE 2016-2017 ONE HUNDRED DRAWINGS AND WATERCOLOURS Stephen Ongpin Fine Art Ltd. Guy Peppiatt Fine Art Ltd. Riverwide House 6 Mason’s Yard Duke Street, St James’s London SW1Y 6BU GUY PEPPIATT FINE ART STEPHEN ONGPIN FINE ART ONE HUNDRED DRAWINGS AND WATERCOLOURS dating from the 16th Century to the 20th Century WINTER CATALOGUE 2016–2017 to be exhibited at Riverwide House 6 Mason’s Yard Duke Street, St. James’s London SW1Y 6BU Stephen Ongpin Fine Art Guy Peppiatt Fine Art Tel.+44 (0) 20 7930 8813 Tel.+44 (0) 20 7930 3839 or + 44 (0)7710 328 627 or +44 (0)7956 968 284 [email protected] [email protected] www.stephenongpin.com www.peppiattfineart.co.uk 1 We are delighted to present our ninth annual Winter catalogue of One Hundred Drawings and Watercolours, which will, as usual, be accompanied by an exhibition in our London gallery. This catalogue includes a wide range of British and European drawings and watercolours, placed more or less in chronological order, ranging in date from the 16th century to the first half of the 20th century. Although the areas of Old Master drawings, early British drawings and watercolours, and 19th and 20th Century drawings have long been regarded as disparate fields, each with their own enthusiasts, part of the purpose of this annual catalogue is to blur the distinction between these collecting areas. The works we have selected for this catalogue will show that a fine drawing or watercolour – whoever the artist and whatever the date - is always worthy of note. -

Capitani Di Un Esercito Milano E I Suoi Collezionisti Capitani Di Un Esercito Milano E I Suoi Collezionisti
CAPITANI DI UN ESERCITO MILANO E I SUOI COLLEZIONISTI CAPITANI DI UN ESERCITO MILANO E I SUOI COLLEZIONISTI a cura di Elisabetta Staudacher © 2017 Gallerie Maspes srl tutti i diritti riservati CAPITANI DI UN ESERCITO MILANO E I SUOI COLLEZIONISTI 20 ottobre - 20 dicembre 2017 Gallerie Maspes via Manzoni, 45 20121 Milano con il patrocinio di Gallerie Maspes Progetto espositivo a cura di Catalogo a cura di L’Editore e il Curatore ringraziano sentitamente: Francesco Luigi Maspes Elisabetta Staudacher Amministratore Unico Giulia Amato, Manuela Andreano, Martina Bastianelli, Pierangela Maggiora Mostra a cura di Comitato scientifico Diego Brambilla, Cristina Cappellini, Silvia Capponi, Elisabetta Staudacher Nicoletta Colombo Cesare Cerea, Massimo e Gabriele Ciaccio, Ferdinando Direttore Sergio Rebora Colombo, Clementina Conte, Stefania Cresta, Andrea Francesco Luigi Maspes Segreteria organizzativa Elisabetta Staudacher Crozza, Filippo Del Corno, Manuela Diano, Angelo e Elena Orsenigo Serafino Enrico, Emanuele Fiano, Valentina Galimberti, Responsabile spazio espositivo Schede a cura di Alessia Gillardi, Lorella Giudici, Roberto Gollo, Piero e Relazioni esterne Restauri Benedetta Brison Guy, Roberto Maroni, Luca Melloni, Claudia Palma, Elena Orsenigo Enrica Boschetti, Milano Elisabetta Chiodini Simone Percacciolo, Domenico Piraina, Sonia Rendo, Elena Di Raddo Giuseppe Sala, Alessandra Sartori, Fabrizio Spada, Responsabile Archivio e Biblioteca Assicurazioni Luisa Martorelli Angelo Tadini, Anna Vecchi, Luisa Vitiello. Melissa Raspa Ciaccio Broker, -

The Head of a Youth Charcoal, Black Chalk and Pastel, on Light Brown Paper
Francesco Paolo MICHETTI (Tocco di Casauria 1851 - Francavilla al Mare 1929) The Head of a Youth Charcoal, black chalk and pastel, on light brown paper. Signed FP Michetti at the lower right. 463 x 354 mm. (18 1/4 x 13 7/8 in.) As one Italian writer has aptly noted, ‘The Abruzzi landscape truly spoke to Michetti’s heart with its many voices; he heard them all and absorbed them all. The sea and the mountains, the local festivals so full of colour, of movement, of joy, the mystic processions, the pageantry of superstition and faith in the naves of the solemn age-old cathedrals and of the silent basilicas, the peaceful labour in the fields, the olive- clad hills, the people with their keen sensitiveness and their primitive tenacious passions, deeply impressed his feelings; in black-and-white or in colour, in innumerable marvellous drawings and in paintings of unforgettable beauty and imperishable interest he expressed the fascination, the poetry, the sweetness and the ruggedness, the character and the variety of those scenes. He was indeed a sublime interpreter of the Abruzzi and of their people, whose faces and souls he portrayed in fundamental and everlasting lines.’ This striking pastel study may be related to one of the seated onlookers in Francesco Paolo Michetti’s very large painting of The Daughter of Jorio of 1895, in the Palazzo della Provincia in Pescara, of which a somewhat smaller variant is in a private collection. The subject of Michetti’s painting was inspired by a scene he and his friend Gabriele d’Annunzio witnessed in the artist’s home town of Tocco di Casauria one summer day, when a young woman, dressed in red, was chased through the town square by a number of drunken farm labourers. -

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO 29 NOVEMBRE 2017 GE235-36 Wannenesgroup.Com Lotto 929
DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO XIX DEL E ANTICHI DIPINTI 29 NOVEMBRE 2017 DIPINTI ANTICHI GE235-36 E DEL XIX SECOLO wannenesgroup.com GENOVA, 29 NOVEMBRE 2017 lotto 929 1 2 DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO GENOVA, 29 NOVEMBRE 2017 OLD MASTERS AND 19TH CENTURY PAINTINGS GENOA, 29 NOVEMBER 2017 ASTA $ AUCTION ESPOSIZIONE $ VIEWING Genova Genova Palazzo del Melograno Palazzo del Melograno Piazza Campetto, 2 Piazza Campetto, 2 MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE Wednesday 29 November VENERDÌ 24 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Prima Tornata Friday 24 November ore 14 lotti 601 - 817 10am to 1pm - 2 to 6pm First Session at 2pm lots 601 - 817 SABATO 25 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Seconda Tornata Saturday 25 November ore 17.30 lotti 818 - 929 10am to 1pm - 2 to 6pm Second Session at 5.30pm lots 818 - 929 DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Terza Tornata Sunday 26 November ore 21 lotti 930 - 1059 10am to 1pm - 2 to 6pm Third Session at 9pm lots 930 - 1059 LUNEDÌ 27 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Monday 27 November 10am to 1pm - 2 to 6pm La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo in copertina: I lotti potranno essere ritirati a partire da Giovedì 30 Novembre esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097 lotti 753 e 1004 Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. The lots may be collected from Thursday 30 November by telephone appointment calling +39 010 25 300 97. -
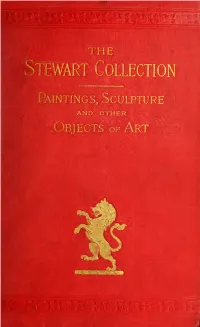
A.T. Stewart Collection of Paintings, Sculptures, and Other Objects Of
;tion TT : DTTTO s &Sfe& m w \j "_mfm £ Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from LYRASIS Members and Sloan Foundation http://archive.org/details/atstewOOamer CATALOGUE OF THE A.T.Stewart Collection OF PAINTINGS, SCULPTURES, AND OTHER OBJECTS OF ART T^O BE SOLD BY AUCTION, WITHOUT RESERVE BY ORDER OF HENRY HILTON, ESQ., AND CHARLES CLINCH, ESQ., EXECUTORS OF THE ESTATE OF MRS. CORNELIA M. STEWART, DECEASED r\N WEDNESDAY, THURSDAY, AND FRIDAY EVENINGS ^ MARCH TWENTY-THIRD, TWENTY-FOURTH, AND TWENTY-FIFTH, AT 7.30 O'CLOCK, AT CHICKER1NG HALL, FIFTH AVENUE AND EIGHTEENTH STREET /CONTINUING MONDAY, MARCH TWENTY-EIGHTH ^ AND FOLLOWING DAYS, AT THE AMERICAN ART GALLERIES, No. 6 EAST TWENTY-THIRD STREET (MADISON SQUARE SOUTH) \ \ fHERE THE COLLECTION WILL BE ON PUBLIC ' EXHIBITION, DAY AND EVENING, FROM MONDAY, FEBRUARY TWENTY-FIRST, UNTIL DATE OF SALE (SUNDAYS EXCEPTED) AMERICAN ART ASSOCIATION, MANAGERS THOMAS E. KIRP.Y, AUCTIONEER NEW YORK: MDCCCLXXXVII Copyright, 1887, By AMERICAN ART ASSOCIATION, NEW YORK. [All rights reserved] COMPILED liY THOMAS E. KIKHY. PRESS OK J. J. LITTLE ft CO., ASTOR PLACE, NEW YORK. ORDER OF SALE. Wednesday Evening, March 23D, at 7.30 o'clock, at Chickering Hall, corner of Fifth Avenue and 18th Street, Modern Paintings. Catalogue Nos. 1 to 74, inclusive. Thursday Evening, March 24TH, at 7.30 o'clock, at Chickering Hall, Modern Paintings. Catalogue Nos. 75 to 143, in- clusive. Friday Evening, March 25TH, at 7.30 o'clock, at Chickering Hall, concluding sale of Paintings. Catalogue Nos. 144 to 217, inclusive. Monday Afternoon, March 28th, at 2.30 o'clock, at The Amer- ican Art Galleries, 6 East 23d Street, Madison Square, South, Sevres, Royal Worcester, and other European Ceramics, Miscellaneous Objects, etc. -

Domenico Morelli E L'arte Sacra Dell'ottocento
2 A me 3 “I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi e resistenti”. Luis Sepúlveda 4 Uno speciale grazie a Giovanna Capitelli, per l’intensità con cui si dona e la preziosa guida. Si ringraziano Gianfranca Florio, Musei Ascoli; Anna Goddi, Biblioteca ISRE; Alesssandro Bertinotti, Biblioteca Negroni Novara; Federica Centulani, Biblioteca di Palazzo Mocenigo, Venezia; Gabriella Benaglio, Biblioteca Lecco; Marcello Graziosi, Biblioteca di Vignola; Eleonora Pomes, Biblioteca Provinciale S. Teresa dei Maschi - De Gemmis, Bari; Marco Notarfonso, Dirigente Servizio Biblioteche, Latina; Morena Medri, Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi, Lugo; Antonella Torazzi, Biblioteca Provinciale L’Aquila; Flora Dibenedetto, Biblioteca Comunale “S. Loffredo”, di Castello; Lucio De Matteis, Biblioteca "B. Molajoli" della Sopr. Spec. per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, Napoli; Maddalena Piras, biblioteca Decastro; Palmira Panedigrano, Ufficio Manoscritti e Rari, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze; Liliana Bilello, Roma Capitale – Istituzione Biblioteche, Biblioteca Olgiate Olona; Biblioteca Rispoli, Roma; Giuseppe D'Errico, Ufficio Riproduzioni, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; F. Fraschini, Biblioteca Comunale Centrale "Palazzo Sormani" Milano; Davide Ravaioli, Fondazione Federico Zeri Biblioteca, Convento di Santa Cristina, Bologna; Massimo Caporalini, Biblioteca comunale Planettiana – Jesi; Laura Colombi, Biblioteca Labronica "F.D. Guerrazzi" -

Piano Di Gestione Del Complesso
MANAGEMENT MANAGEMENT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA PLAN BENINCASA Piano di gestione Management plan UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PIANO DI GESTIONE Management Plan © Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 2016 Tutti i diritti sono riservati isbn 978-88-96055-67-0 INDICE CONTENTS Editorial team Premessa 9 Ideazione e coordinamento Concept and coordination Premise Lucio d’Alessandro Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa Rector of Suor Orsola Benincasa University 1. 13 Progettazione e modello di gestione Design and management model Introduzione e obiettivi del Piano Luisa Bocciero Introduction and objectives of the Plan 1.1 Introduzione Introduction 15 Credits 1.2 Obiettivi del Piano di gestione Goals of the Management Plan 17 Realizzazione modelli vettoriali e 3D Vector models and 3D 1.3 I Princìpi informatori del PDG The inspiring principles of the MP 21 Leopoldo Repola Alfredo Cerrato 1.3.1 Le parole-chiave Keywords 21 Ricerca iconografica Image research 1.4 Gli assi di intervento e la struttura del PDG Axes of Intervention: MP structure 23 Loredana De Simone Daniela Signoretti Germana Pecoraro 1.4.1 I principi Unesco Unesco principles 23 Raccolta dati statistici e relazione sociologica Statistics collection and sociological report 2. 27 Stefania Ferraro Giampaolo di Costanzo Anna D’Ascenzio Il Progetto di conoscenza. Studi e ricerche Editing italiano Editor (Italian text) Giuseppina Della Sala Fact-finding study and research project 2.1 Analisi e conoscenza del territorio Study and knowledge of the area 29 Traduzione testo in inglese English translation Adrian Bedford 2.1.1 Ubicazione Location 29 Immagini originali Original images 2.1.2 Accessibilità Accessibility 31 Peppe Avallone (pp. -

Studiobibliografico G.Lombardi
BOLLETTINO N. 2/2020 1 ibliografico G. Lo io B mba tud rd S i Mondadori, 1939, 8°, pp. 726, con 32 ill. f. t. Biografie e 2 tavv. genealogiche più volte ripieg, leg. ed. t. tela, sovracc. fig. € 18,00 1 (Biografia) ALBERTINI A. - Beethoven. L’uomo. Torino, Bocca, 1931, 8°, pp. IX-264, 11 (Biografia - Trento) BILLERI Paolo - Vita con 15 tavv. f. t. ed elenco e date delle prin- del beato Stefano Bellesini, parroco agosti- cipali composizioni. € 15,00 niano. Roma, Tip. Poliglotta, 1904, 8, pp. 287, ritratto del Beato all’antip., leg. mz. pel- 2 (Biografia) ANONIMO ROMANO - Vita di le. € 35,00 Cola di Rienzo. A cura di Arsenio Frugoni. Il Beato B. fu nominato dal governatore au- Firenze, Le Monnier, 1957, 16°, pp. 227, con striaco direttore generale delle scuole del un ritratto in antip., fioriture in cop., inton- Trentino. so. € 15,00 12 (Biografia) BIRKENFELD Gunther - Au- 3 (Biografia) ARCARI Paolo - Parini. Milano, gusto. Il romanzo della sua vita. Milano, Agnelli, 1929, 8°, pp. 263, con 4 tavv. f. t. Bompiani, 1937, 8°, pp. 376. € 15,00 € 15,00 13 (Biografia) BIZZARRI Edoardo - Il Ma- 4 (Biografia) ASSANTE Franca - Giovan gnifico Lorenzo. Verona, Mondadori, 1950, Battista Maria Jannucci. L’uomo e l’opera. 8°, pp. 376, con 12 tavv. f. t., leg. ed. cart., Napoli, Giannini, 1981, 8°, pp. 312, con 5 sovracc. fig. € 20,00 facsimili f. t. € 25,00 14 (Biografia) BRANDI C. - Charles Quint 5 (Biografia) B. H. LIDDELL Hart - Un uomo 1500 - 1558. Traduit de l’allemand par Guy più grande di Napoleone. -

INVENTARIO ANALITICO Ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl Zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqNota biografica wertyuiopasdfghjklzxcvb nmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Archivio Contemporaneo tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty“Alessandro Bonsanti” Gabinetto G.P. Vieusseux uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui(http://www.vieusseux.it/archivio-contemporaneo.html) opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopFondo asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasNello Tarchiani dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf- INVENTARIO ANALITICO ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm a cura di Ambra Spaccasassi Firenze, 2017 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 0 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui Fondo Nello Tarchiani – Inventario analitico NELLO TARCHIANI NOTA BIOGRAFICA Nello Tarchiani, noto critico d’arte e funzionario nel settore delle Belle Arti, ha costituito una delle figure più significative del panorama artistico fiorentino durante la prima metà del Novecento. La sua grande notorietà deriva principalmente dalle occupazioni e dai numerosi interventi praticati in ambito culturale e artistico, lo studio dei quali ha permesso di comprendere almeno in parte la sua figura di “uomo pubblico”. In effetti vi sono molti testi relativi ai progressi nella gestione e tutela dei beni culturali, in particolare a Firenze, come anche saggi relativi alla critica d’arte del secolo scorso, che fanno riferimento alla figura di Nello Tarchiani e che ci permettono di capire alcuni aspetti del suo lavoro e i principali contributi che in questo