Opera Ipogea 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

J-Ils-Ug Orb Dolirish Tioniiis for Gnimskamf I Smatta
J-ilS-Ug orb Dolirish tioniiis for gnimskamf i Smatta. VOL. 50. NO. 23. ' CHICAGO, ILL.. TISDAQEN DEN 8 Jl'N'I I9S6, LÖPANDE N:R 233_ han» himmelska .liva mil att bedja Jesua vir it_ K»are hade ett | Ack denna obegriplig» fraktan för dam. Röster som ropa. Saliga aren I. underbart namn, t.v han var en un Iför Jesua! derbar person. Profeten Jesaja, .Vir Herren uppfor till himme Av fr. Peyrem. Dn, aom kastas ankring på vari Av Frank Mängs. llen, övergav han icke de aina. Nej, sinn profeterade om hans komman 'dens vida hav med daa tusentala han kommer väl ihåg dem. han de minst sju hundra ir innan han r r Röster höras från alla hill oeh i * ~' på skummande vig. var inte Luk. 6: 20—26. tänker dagligen och stundligen på kom, nämnde om honom och kal sök» tränga aig in i •*s—»tni__nt-i rädd för Jesus! Inbjud honom och dem. Märkena i han» händer äro lade bonom "L'ndet-ba r " Han •»jäl, men bullret av denn» värl- ••** >«*-«i med ombord, ty vinden, Det " ett **?<*** egendomligt Böin om sommaren. liksom en skrift, där hans lärjun var underbar uti sin kärlek, ty han den* «ynelsättningar, passionerna» ** dig ««»t- Han är den ende. •'ud»-"P- «~» Hi™ Jesus i da* gars namn äro upptecknade. har «lakat oaa och älakar oas ännu larm ooh de olika int tsv-! *-~* kan föra ditt livs farkost lyck möter oa» med. Aldrig nigonau» Mi du komma ihåg detta «Us i dag. Märk att det heter, au han lingakamp äro si bedövande, au lig, j hamn genom döden» bran ha vi väl hört denns världen* visa Mäktigt strömma livets flöden dagar och isynnerhet i de mörka "älskar oss'. -

Accra Technical University 20
ACCRA TECHNICAL UNIVERSITY TH 20 CONGREGATION – DECEMBER, 2020 LIST OF GRADUATING STUDENTS HIGHER NATIONAL DIPLOMA HND SECRETARYSHIP & MANAGEMENT STUDIES FIRST CLASS ALLAN, GIFTY ANEEBA OPARE, JULIANA ADJOA SECOND CLASS UPPER DIVISION ABABAGRE, JANET ABAYE, SANDRA ADZO ABBEY, NAOMI NAA ABLORDEPPEY, SENA ABUBAKAR, MUHIBA ABUBAKARI, NAIMA ACHEAMPONG, BELINDA ACQUAH, NANA EFUAH ADDO, GLADYS ADDY, DEBORAH BLESSING AFANKWAH, QUEENSTER AGAMAH, EUNICE YAWA AGBEVE, DORA AGBOLUSU, MAWUSI AGYAPONG, PRINCESS AGYEI, EDWINA AKOSUA AGYEI, RITA NYARKOA AIDOO, REBECCA ADJOWAH AKAI, SARAH AKOMAH, EUNICE TSORMANAH AKYEAMPONG, NAOMI OLOLADE AMANKWAH, ELIZABETH AMEGASHIE, ALFRED KWAKU AMEMAA, RUTH AMETEPEY, MIRIAM OGBO AMLI, GODWIN KORBLA AMO, STELLA AMOAH, ABIGAIL OPPONG AMPONSAH, GLORIA AMPONSAH, HENRIETTA AKOSUA AMPONSAH, NANA KWAME NYAMEKYE ANKRAH, SHIRLEY NAA TSUBAH ANNAN, JOYCELYN AKAIBI ANONGBA, BRIDGET ANSAH, DOROTHY APPIAH, ALICE ADWOA KOBOWA APPIAH, SANDRA ARHINFUL, MERCY ARKO-BAAH, DOROTHY ARKOH, VIDA ARKU, FRANCISCA ARTHUR, GIFTY ARTHUR, PRINCESS MARY BAMFOA ASAMOAH, MILLICENT ASARE, SANDRA ASIEDU, ANGELA ASOMANING, EMMANUEL MINTAH AVEVOR, EMILY EMEFA BANFUL, ABRAHAM SARKODIE BENTIL, FATIMA BONAPARTE, BERNICE NAABARKEY BOYE, LINDA AKUORKOR BROWN, JESSE QUAYE CLOTTEY, KENNETH AARON ATTUQUAYE DADZIE, SIMON DAMALIE, EDITH DANQUAH-SMITH, MARGARET DANSO, ELSIE SOMUAH DANSO, LINDA ASIEDUA DARKO, KINGSLEY KWABENA DARKO, NANA KORANG DOKU, NINA ADAI DOMPREH, CHRISTINA DONKOR, ALICE DONKOR, CHARLENE DORGBETOR, FRANCISCA DORNU, RAYMOND PAPAA DUGBLE, -

IDE.MS1 UNIVERSITY of MUMBAI PAGE : 17 OFFICE REGISTER for M.Sc
IDE.MS1 UNIVERSITY OF MUMBAI PAGE : 17 OFFICE REGISTER FOR M.Sc. (PART I) EXAMINATION - APRIL 2015 DATE : AUGUST 4 2015 COLLEGE : 279 I.D.O.L.UNIVERSITY-KALINA ================================================================================================================================== SEAT NO NAME PAPER-I PAPER-II PAPER-III PAPER-IV PAPER-V TH-TOT. U I T U I T U I T U I T U I T CENTRE PRAC-I PRAC-II PRAC-III PRAC-IV PR-TOT GR-TOT REMARK ================================================================================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBJECT (40) : MATHEMATICS (SCHEME-A) I-100/25; II-100/25; III-100/25; IV-100/25; V-100/25; 500/200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 /ANSARI SHAZIA LAL MIYA NOORUNNISA -- -- 01F -- -- 14F -- -- 02F -- -- 00F -- -- 12F 029F MUMBAI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 029 F ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 /BIRAJDAR KALPANA SHIVAJI LAXMI -- -- 04F -- -- 41 -- -- 07F -- -- 00F -- -- 40 092F MUMBAI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 092 F ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 DESHMUKH MONESH DESHMUKH SINDHU -- -- A -- -- A -- -- A -- -- A -- -- A A MUMBAI -
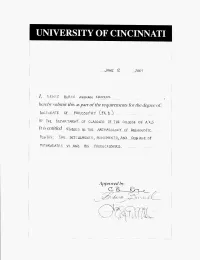
Studies in the Archaeology of Hellenistic Pontus: the Settlements, Monuments, and Coinage of Mithradates Vi and His Predecessors
STUDIES IN THE ARCHAEOLOGY OF HELLENISTIC PONTUS: THE SETTLEMENTS, MONUMENTS, AND COINAGE OF MITHRADATES VI AND HIS PREDECESSORS A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph.D.) In the Department of Classics of the College of Arts and Sciences 2001 by D. Burcu Arıkan Erciyas B.A. Bilkent University, 1994 M.A. University of Cincinnati, 1997 Committee Chair: Prof. Brian Rose ABSTRACT This dissertation is the first comprehensive study of the central Black Sea region in Turkey (ancient Pontus) during the Hellenistic period. It examines the environmental, archaeological, literary, and numismatic data in individual chapters. The focus of this examination is the central area of Pontus, with the goal of clarifying the Hellenistic kingdom's relationship to other parts of Asia Minor and to the east. I have concentrated on the reign of Mithradates VI (120-63 B.C.), but the archaeological and literary evidence for his royal predecessors, beginning in the third century B.C., has also been included. Pontic settlement patterns from the Chalcolithic through the Roman period have also been investigated in order to place Hellenistic occupation here in the broadest possible diachronic perspective. The examination of the coinage, in particular, has revealed a significant amount about royal propaganda during the reign of Mithradates, especially his claims to both eastern and western ancestry. One chapter deals with a newly discovered tomb at Amisos that was indicative of the aristocratic attitudes toward death. The tomb finds indicate a high level of commercial activity in the region as early as the late fourth/early third century B.C., as well as the significant role of Amisos in connecting the interior with the coast. -

SI-10022011-Form IEPF-2
Note: This sheet is applicable for uploading the particulars related to the unclaimed and unpaid amount pending with company. Make sure that the details are in accordance with the information already provided in e-form IEPF-2 CIN/BCIN Company/Bank Name Date Of AGM(DD-MON-YYYY) L28920MH1957PLC010839 Prefill SIEMENS LIMITED 06-FEB-2018 Sum of unpaid and unclaimed dividend 4671265.00 Sum of interest on matured debentures 0.00 Sum of matured deposit 0.00 Sum of interest on matured deposit 0.00 Sum of matured debentures 0.00 Sum of interest on application money due for refund 0.00 Sum of application money due for refund 0.00 Redemption amount of preference shares 0.00 Sales proceed for fractional shares 0.00 Validate Clear Proposed Date of Investor First Investor Middle Investor Last Father/Husband Father/Husband Father/Husband Last DP Id-Client Id- Amount Address Country State District Pin Code Folio Number Investment Type transfer to IEPF Name Name Name First Name Middle Name Name Account Number transferred (DD-MON-YYYY) AFTAB AHMAD NA SECTOR 20 H NO 139 INDRANA LUCKNOWINDIA U P Uttar Pradesh 226016 0000000000SIA0000007 Amount for unclaimed and unpaid Dividend1,400.00 02-MAR-2018 ANIMA BANERJEE NA 36/A AMMERST ROW CALCUTTA INDIA West Bengal 700009 0000000000SIA0000070 Amount for unclaimed and unpaid Dividend10,500.00 02-MAR-2018 ABANTIKA DAS NA BD396 SECTO 1 BIDHAN NAGAG SALTINDIA LAKE CITY CALCUTTA West Bengal 700064 0000000000SIA0000201 Amount for unclaimed and unpaid Dividend7,000.00 02-MAR-2018 AJMAL HUSAIN SYED NA HAQ CONSULTANTS BAITUL -
Mitos Y Leyendas De Colombia
PARTE I MITOLOGÍA INDÍGENA MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA VOLUMEN I Eugenia Villa Posse Para facilitar ia lectura, se ha incluido en el primer tomo la bibliografía general de la obra. COLECCIÓN "Integración cultural" MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA Investigación y compilación Eugenia Villa Posse ISBN 9978-60-003-5 ISBN 9978-60-004-3 (Tomo I) Editonal © IADAP Diego de Atienza y Av. América Telfs : 553684 - 554908 Fax : 593.2.563096 Apartados postales: 17-07-9184 / 17-01-555 Quito-Ecuador Derechos reservados conforme a la ley Primera edición, agosto 1993, 1000 ejemplares DIRECTOR EJECUTIVO Eugenio Cabrera Merchán COORDINADOR DIFUSIÓN Víctor Manuel Guzmán DIAGRAMACION Y PORTADA Wilfrido Acostó Pineda LEVANTAMIENTO DE TEXTOS Nelly Jiménez Viana IMPRESIÓN Washington Padilla M. III JUSTIFICACIÓN MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA, constituye otro aporte editorial que el Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés Bello -IADAP- pone en circulación como resultado de la ejecución de su Programa de Difusión de la Cultura Popular. El trabajo compilatorio en tres tomos ha sido preparado por la antropóloga Eugenia Villa Posse. El I Tomo se refiere a "Mitología Indígena"; el II "Leyendas y Cuentos del Folclor"; y el III corresponde a "Mitos Prehispánicos Muiscas". El IADAP, se permite expresar su reconocimiento y gratitud a la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, bajo cuya orientación y auspicio se realizó la obra y a nuestra distinguida amiga Eugenia Villa Posse, lamentando que la edición haya tenido un involuntario retrazo. Quito, agosto de 1993 La Dirección Ejecutiva V EL MITO Y LA LEYENDA Selección de textos de la literatura oral colombiana Antropóloga: Eugenia Villa Posse 1 . -

Iullemeden Aquifer System Report
Integrated and Sustainable Management of Shared Aquifer Systems and Basins of the Sahel Region RAF/7/011 IULLEMEDEN AQUIFER SYSTEM 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION EDITORIAL NOTE This is not an official publication of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The content has not undergone an official review by the IAEA. The views expressed do not necessarily reflect those of the IAEA or its Member States. The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the IAEA as to the legal status of such countries or territories, or their authorities and institutions, or of the delimitation of their boundaries. The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA. INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION REPORT OF THE IAEA-SUPPORTED REGIONAL TECHNICAL COOPERATION PROJECT RAF/7/011 IULLEMEDEN AQUIFER SYSTEM COUNTERPARTS: Mr Adnane Souffi MOULLA (Algeria) Mr Abdelwaheb SMATI (Algeria) Mr Philippe Armand ADJOMAYI (Benin) Mr. Moussa BOUKARI (Benin) Mr Aly THIAM (Mali) Mr Sidi KONE (Mali) Mr Sanoussi RABE (Niger) Mr Ismaghil BOBADJI (Niger) Mr Christopher Madubuko MADUABUCHI (Nigeria) Mr Adegboyega Albert ADEDEJI (Nigeria) EXPERT: Mr Kamel ZOUARI (Tunisia) Reproduced by the IAEA Vienna, Austria, 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION Table of Contents 1. -

MUSLIM MAFIA This Page Intentionally Left Blank MUSLIM MAFIA
MUSLIM MAFIA This page intentionally left blank MUSLIM MAFIA INSIDE THE SECRET UNDERWORLD THAT’S CONSPIRING TO ISLAMIZE AMERICA BY P. DAVid Gaubatz and Paul SperrY MUSLIM MAFIA WND Books Published by WorldNetDaily Los Angeles, CA Copyright © 2009 by P. David Gaubatz and Paul Sperry All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, scanning, or otherwise, without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Jacket design by Linda Daly WND Books are distributed to the trade by: Midpoint Trade Books 27 West 20th Street, Suite 1102 New York, NY 10011 WND Books are available at special discounts for bulk purchases. WND Books, Inc. also publishes books in electronic formats. For more information call (310) 961- 4170 or visit www.wndbooks.com. ISBN 13-Digit: 9781935071105 ISBN 10-Digit: 1935071106 E-Book ISBN 13-Digit: 9781935071648 E-Book ISBN 10-Digit: 1935071645 Library of Congress Control Number: 2009931566 Printed in the United States of America 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I dedicate this book to the innocent children of all races, religions, and cultures who are the ultimate victims of the errors of adults from all races, religions, and cultures. —P. David Gaubatz Dedicated to the memory of H. Baldwin Sperry —Paul Sperry This page intentionally left blank A note of caution from the authors This is not a book about Islam or Muslims in general. It is about the threat from Shariah Islam and violent jihad propagated by a criminal class of Muslims known as the Muslim Brotherhood or the “Ikhwan mafia.” This secretive organization dominates most established Muslim groups and mosques in America while exploiting, manipulating, and even victimizing law-abiding Muslim Americans. -

Grudzień 2019 Nr 9/2019 • Miesięcznik Gminy Gniewkowo Nakład 3000 Egz
GRUDZIEŃ 2019 NR 9/2019 • MIESIĘCZNIK GMINY GNIEWKOWO NAKŁAD 3000 EGZ. • ISSN 1233-9539 SŁOWO WSTĘPNE czór, kiedy panuje niepowtarzalny, składam Wam w imieniu redakcji magiczny klimat: unosi się zapach najserdeczniejsze życzenia: dużo cie- SPIS TREŚCI świerku i pierników, słychać śmiech pła w gronie rodziny, radości i zdro- i radość dzieci, migoczą światła na wia, by w przyszłym roku z optymi- Grudzień 2019 naszej choince. Jest to wieczór, gdy zmem wejść w nowy 2020 ROK. nabieramy sił i wiary, że nic nie jest I jeszcze Wam Wszystkim, którzy Słowo wstępne 3 ważniejsze od naszych najbliższych, czytacie nasz biuletyn, podziękować Redaktor naczelna Katarzyna Milewska 3 że wszystko od jutra będzie łatwiej- za ten rok, za to, że razem z zespo- sze i prostsze, bo mamy przecież sie- łem redakcyjnym mogliśmy razem Ważny temat 3 bie. I mamy nadzieję, że dzięki temu z Wami i dla Was współtworzyć Drodzy Czytelnicy Tajemniczy medal 3 szczególnemu nastrojowi wszystkie strony tego pisma. Za wszelkie nie- Zbliżamy się do końca 2019 roku. kolejne, nadchodzące przyszłe dni dociągnięcia, które się pojawiły, Z Urzędu Miejskiego 5 Jest to czas podsumowań, refleksji, będą łatwiejsze do pokonania. przepraszam. Dzisiaj jest też oka- obietnic i postanowień na przyszły Życzenia 5 Tego każdemu z Was życzę! zja, aby podziękować każdemu, kto rok. Jest to czas, kiedy zbliża się ten przyczynił się do tego, by nasz perio- Podsumowanie 6 jedyny raz w roku wieczór, na któ- My również, jako „Gniewkorama” dyk mógł się ukazywać, znajdować ry wszyscy z utęsknieniem czeka- Informacje z obrad sesji 8 chcemy „wkraść” się do Waszych do- się w punktach kolportażu, być roz- my – Wieczór Wigilijny. -

CIN/BCIN Company/Bank Name Date of AGM(DD-MON-YYYY)
Note: This sheet is applicable for uploading the particulars related to the unclaimed and unpaid amount pending with company. Make sure that the details are in accordance with the information already provided in e-form IEPF-2 CIN/BCIN L85195TG1984PLC004507 Prefill Company/Bank Name DR.REDDY'S LABORATORIES LTD Date Of AGM(DD-MON-YYYY) 27-JUL-2016 Sum of unpaid and unclaimed dividend 6887580.00 Sum of interest on matured debentures 0.00 Sum of matured deposit 0.00 Sum of interest on matured deposit 0.00 Sum of matured debentures 0.00 Sum of interest on application money due for refund 0.00 Sum of application money due for refund 0.00 Redemption amount of preference shares 0.00 Sales proceed for fractional shares 0.00 Validate Clear Proposed Date of Investor First Investor Middle Investor Last Father/Husband Father/Husband Father/Husband Last DP Id-Client Id- Amount Address Country State District Pin Code Folio Number Investment Type transfer to IEPF Name Name Name First Name Middle Name Name Account Number transferred (DD-MON-YYYY) NEETA NARENDRA SHAH NA NA NA CHANDRIKA APT.,SHINGADA TALAV,W.NO.4016,,NASIKINDIA MAHARASHTRA NASIK DPID-CLID-1201750200019180Amount for unclaimed and unpaid dividend150.00 30-AUG-2020 ARUN KUMAR RADHAKRISHAN A-40,(60.MEATER),POCKET-00,,SECTOR-2,ROHINI,DELHIINDIA Delhi Delhi FOLIOA00001 Amount for unclaimed and unpaid dividend180.00 30-AUG-2020 AVINASH BALWANT DEV BALWANT 1 JASMIN APARTMENTS,NEW PANDITINDIA COLONY GANGAPUR ROAD,NASIK,NASIKMAHARASHTRA NASIK FOLIOA00403 Amount for unclaimed and unpaid dividend60.00 30-AUG-2020 A RAVI KUMAR A KAMESWAR RAO DR. -

KOMNENOS'lar DEVLETİ a K D E N I Z K a R a D E N
Drava Sava DALMAÇYA S Sõrmium IR Belgrad M Zara I KHERSONESTheodosia U M (Kaffa) TH Khersones Spolatto Vidin KAFKASYA Tuna Silistria P Ras A Pliska Niş R I Nikopolis N Ragusa S T R I O Priştina Trnovo Varna Serdika BALKAN DAĞLARI Mesembria H D I T Pernik Ankhialos Y Skopye Maric Develtos Ú Prizren a( Sozopolis Skadar V M R er A iç I a Philippopolis ) R r Adrianopolis R d Strumika H MAKEDONIA Dyrrhakhion Okhrida ar (Edirne) Bari A A Melnik Prilep Versinikia Bulgarophygon İstanbul PAPHLA- Kars G K Ani Tarento Prosek Herakleia Prespa LVodena STRYMON Arkadiopolis Trabzon O OPTIMATON 1045’den Serrnes Khalkedon GONIA K I A IBERIA Brõndisi U H A L D Dvin AvlonaN Selymbria beri Arakses B THASOS ARMENIAKON THRAKIA Nikomedeia SEBASTEIA Kastoria K Koloneia THEODOSIOPOLISTheodosiopolisVASPURKAN NIKOPOLIS Kallipolis Kyzikos BUKELLARION O L I A Rossano KEPHALLENA Servia Nikaia Dazimon O N E TH. THESSAIONIKE Abydos OPSIKION KORFU LEMNOS Sangarios Adramyttion Ankyra Sebasteia MESOPO- TARON Nikopolis Larissa PELAGOSAIGATON TH ABYDO(Edremit) Dorylaion KAPPADOKIAKHARSIANON HEAKESION ‹TALYA KATERANLI ‹TALYA Mantzikert LESBOS TephrikeTAMIA Messina Pergamon Kaisareia Melitene HELLAS ANATOLIKONAmorion LYKANDOS KEPHALLENIA EUBOA MELITENE Martyropolis Sardes Arabissos Taormina Thebal KHIOS Zapetra KHIOS Smyrna aiand FIRAT Korinthos M r Ikonion Hadat Amida ZAKYNTHOS Athenae ANDROS Ephesos os Germanikeia ÞEH‹RLER‹ PELOPONNESOS THSAMOS Tyana Samosata Dicle Syrakusa H Anazarbos Nisibis SAMOS T Miletos TELUKH Edessa K I B Y R A I O T Adana NAKSOST O Telukh Harran N Tarsos H Attaleia KILIKIA KOS SELEUKEIA T Musul Antiokheia A Seleukeia I Halep Fõrat RHODOS E Laodikeia H K O KRETA RaphaneaI T KYPROS N Tripolis A Emesa II. -

Kappadokia Kralliği Ve Roma-Bizans Dönemi
KAPPADOKİA KRALLIĞI VE ROMA-BİZANS DÖNEMİ HALİT ERKİLETLİOĞLU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları TARİH DİZİSİ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 157 Kappadokia Krallığı ve Roma-Bizans Dönemi Halit Erkiletlioğlu Bu kitap KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin bir kültür hizmetidir. Eserin tüm hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan kullanılamaz. Birinci Baskı: Aralık 2019 ISBN: 978-605-9117-40-1 Yayın Koordinatörü: Salih ÖZGÖNCÜ Erkan KÜP Yayın Yürütme Kurulu: Mustafa ERDOĞDU Maide GÜZELOĞLU Tasarım: www.bilgegrafik.com Kapak: Ali Saraçoğlu Baskı ve Cilt: Orka Matbaacılık, İnecik Mah. Çırağan Sk. No: 4 Melikgazi / KAYSERİ / [email protected] T.: +90 352 322 17 00 Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı T.: +90 352 220 70 90 KAPPADOKİA KRALLIĞI VE ROMA-BİZANS DÖNEMİ HALİT ERKİLETLİOĞLU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları TARİH DİZİSİ HALİT ERKİLETLİOĞLU ve Türkiye Yazarlar Birliği üyelikleri görevlerini yürütmüştür. Halit Erkiletlioğlu 28 Nisan 1945 Kayseri Dil, tarih ve sanat tarihi konularında yüzlerce doğumludur. Sümer İlkokulu, Sümer Ortaokulu ve yazı, makale ve incelemesi, Erciyes, Kültür- Kayseri Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1969 yılında da Sanat, Hakses, Tarih ve Edebiyat, Tarih, Selçuk, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden Yeni Düşünce, Türk Dünyası Dergisi, Anadolu mezun oldu. İslâhiye’de askerlik görevini yedek Haber Belsin ve Kayseri Hâkimiyet gibi dergi subay teğmen olarak tamamladı. Bu tarihten ve gazetelerde yayınlandı. Birçok konferans itibaren de oturmakta olduğu Kayseri’de serbest ve sempozyuma ilmî bildirileri ile katıldı. Yerel; olarak 45 sene çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Başak, Erciyes ve Elif, TV 1, Kayseri TV ve OSB Halen bir şirketin ortağı olup, aynı zamanda yerel TV isimli televizyonlar tarih ve kültür programları kültür ve tarih konularında çalışmalarına devam yaptı.