Castelletto Cervo: Cenni Storici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abano Terme Acerra Aci Castello Acqualagna Acquanegra
Abano Terme Alzano Scrivia Azzano San Paolo Belvedere Marittimo Acerra Amelia Azzate Benevento Aci Castello Anagni Bagnaria Benna Acqualagna Ancarano Bagnatica Bentivoglio Acquanegra Cremonese Ancona Bagno A Ripoli Berchidda Adro Andezeno Bagnoli Di Sopra Beregazzo Con Figliaro Affi Angiari Bagnolo Cremasco Bereguardo Afragola Anguillara Veneta Bagnolo Di Po Bergamo Agliana Annicco Bairo Bernareggio Agliano Annone Di Brianza Baone Bertinoro Agliè Antrodoco Baranzate Besana in Brianza Agna Anzola D’Ossola Barasso Besenello Agordo Aosta Barbarano Vicentino Besnate Agrate Brianza Appiano Gentile Barberino Di Mugello Besozzo Agugliano Appiano sulla strada del vino Barberino Val D’Elsa Biassono Agugliaro Aprilia Barbiano Biella Aicurzio Arce Barchi Bientina Ala Arcene Bardello Bigarello Alano Di Piave Arco Bareggio Binago Alba Arconate Bariano Bioglio Alba Adriatica Arcore Barlassina Boara Pisani Albairate Arcugnano Barone Canavese Bolgare Albano Laziale Ardara Barzago Bollate Albaredo Arnaboldi Ardea Barzanò Bollengo Albaredo D’Adige Arese Basaluzzo Bologna Albavilla Arezzo Baselga Di Pinè Bolsena Albese Con Cassano Argelato Basiano Boltiere Albettone Ariccia Basiliano Bolzano Albiano Arluno Bassano Bresciano Bolzano Vicentino Albiate Arquà Petrarca Bassano Del Grappa Bomporto Albignasego Arquà Polesine Bassano In Teverina Bonate Sotto Albino Arre Bastida Pancarana Bonemerse Albiolo Arsago Seprio Bastiglia Bonorva Albisola Superiore Artegna Battaglia Terme Borghetto S. Spirito Albuzzano Arzachena Battuda Borgo San Dalmazzo Aldeno Arzano Baveno -

San Secondo Bennese Memorial FILIPPO TURATI - CC>DD F.N.56 Sab 2 Dom 3 Settembre 2017 Federazione Italiana Bocce - Comitato Provinciale Di BIELLA Girone : 1,1 41-G.B
gironi.b gironi.d gironi.f gironi.h gironi.i San Secondo Bennese Memorial FILIPPO TURATI - CC>DD f.n.56 Sab 2 Dom 3 settembre 2017 Federazione Italiana Bocce - Comitato Provinciale di BIELLA girone : 1,1 41-G.B. VALDENGHESE (NO=1) PETRETTI PIER MARIO-TANCORRE GIORGIO 23-S.B. BASSA VALLE-HELVETIA ASSI YEUILLAZ RODOLFO-VAIROS 23-S.B. BASSA VALLE-HELVETIA OSVALDO ASSI YEUILLAZ RODOLFO-VAIROS OSVALDO 23-S.B. BASSA VALLE-HELVETIA ASSI YEUILLAZ RODOLFO-VAIROS 13-AMICI VAGLIO - S.B. BIELLESE OSVALDO (NO=1) BACCHIN RAFFAELLO- BOTTA RENATO 13-AMICI VAGLIO - S.B. BIELLESE (NO=1) BACCHIN RAFFAELLO- 15-BOCC. VALLE ELVO BOTTA RENATO ARGENTERO ROBERTO-MAGNETTO GUIDO 33-S.B. BOCCE VALDENGO FERRARIS TOLLEGNO COSSA 33-S.B. BOCCE VALDENGO SILVANO-COLIA GIUSEPPE FERRARIS TOLLEGNO COSSA SILVANO-COLIA GIUSEPPE 33-S.B. BOCCE VALDENGO FERRARIS TOLLEGNO COSSA 7-SAN SECONDO BENNESE SILVANO-COLIA GIUSEPPE ANGARAMO MAURO-GIUPPONI ANGELO 33-S.B. BOCCE VALDENGO FERRARIS TOLLEGNO COSSA SILVANO-COLIA GIUSEPPE 24-AMICI BOCCE (NO=1) CURTOLI CESARE-GRAZIANO UGO* 24-AMICI BOCCE (NO=1) CURTOLI CESARE-GRAZIANO UGO* 56-S.B. PRALUNGO (NO=1) GIRELLI CLAUDIO-MONETTA GIANCARLO Zucconelli Zucconelli Zucconelli Zucconelli sole sab 14:00-15:45 sab 16:00-17:45 sab 18:00-19:45 sab 21:30-23:15 girone Vandorno-Str.del Cimitero del Vandorno 5 Vandorno-Str.del Cimitero del Vandorno 5 Vandorno-Str.del Cimitero del Vandorno 5 Benna-via delle Viare lunghe 12 1,1 Zucconelli Zucconelli Zucconelli Zucconelli 0 sab 14:00-15:45 sab 16:00-17:45 sab 18:00-19:45 sab 21:30-23:15 0 Torrazzo-via Per Sala 2 Torrazzo Torrazzo-via Per Sala 2 Torrazzo Torrazzo-via Per Sala 2 Torrazzo Torrazzo-via Per Sala 2 Torrazzo pioggia San Secondo Bennese Memorial FILIPPO TURATI - CC>DD f.n.56 Sab 2 Dom 3 settembre 2017 Federazione Italiana Bocce - Comitato Provinciale di BIELLA girone : 1,2 1-FORNO BURATTO GUIDO-BERTOT EFISIO 36-S.B. -

Linea 300: Biella
LINEA 300 : BIELLA - COSSATO - VALLE MOSSO - PONZONE - TRIVERO ( 300 ) Data Revisione ORARIO VALIDO DAL 31 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2017 - ESCLUSI GIORNI FESTIVI 03.08.2015 1 CON EVENTUALI LIMITAZIONI, INDICATE SULLE SINGOLE CORSE Itinerario in Biella: Piazza San Paolo - Viale Roma - Piazza Adua - Via Torino - Piazza Vittorio Veneto - Viale Matteotti - Via Carducci - Via Marconi - Via Milano Corse garantite in caso di sciopero © © © © Note Codice itinerario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numero corsa 011 017 021 059 023 027 031 067 035 Limitazioni solo nei giorni: BIELLA SAN PAOLO piazza Stazione 7.30 12.30 13.30 14.30 17.10 18.30 19.40 BIELLA piazza V.Veneto (portici) 7.35 12.35 13.35 14.35 17.15 18.35 19.45 BIELLA viale Carducci fr.via Marconi 7.37 12.37 13.37 14.37 17.17 18.37 19.47 BIELLA CHIAVAZZA via Milano, 34 7.40 12.40 13.40 14.40 17.20 18.40 19.50 VIGLIANO B. SE SOBRANO via Milano, 122 7.45 12.45 13.45 14.45 17.25 18.45 19.55 VIGLIANO B. SE via Milano (municipio) 7.48 12.48 13.48 14.48 17.28 18.48 19.58 VALDENGO BELLARIA via Sella/Diaz 7.51 12.51 13.51 14.51 17.31 18.51 20.01 CERRETO C. LLO Ponte Chiebbia 7.55 12.55 13.55 14.55 17.35 18.55 20.05 QUAREGNA SP300 via Martiri 7.57 12.57 13.57 corsa Attende 14.57 17.37 18.57 corsa Attende 20.07 COSSATO viale Pajetta (stazione) 8.00 13.00 14.00 15.00 17.40 19.00 20.10 da da BIELLA da BIELLA COSSATO via Mazzini, 8 8.02 13.02 14.02 15.02 17.42 19.02 20.12 COSSATO Liceo (piazzale) COSSATO via Maffei (fr. -

ASL BI Avviso Pubblico Per Conferimento Incarico Provvisorio
SEDE LEGALE Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) P.IVA 01810260024 Presso i locali della SC PERSONALE IL DIRETTORE TRINCHERO SIMONA in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, ha assunto la seguente determinazione: Determinazione n. 656 in data 14/06/2021 OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROVVISORIO DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE - AMBITO TERRITORIALE COSSATO, LESSONA, QUAREGNA- CERRETO, CASAPINTA, MEZZANA MORTIGLIENGO, STRONA, CASTELLETTO CERVO, MOTTALCIATA, GIFFLENGA, PIATTO, VALDENGO, VIGLIANO Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente. SEDE LEGALE Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) P.IVA 01810260024 Determinazione n. 656 in data 14/06/2021 OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROVVISORIO DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE - AMBITO TERRITORIALE COSSATO, LESSONA, QUAREGNA- CERRETO, CASAPINTA, MEZZANA MORTIGLIENGO, STRONA, CASTELLETTO CERVO, MOTTALCIATA, GIFFLENGA, PIATTO, VALDENGO, VIGLIANO IL DIRETTORE PREMESSO che l’ A.C.N. del 23/03/2005 e ss.mm.ii. disciplina i rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; RILEVATO che con determinazione dirigenziale n.388 del 07/04/2021 è stato indetto un secondo avviso pubblico,(in quanto al precedente di cui alla determinazione n.138 del 08/02/2021 -

Biellese, Terra Di Telai DOSSIER PRINCIPALE
[Digitare il testo] DOSSIER PRINCIPALE BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Biellese, terra di telai Parco diffuso del paesaggio industriale e della tradizione tessile. INDICE 1. TERRITORIO DI RIFERIMENTO A.1 inquadramento geografico generale del Biellese A.2 inquadramento demografico generale del Biellese B.1 Focus sul territorio interessato dal Progetto B.2 Specifiche del territorio interessato dal progetto rispetto al resto del territorio provinciale: paesi, Comunità montane. Musei, santuari 2. IL PROGETTO 2.1 Descrizione del progetto 2.2 Composizione del partenariato, reti e sinergie: pubblico e privato insieme per il territorio 2.3 Cronoprogramma 2.4 Quadri economici 1 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Sezione 1 Caratteristiche del territorio di riferimento Provincia di Biella Abitanti al 31.12.2009 n. 186.698 Montagna 41% collina 43% pianura 16% 2 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI 3 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI A.1 Inquadramento geografico generale del Biellese Rilievi montagnosi sistemi vallivi : con i rilievi del monte Mars ad ovest (2600 m) e del monte Barone a nord-est (2044 m), l'arco montano racchiude a nord-ovest il territorio della provincia, presentando valori paesaggistici significativi e importanti valori di naturalità. Al limite settentrionale, l'alta Valle Sessera presenta la più ampia estensione di aree naturali e semi-naturali di tutta la provincia, con particolari caratterizzazioni vegetazionali per l'estensione del bosco e le varietà botaniche e faunistiche. Articolati a ventaglio attorno alla città di Biella e, più ad oriente, lungo l'asse pedemontano, i sistemi vallivi del biellese si caratterizzano per l'elevato livello di insediamento secondo modelli assai articolati. -

Escursione Lungo Il Torrente Cervo: Fossili E Ambienti Del Biellese Da 4 Milioni Di Anni Fa Ad Oggi
Escursione lungo il Torrente Cervo: fossili e ambienti del Biellese da 4 milioni di anni fa ad oggi a cura di Edoardo MARTINETTO , Cristina FESTA Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino, Associazione Culturale Verde Antico L’alveo del Torrente Cervo è uno dei siti piemontesi in cui sono meglio visibili i sedimenti che si sono deposti da 4 a 2 milioni di anni fa, in un’epoca detta Pliocene. Ogni anno l’azione erosiva delle acque mette in evidenza nuovi corpi rocciosi con il loro prezioso e contenuto fossilifero, molto ricco di informazioni sugli ambienti del passato e sugli organismi che li popolarono. Il sito si presta quindi in modo ottimale per escursioni didattiche e divulgative. 1 CENNI GEOMORFOLOGICI SUL BIELLESE Il Biellese è una zona di interesse sia dal punto di vista geologico-paleontologico, che da quello paesaggistico-naturalistico. È la particolare morfologia che delinea il paesaggio a mettere in risalto tali peculiarità e caratteristiche. Il territorio si estende su di una superficie di circa 910 km² e presenta un’orografia molto variabile in quanto contraddistinto da una elevata escursione altimetrica (dai 171 m nel comune di Gifflenga ai 2.600 m del monte Mars). Per questo motivo, vi è una netta contrapposizione tra la montagna e la pianura, ma anche i rilievi collinari e il settore urbano pedemontano danno il loro contributo nel determinare la configurazione della superficie. Schema geomormorfologico del Biellese. Dal punto di vista geologico, una buona parte del tratto biellese è attraversato e diviso in due zone geologiche da un’importante faglia: la Linea del Canavese . -

Francescon Marco
Curriculum Vitae Francescon Marco INFORMAZIONI PERSONALI Francescon Marco Via per Castelletto Cervo 345 - 13836 Cossato (BI) 347.2296846 [email protected] [email protected] Linkedin www.linkedin.com/in/marco-francescon-ingbi Sesso Maschile | Data di nascita 24/08/1976 | Nazionalità Italiana TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Civile (ordinamento previgente DM 509/99) ESPERIENZA PROFESSIONALE da aprile 2003 Ingegnere civile – libero professionista (da aprile 2004) ad oggi Via per Castelletto Cervo 345 - 13836 Cossato (BI) ▪ Titolare Attività o settore Professione Tecnica per committenza pubblica e privata nei seguenti campi: - Edilizia (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza) - Impianti elettrici (progettazione, direzione lavori, contabilità) - Impianti termici (progettazione, direzione lavori, contabilità) - Risparmio Energetico (diagnosi, certificazioni energetiche) - Antincendio (progettazione) - Idraulica (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza) - Viabilità (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza) - Urbanistica (S.U.G., S.U.E. sia di iniziativa pubblica che privata) - Consulenze varie Referenze Enti Pubblici: - A.S.L. BI - A.S.L. VC - A.T.C. Piemonte Nord - Comune di Biella - Comune di Cerrione - Comune di Cossato - Comune di Pettinengo - Comune di Sordevolo - Comune di Tollegno - Comune di Valtournenche - Comune di Vigliano Biellese - CORDAR Biella Servizi CORDAR S.p.A Biella Servizi prot. n. 0002971 del 02-09-2020 - Provincia di Biella da gennaio 2014 Organizzatore e docente di corsi di aggiornamento professionale per ingegneri ed al 2018 architetti presso A.I.A.B. – Associazione degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Biella Via Novara 1 – 13900 Biella (BI) ▪ Incarichi a progetto nell’ambito della attività varie di libera professione o a titolo gratuito Attività o settore Organizzazione e docenza da settembre 2014 Docente di Topografia presso I.I.S. -

Comune Di Lessona (Provincia Di Biella) Avviso Di Emissione Di Bando Di Concorso Generale N
REGIONE PIEMONTE BU20 20/05/2021 Comune di Lessona (Provincia di Biella) Avviso di emissione di bando di concorso generale n. 4 per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Lessona. Si rende noto che ai sensi della L.R. 17/02/2010 n. 3 e s.m.i. con la determina del Responsabile dei Servizi Rivolti alle Persone n. 35 del 11.05.2021 è stato approvato il bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nel Comune di Lessona (BI) ai cittadini residenti nei Comuni di Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerrione, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia, o siano iscritti all'AIRE. Il Comune di Lessona (BI) si riserva l'assegnazione di alloggi alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco; Il suddetto bando di concorso sara' pubblicato dal 20 maggio 2021 al 19luglio 2021 e le domande di partecipazione, compilate su moduli appositi, in distribuzione presso il Comune di Lessona e nei Comuni dell'Ambito Territoriale di appartenenza sopra elencati, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 19 luglio 2021mentre per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. -

Periodico Di Informazione Del Comune Di Castelletto Cervo
‘L‘L GARABIUNGARABIUN PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTELLETTO CERVO Anno II Numero 4 Autorizzazione Tribunale di Biella n.573/2011 Dicembre 2013 Direttore Responsabile Filippo Senatore Direttore Editoriale Comune di Castelletto Cervo - Via XXV Aprile - Tel 0161 859116 Sommario Alfredo Frassati 2 Lettera del Sindaco 3 Ordinanza Sindacale 3 urgente per taglio rami ed alberi interferenti con la linea ferroviaria Interruzione della cor- 4 rente elettrica Nuova illuminazione e 4 gli altri lavori in corso Contro la crisi il Comu- 5 ne promuove l’iniziativa “acquistiamo insieme” Il taglio delle piante e 5 quelle lettere poco comprese L’Unione dei Comuni 6 “tra Baraggia e Brama- terra” Mostra dei pittori biel- 7 lesi in occasione della di Filippo Senatore “Fera del Garabiun” ALFREDO FRASSATI Gli alunni della Prima- 8 ria di Castelletto Cervo Il 1° settembre 1959 la F.u.c.i. tenne il suo congresso a Torino. L’arcivescovo di Mila- raccontano i primi me- no Giovanni Battista Montini (futuro papa Paolo VI) nel suo discorso vibrante citò le si di scuola virtù eroiche dello studente Pier Giorgio morto nel luglio del ’25. Poi si recò in visita “Un grande uomo è 9 colui che non perde il privata dal padre anziano Alfredo. Un abbraccio fraterno tra un laico e un religioso. suo cuore di bambino” Chi era questo distinto signore piemontese? Alfredo Frassati era nato a Pollone presso La Storia del cinema 10 Biella il 28 settembre 1868. Nel 1890 si laureò in legge a Torino. Nel 1897 conseguì la Capitolo 1 - Il cinema delle origini libera docenza in diritto e procedura penale a Sassari. -

Episodio Di Cimitero Di San Vincenzo, Mottalciata, 17.05.1944 I.STORIA
Episodio di cimitero di San Vincenzo, Mottalciata, 17.05.1944 Compilatori: Enrico Pagano e Maurizio Regis I.STORIA Località Comune Provincia Regione cimitero di San Vincenzo Mottalciata Vercelli (ora Biella) Piemonte Data iniziale: 17/5/44 Data finale: 17/5/44 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 20 20 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari inermi Sbandati 20 Prigionieri di Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani guerra Elenco dei nomi 1. Aglietti Aldo, dI Costantino, nato a Cossato (BI) il 17.09.1925, residente a Cossato (BI), nome di battaglia “Terribile”, fucilato a Mottalciata, cimitero di san Vincenzo, il 17.05.1944, h.13.30, distaccamento “Bandiera” poi V divisione Garibaldi 2a brigata “Pensiero”; 2. Belli Luciano, di Ottavio, nato ad Andorno Micca (BI) il 2.2.1925, residente a Andorno Micca (BI), nome di battaglia “Audace”; fucilato a Mottalciata, cimitero di san Vincenzo, il 17.05.1944, h.13.30, V divisione Garibaldi 2a brigata “Pensiero”; 3. Bertotti Rambaldo, di Ottavio e Maria Zarino, nato a Vercelli (VC) il 18.12.1924, residente a Biella (BI), nome di battaglia “Pse-Pse”; fucilato a Mottalciata, cimitero di san Vincenzo, il 17.05.1944, h.13.30; V divisione Garibaldi 2a brigata “Pensiero”; 4. Bianchetto Eraldo, di Lorenzo e Giustina Mino, nato a Lessona (BI) l’8.8.1922, residente a Lessona (BI), nome di battaglia “Falco”, fucilato a Mottalciata, cimitero di san Vincenzo, il 17.05.1944, h. -
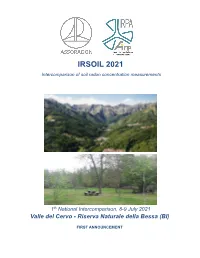
IRSOIL 2021 Intercomparison of Soil Radon Concentration Measurements
IRSOIL 2021 Intercomparison of soil radon concentration measurements 1th National Intercomparison, 8-9 July 2021 Valle del Cervo - Riserva Naturale della Bessa (BI) FIRST ANNOUNCEMENT INTRODUCTION Soil radon measurements, born as a practice closely linked to research and scientific curiosity, has managed, over the years, to carve out a more technical role, assuming relevance for its practical implications: measurement can be a useful tool for the classification of radon risk areas. In Italy, Legislative Decree n. 101/2020, transposition of 59/Euratom/2013, has undoubtedly sparked new interest on this subject. Soil radon measurements involves both radiation protection field and geophysical aspects of great interest. For some time now european researchers and freelancers met periodically to test methodologies, techniques and instruments together, thus showing great interest in these evaluations. Assoradon and AIRP therefore believed that the time was ripe to propose, also in Italy, an exercise of field measurements that would allow laboratories, both public and private, to compare their techniques and methodologies. The intercomparison is organized in collaboration with ARPA Piemonte and ARPA Valle d'Aosta The setting for this event is the province of Biella, the smallest province of Piemonte, with its famous “Valle del Cervo” that is probably the place with the highest natural radioactivity in Italy. Results of the intercomparison will be processed in the months following the event: a technical report will be drawn up and published on -

Progettiprogetti Deldel Territorioterritorio
PIANOPIANO NAZIONALENAZIONALE DIDI RIPRESARIPRESA EE RESILIENZARESILIENZA II progettiprogetti deldel territorioterritorio Dossier al 31 marzo 2021 NEXT GENERATION PIEMONTE IL CONTRIBUTO DEL PIEMONTE ALL’ELABORAZIONE E ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR Veniamo da un anno tra i più difficili della nostra storia e anche se l’emergenza sanitaria assorbe la maggior parte delle nostre energie non deve toglierci, però, la capacità di guardare avanti e progettare il nostro futuro. Per il Piemonte è un momento storico. Entro il mese di aprile la Giunta regionale licenzierà una serie di documenti di programmazione strategica che definiranno le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte dei prossimi 10 anni. Decisioni che spesso vengono prese all’interno dei palazzi, ma che noi vogliamo costruire insieme al territorio, raccogliendo il contributo di tutti, inclusi i nostri giovani, che sono i veri proprietari del futuro. L’esperienza a Bruxelles mi ha insegnato che occorre contribuire a indirizzare le risorse economiche, affinché possano rispondere alle reali esigenze del nostro tessuto economico e sociale. E oggi abbiamo a disposizione cifre che, probabilmente, non vedremo mai più. Saremo competitivi se sapremo individuare e condividere progetti con immediate ricadute sui territori e se sapremo “fare squadra” a livello nazionale. Questo documento è il nostro contributo all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E siamo orgogliosi di dire che è il contributo del Piemonte, non della Regione Piemonte. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte DA “RIPARTI PIEMONTE” A “NEXT GENERATION PIEMONTE” Quando, nei primi mesi del 2020, l’epidemia da Sars Con questo stesso approccio abbiamo letto l’opportunità, per il Covid2 ha iniziato a colpire la popolazione e l’economia nostro territorio offerta da Next Generation EU e dagli piemontese e italiana, la nostra regione già stava soffrendo strumenti che in tale quadro sono stati prefigurati dall’Unione una grave crisi, legata ai profondi cambiamenti di scenario Europea.