Parodiae Libertas. Sondaggi Sulla Parodia Italiana Del Cinquecento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
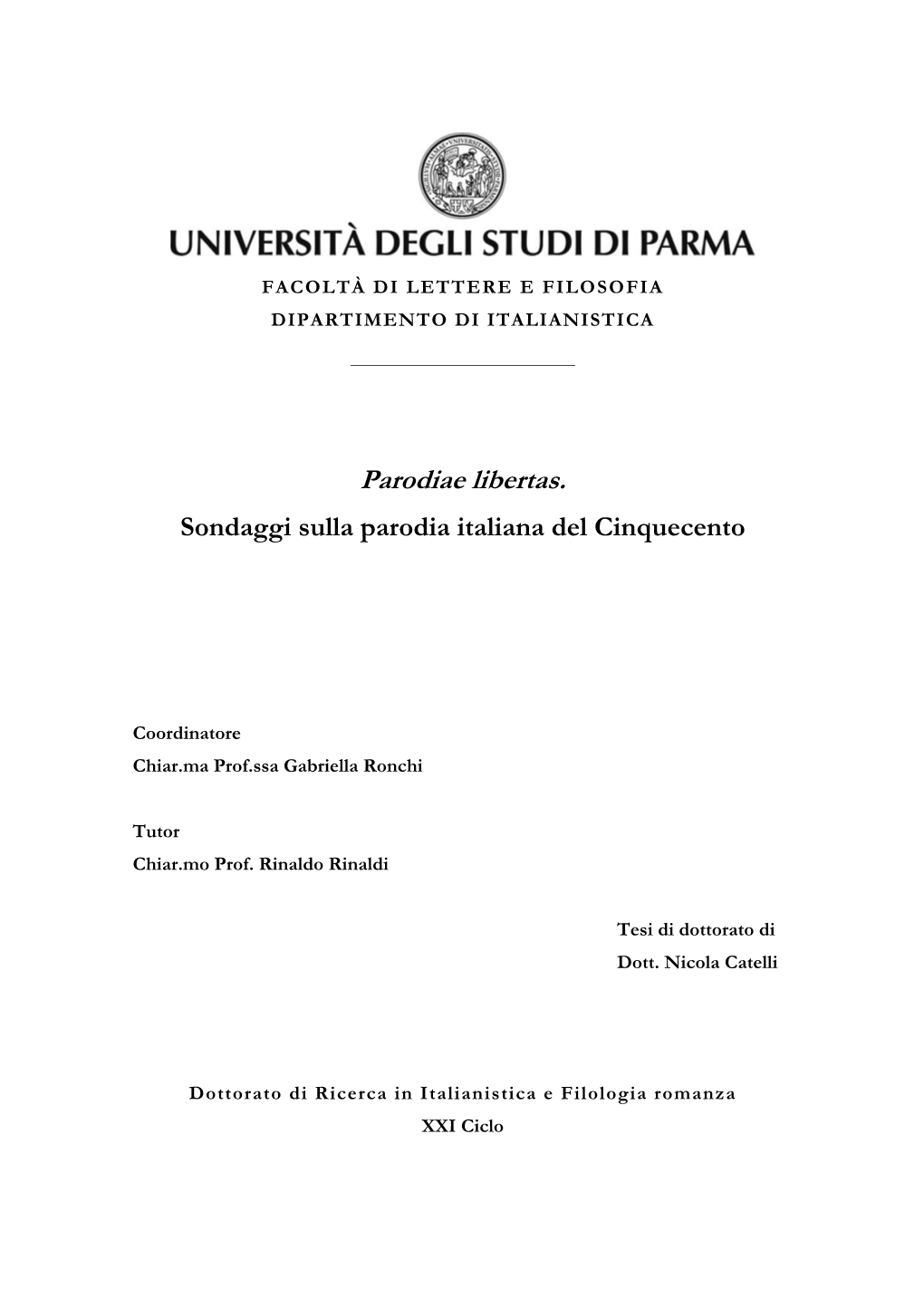
Load more
Recommended publications
-

00-Pag. Iniziali.Pmd
TRADURRE DIRITTO 171 Maria Alessandra Panzanelli Fratoni Notizie sulla formazione culturale di Girolamo Tezi Ragionando dei libri che egli ebbe in prestito da Prospero Podiani e delle origini della Biblioteca Augusta di Perugia 1. Premessa Adi 7 di maggio 1596 Ricordo come imprestai al s.or Girolamo Tetii Poemata in laudem Beatissime V. M. in 4 manuscripta 1 e, dopo le composizioni in onore della Vergine, che una manicula interveniva a segnalare particolarmente, forse appunto perché si trat- tava di un manoscritto, il prestatore e annotatore elencava una serie di opere a stampa. A redigere quell’appunto era Prospero Podiani, il bibliofilo peru- gino noto soprattutto per l’importante raccolta libraria da cui ebbe origine la Biblioteca Augusta di Perugia; vicenda che, come racconta in questa stessa sede Erminia Irace, coinvolse Girolamo Tezi in pri- ma persona e giunse a perfezione intorno all’anno 1623. A quei primi libri prestati da Podiani a Tezi, altri fecero seguito, registrati in tempi e modalità differenti, per un totale di duecento edizioni (si tratta infatti sempre di libri a stampa, meno il primissi- mo, col quale abbiamo esordito). Una quantità importante, una pic- cola biblioteca, che possiamo presumere venisse utilizzata davvero; a differenza di una raccolta personale, infatti, trattandosi del prestito di libri di proprietà altrui, la probabilità che essi venissero effettiva- mente letti aumenta considerevolmente. D’altra parte, la recente edi- zione delle Aedes ha fatto sorgere un’attenzione per il Girolamo Tezi autore che rende assai più interessante approfondire l’argomento delle sue letture: nel consistente prestito librario da lui richiesto e 1 BAP, ms. -

Irodalomtörténeti Közlemények
•V'i-a/,^ v * s- Irodalomtörténeti Közlemények A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Tarnai Andor: A neolatin költészet és dráma alkonya Európában Knapp Éva: Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio- versében Fejér Ádám: Horváth János és a korszerű Petőfi-kép Nyilasy Bt.'ázs: Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról Heltai János: Balassi és Buchanan lephtese Bartók István: Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija Janzer Frig] es: József Attila és a romantika Műhely: Babits-tanulmányok * Petrőczi Éva: Egy fordítás háttértörténete (Lewis Bayly: The Practice of Piety - Medgyesi Pál: Praxis pietatis) Pilo Boyl, Cecilia: Caesar Aegyptus földén Alexandriában (Olasz jezsuita iskoladráma Faludi Ferenc átdolgozásában) Szabó Gábor: Egy fiktív személy (feltüntetése (Orbán János Dénes versei) Adattár Józ^f Attila Tudományegyetem MegyarU [ *«*»** Szemle ÍT3U S«c^fiU Bsy«*«*" u° ** IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1997. CL évfolyam 5-6. szám Tarnai Andor: A neolatin költészet és dráma alkonya Európában 457 SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Knapp Éva: Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio-versében 470 Komlovszki Tibor Fejér Ádám: Horváth János és a korszerű Petőfi-kép 508 Nyilasy Balázs: Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról 527 technikai szerkesztő Kisebb közlemények (1954-1962) Heltai János: Balassi és Buchanan Iephtese 541 a szerkesztőség titkára Bartók István: Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija 550 Janzer Frigyes: József Attila és a romantika 557 (1963-1970) -

Defective Tales: the Story of Three Myths
Defective Tales: The Story of Three Myths DO WOMEN HAVE SOULS? The Story of Three Myths BY Michael Nolan University College Dublin The ChurchinHistory Information Centre www.churchinhistory.org Defective Tales The Story of Three Myths I "The Council of Macon held that Woman does not have a soul" II "Aquinas said that a Female is a defective Male" III "Aristotle said a Female is a deformed Male" Michael Nolan Reprinted (with revisions) from New Blackfriars with the kind permission of the Editor 1 The Mysterious Affair at Mâcon The Bishops and The Souls of Women Michael Nolan University College Dublin Abstract The story that the Council of Macon decreed that women do not have a soul is untrue. This article traces the growth of the myth. The decree of the Council of Macon (585 AD) that women do not have a soul, has the honoured place in liberal demonology given to historical events that never happened. It is a tale to treasure. As the eponymous wine is sipped at elegant tables, the misguided deeds of bishops can be recalled, and the only regret must be that no Synod of Brie or Council of Camembert offers occasion for further mirth. On these occasions facts become such skimble- skamble stuff as puts men from their dreams. For the Council, of course, decreed no such thing, if only for the persuasive reason that some of the bishops may themselves have been married. [1] The penalties applied to a bishop who decrees that his wife does not have a soul are not recorded in canon law, presumably as surpassing male imagination. -

Print Version
Deutsche Biographie – Onlinefassung NDB-Artikel Acidalius, Valens Humanist, Philologe und neulateinischer Dichter, * 25.5.1567 Wittstock (Brandenburg), † 25.5.1595 Neisse. (evangelisch, dann wahrscheinlich katholisch) Genealogie V Heinrich Acidalius (eigentlich Haveken- oder Hauckenthal), († vor 1580), Rektor und Superintendent in Wittstock; 4 B u. a. →Christian Acidalius (1576–1631), Mediziner, Professor in Altdorf. Leben A. studierte in Rostock, Greifswald und Helmstedt (bei →J. Caselius), ferner seit 1590 in Bologna Medizin und lateinische Philologie. Schon 1590 erschien in Padua seine erste Arbeit, eine Velleius-Ausgabe. Mittellos, krank und ohne Neigung zum ärztlichen Beruf kehrte er 1593 als Doktor der Medizin und der Philosophie aus Italien zurück und zog zuerst zu seinem Studienfreund D. Bucretius (Rindfleisch) nach Breslau, dann 1595, auf den Ruf des fürstbischöflichen Kanzlers J. M. Wacker von Wackenfels nach Neisse. Trotz seiner angegriffenen Gesundheit war er in diesen Jahren mit eifrigen Studien an Apuleius, Plautus und anderen Autoren beschäftigt. In Neisse, vielleicht schon in Breslau, scheint er zum Katholizismus übergetreten zu sein, wenigstens wurde er 1595 nach katholischem Ritus beerdigt. Vielleicht im Zusammenhang mit dieser Konversion erhielt er wahrscheinlich das Rektorat der Schule in Neisse, doch hat er dieses Amt offenbar nie ausgeübt. Seine letzten Lebensmonate waren durch die heftigen Angriffe verdüstert, denen er als angeblicher Verfasser einer antisozinianischen, scherzhaften, aber als solcher verkannten Flugschrift (mulieres homines non esse) ausgesetzt war. Von seinen zahlreichen kritischen Arbeiten zu lateinischen Autoren sind nur die „Animadversiones in Curtium“ zu seinen Lebzeiten erschienen. Seine besten Studien, vor allem zu Plautus und Tacitus, wurden später von seinem Bruder Christian herausgegeben. A. zeigt sich in diesen Arbeiten als hochbegabter, scharfsinniger Textkritiker, was sowohl die Zeitgenossen als auch neuere Gelehrte anerkannt haben (F. -

The Glass Case Antiquarian Books from the 15 Century to 1900 Many
The Glass Case Antiquarian Books from the 15 th century to 1900 Many About Women On-Line Only: Catalogue # 208 Second Life Books Inc. ABAA- ILAB P.O. Box 242, 55 Quarry Road Lanesborough, MA 01237 413-447-8010 fax: 413-499-1540 Email: [email protected] The Glass Case: Antiquarian ON-LINE ONLY : CATALOGUE # 208 Terms : All books are fully guaranteed and returnable within 7 days of receipt. Massachusetts residents please add 5% sales tax. Postage is additional. Libraries will be billed to their requirements. Deferred billing available upon request. We accept MasterCard, Visa and American Express. ALL ITEMS ARE IN VERY GOOD OR BETTER CONDITION , EXCEPT AS NOTED . Orders may be made by mail, email, phone or fax to: Second Life Books, Inc. P. O. Box 242, 55 Quarry Road Lanesborough, MA. 01237 Phone (413) 447-8010 Fax (413) 499-1540 Email:[email protected] Search all our books at our web site: www.secondlifebooks.com or www.ABAA.org . DISPUTING THE "DISPUTATIO" - TWO CONTEMPORARY REFUTATIONS Treatise on the Question Do Women Have Souls 1. (ACIDALIYS, Valens,?). ADMONITIO THEOLOGICA ; facultatis in Academia Witebergensi, ad scholasticam Iuventutem, de Libello famoso & blasphemo recens sparso, suius titulus ets: Disputatio nova contra Mulieres, qua ostenditur, eas homines non esse. Wittenberg: Widow of Mattheus Welack, 1595. First Edition. 4to, (6) leaves, with typographical ornament on the title-page and at the end.VD 16 W- 3700; Universal STC no. 609252. BOUND WITH: [GEDIK, Simon?] RUFUTATIO OPPOSITA … autoris thesibus, quibus humanam naturam foeminei sexus impugnat, in qua praecipuae calumniate huius mendacis spiritus refutantur, quae sit illius ntention ostenditur, et studiosi pietatis omnesq(ue) Christiani monentur, ut sibi caveant a tam Diabolico scripto. -

Acidalius on Tacitus* F. R. D. Goodyear Described 1607 As An
1 Acidalius on Tacitus* F. R. D. Goodyear described 1607 as an annus mirabilis for Tacitean studies. Two publications exerted lasting influence on textual scholarship and commentary on Tacitus, and another marked a methodological advance in the appreciation of the manuscript evidence.1 In 1607 appeared at Antwerp the final revision of Justus Lipsius’ edition of Tacitus. In the breadth and depth of its coverage of philological and historical problems Lipsius’ edition would provide a vulgate text and commentary2 until German scholars put both on a new footing in the nineteenth century. In Frankfurt Curtius Pichena published an edition of Tacitus’ works. Pichena, whose services to Tacitus Goodyear ranked second only to Lipsius’,3 has the distinction of being the first editor of Tacitus to recognise that the first and second Medicean manuscripts in the Biblioteca Laurenziana in Florence are important witnesses to the text of the Annals: he was the first editor to use the second Medicean in a printed edition, the first to make both Mediceans one basis of a printed edition.4 It would be more than two hundred years before editors would develop Pichena’s insight and recognise that the Mediceans were not merely a crucial but the unique source of the text of Tacitus’ Annals and Histories and of all the other extant manuscripts of these two works. And in 1607 at Hannover appeared the Notae on * Without the instruction and inspiration that I have received from Michael I should never have developed a serious interest in philology and could never have written this essay on Acidalius for him. -
A Wolfenbütteli Corvinacsoport Rövid Bemutatása
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Disszertáció Zsupán Edina A wolfenbü tteli corvinacsoport Nyelvtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus, egyetemi tanár Ókortudományi Doktori Program A doktori program vezetője: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár A bizottság tagjai: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár (elnök) Dr. Bolonyai Gábor CSc, habilitált egyetemi docens (belső bíráló) Dr. Ács Pál DSc, c. egyetemi tanár (külső bíráló) Dr. Földváry Miklós PhD, habilitált egyetemi adjunktus (titkár) Dr. Bartók István DSc, tudományos tanácsadó (tag) Dr. Ferenczi Attila PhD, habilitált egyetemi docens (póttag) Dr. Mikó Árpád DSc, tudományos tanácsadó (póttag) Témavezető: Dr. Madas Edit CMHAS, egyetemi tanár Budapest, 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ..................................................................................................................................... 4 Köszönetnyilvánítások ..................................................................................................................... 22 I. KUTATÁSTÖRTÉNET ............................................................................................................... 24 Wolfenbüttel, a magyarok zarándokhelye .................................................................................... 29 II. A WOLFENBÜTTELI CORVINACSOPORT RÖVID BEMUTATÁSA ................................. 31 III. KATALÓGUS .......................................................................................................................... -

Giordano Bruno : His Life, Thought, and Martyrdom
GIORDANO BRUNO BY THE SAME AUTHOR A HISTORY OF THE ITALIAN REPUBLICS IN THE MIDDLE AGES. By J. C. L. SISMONDI. Translated, supple mented and edited, with a Memoir of the Author, by Dr. WILLIAM BOULTING. Demy 8vo, buckram, 5J-. net. GIORDANO BRUN HIS LIFE, THOUGHT, AND MARTYRDOM BY WILLIAM BOULTING " AUTHOR OF TASSO AND HIS TIMES" SYLVIUS," ETC. " To love Truth for Truth s sake is the principal part of human perfection in this world, and the seed-plot of all other virtues." LOCKE. LONDON KEGAN PAUL, TRENCH, TRtTBNER & CO. L BROADWAY HOUSE, 68-74 CARTER LANE, E.G. 1914 The rights of translation and of reproduction are reserved Printed by BALLANTYNK, HANSON &* Co. at the Ballantyne Press, Edinburgh PREFACE THE life of Bruno has been written in English more than once, and he has had many excellent commentators. No one can now write about him without availing himself very largely of the solid and scholarly work done by Tocco, Fio- rentino, Berti, Brunnhofer, Mclntyre and others. The apology for the appearance of the present work must be that some facts, unrecorded in England, have come to light of late years, and also that a few usual, almost unavoidable in accuracies require correction. Moreover, I have tried to follow the development of Bruno s thoughts in the order in or I find which he declared them ; and, on one two points, myself compelled to differ from the conclusions of this or the other commentator. Most of Bruno s works have been published in the editions of Wagner, Lagarde, and Gfrorer, well edited for their day. -

The Pennsylvania State University the Graduate School School of Music RECOVERING QUEEN PENELOPE: a CULTURAL and MUSICAL REINTERP
The Pennsylvania State University The Graduate School School of Music RECOVERING QUEEN PENELOPE: A CULTURAL AND MUSICAL REINTERPRETATION OF MONTEVERDI’S IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA A Thesis in Musicology by Kyle Masson © 2014 Kyle Masson Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts May 2014 The thesis of Kyle Masson was reviewed and approved* by the following: Marica Tacconi Professor of Musicology Thesis Advisor Charles Youmans Associate Professor of Musicology Sue Haug Professor of Music Director of the School of Music *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT Claudio Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse in patria (1640) constitutes a unique source for understanding Venetian norms concerning the nature of marriage, love, and the emergence of public opera as a popular form of entertainment in 17th-century Venice. Monteverdi’s first foray into public opera demonstrates the composer’s ability to adapt to shifting expectations from the audience while fulfilling his own personal aesthetic. This study seeks to understand the plurality of meanings embodied in a particular character, Queen Penelope, in an effort to recover period listening practices and receptions of operatic character. In the historiography of Il ritorno studies, Penelope acquires a degree of autonomy more closely correlated to her Homeric counterpart than her textual and musical treatment suggests. Augmented by an investigation of the social conditions and aesthetic shifts of the time, a study of Penelope’s music in its dramatic contexts reveals a systematic objectification of her character. By examining these representations as deliberate actions of the composer, one concludes that the opera focuses more on women as objectified symbols worthy of pity than on chastity, prudence, constancy, or any other such virtues. -

Download File
The Articulation of Difference: Imagining “Women’s Language” between 1650 and the Present Sophie A. Salvo Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2017 © 2017 Sophie A. Salvo All rights reserved Abstract The Articulation of Difference: Imagining “Women’s Language” between 1650 and the Present Sophie A. Salvo This dissertation is an archaeology of so-called Weibersprache. While the concept of feminine language is typically associated with 1970s feminist theory, this study shows that there was a diverse history of conceptualizing “women’s language” prior to this period. I begin with seventeenth-century ethnographic texts that report on a langage des femmes among Island Caribs (by authors such as Jean Baptiste du Tertre, Charles de Rochefort, and Raymond Breton). Shifting genres, I then trace how the idea of a separate women’s language was appropriated by German philology and philosophies of language in the nineteenth century. I show how authors ranging from Wilhelm von Humboldt to Fritz Mauthner reconceptualize Weibersprache to be a universal female phenomenon and present “primitive” women’s languages as evidence for the general alterity of female speech. The second chapter of the dissertation juxtaposes this genealogy of Weibersprache with the nineteenth-century debate over the origin of grammatical gender, and contends that discourses on gendered language constitute an important part of the broader reconfiguration of the sexes during this period. The third chapter moves to literary discourse to show how the notion of women's language fulfills a different discursive function around 1900. -
![[Eventos UCLM | Universidad De Castilla~La Mancha] Final Program](https://docslib.b-cdn.net/cover/7846/eventos-uclm-universidad-de-castilla-la-mancha-final-program-9627846.webp)
[Eventos UCLM | Universidad De Castilla~La Mancha] Final Program
[Eventos UCLM | Universidad de Castilla~La Mancha] Final Program https://exchange.uibk.ac.at/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAA... [Eventos UCLM | Universidad de Castilla~La Mancha] Final Program Eventos UCLM | Universidad de Castilla~La Mancha [[email protected]] Gesendet:Samstag, 14. Juli 2018 02:48 Este correo ha sido enviado automáticamente por el sistema. Para responder escribe al correo [email protected] del organizador del evento o haz clic aquí Comparte el evento Final Program 17th International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies Facultad de Humanidades de Albacete Domingo, 29 de julio - 12:00 h Dear colleague, This letter is being sent to all those who have registered for the Seventeenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). The Program of the Congress will be printed in a few days. We are sending you a draft of it, so that you may check it, particularly what concerns you, and let us know as soon as possible if you found anything wrong. Thank you. We are looking forward to seeing you in Albacete. The Organizing Committee 1 von 114 23.07.2018, 09:50 [Eventos UCLM | Universidad de Castilla~La Mancha] Final Program https://exchange.uibk.ac.at/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAA... XVIITH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NEO-LATIN STUDIES (IANLS) OFFICIAL PROGRAM ALBACETE, 29 JULY – 3 AUGUST 2018 HOMINES ET NATURA: ARTES ET SCIENTIAE IN LITTERIS NEO-LATINIS TRADITAE HUMANITY AND NATURE: ARTS AND SCIENCES IN NEO-LATIN LITERATURE EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA: LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN LA LITERATURA NEOLATINA XVIITH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 von 114 23.07.2018, 09:50 [Eventos UCLM | Universidad de Castilla~La Mancha] Final Program https://exchange.uibk.ac.at/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAA.. -

A Song in Honour of Life a Song in Honour of Life
A song in honour of life A song in honour of life Warsaw 2018 Reviewers: Elwira Buszewicz, Józef Naumowicz Translated: Maria Gaj Proofreading in English: Dominika Uzar Editing and proofreading: Agnieszka Ślusarczyk Typographic design, composition and typesetting: Renata Witkowska Cover design: Lena Olejnikowska On the cover: Lucina, the Roman goddess of light and birth, hands a newborn to Venus, the goddess of love. Scans of old prints with the consent of Ossolineum, scans of contemporary genethliacons thanks to the Science and Culture Foundation in Silesia. © Copyright by Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warsaw 2019 ISBN 978-83-8090-683-9 (electronic version) Academic Publishing UKSW Warsaw ul. Dewajtis 5, 01-815 Warsaw tel. 22 561 89 23 e-mail: [email protected] www.wydawnictwo.uksw.edu.pl Patri Meo Stephano Josepho Kopeć nonagenario dedicatum To my father, Szczepan Józef Kopeć, on his 90th birthday with a special dedication to Wanda Półtawska for her inspirational lectures in Kraków Table of contents List of abbreviations used in the text 9 Introduction. Birth of the world and man. Birthday poetry 11 Chapter I. Phenomenon of the birth of man in the cultures of the world 21 Chapter II. Genethliacon – birth and development of the genre 33 Chapter III. Carmen natale – Latin birthday song 45 Chapter IV. Christian celebration of birth for heaven 99 Chapter V. Genethliacon in the culture of medieval and humanistic Europe 123 Chapter VI. Genethliacons in Poland and Silesia 139 Conclusion. Genethliacon in the formal-compositional aspect. Place of birthday songs in the culture of Europe 163 Bibliography 173 Index of real people appearing in the main text 187 Aneks 191 Summary 198 List of abbreviations used in the text Anth.